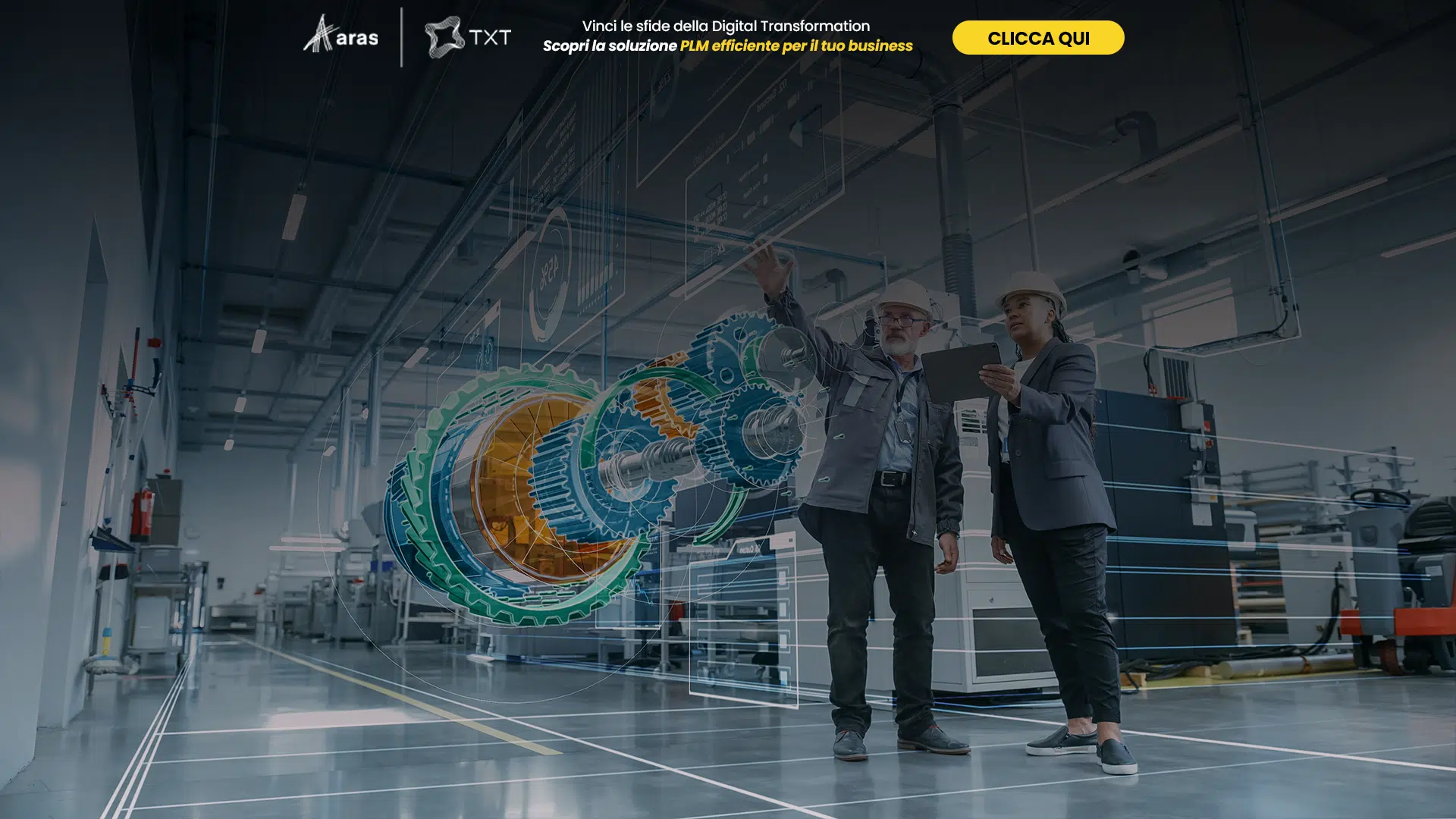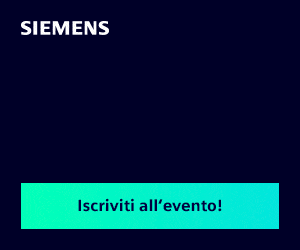di Marco de‘ Francesco ♦ Non solo Alitalia, Alcoa, Almaviva, Ilva: sono 162 i tavoli di crisi aziendali al Mise, e sono solo la punta dell’ iceberg. Come saranno affrontate dal nuovo governo, e con che strumenti ? Quale il ruolo dello Stato? Tra nostalgie per l’ Iri e paletti europei, ecco lo stato dell’arte e le considerazioni di due economisti: Maurizio Castro e Riccardo Gallo
Due le emergenze in tema di crisi aziendali. Anzitutto, la riforma delle discipline del fallimento e dell’insolvenza. I naufragi delle imprese vanno “anticipati” risolvendo i problemi prima del peggioramento della situazione. Un Ddl, indirizzato a tal fine, era stato approvato dal Senato nell’ottobre del 2017, e delegava il governo a mettere mano in materia; ma ora l’esecutivo Gentiloni non è più in carica. Poi, un fondo contro le delocalizzazioni, con il ritorno del ruolo centrale dello Stato nello sviluppo dell’industria. Finalità: creare aziende più grandi, in grado di competere nel mercato globale. Anche qui, il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda aveva annunciato iniziative in questa direzione, prima della caduta del governo.
E’ un dato di fatto che sono ben 162 i tavoli di crisi aziendale aperti al Mise; attualmente, c’è in gioco il lavoro che dà da vivere a 180 mila persone. Un panorama che non è destinato a cambiare in tempi brevi. Certo, è finita la crisi massiva, epidemica, ma resta quella selettiva ed endemica, che alligna nel vasto bacino di aziende stremate da un decennio di congiuntura sfavorevole. Quindi non solo Alitalia, Almaviva, Alcoa, Ilva: la crisi pesca nel 60% delle imprese, quelle “galleggianti”, e nel 20%, quelle “spiaggiate”. Ne abbiamo parlato, per una prima analisi sull’argomento, con il docente di economia dell’industria di processo alla Sapienza Riccardo Gallo e con l’ex senior executive vice-president del settore componenti a livello mondo di Electrolux nonché ex direttore scientifico del Master della Business school Cuoa Maurizio Castro.
Il ddl fallimenti, una sorte segnata
Nell’ottobre 2017 l’aula della Senato ha dato il via libera al ddl fallimenti, e cioè una delega al governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Una legge importante, perché consente di “prevenire” il naufragio dell’azienda. Ma i tempi per l’attuazione sono stretti, e l’atto non sembra rientrare nelle priorità politiche delle forze che potrebbero formare un governo. Secondo Castro «quanto alle soluzioni, il DDl sui fallimenti riguarda giusto le situazioni di precarietà. Prevede una fase preventiva di allerta per anticipare l’emersione delle crisi di impresa. Ciò consente una rapida risoluzione dei problemi prima del peggioramento della situazione. L’allerta è attivabile dal debitore o d’ufficio dal tribunale su segnalazione (obbligatoria per fisco e Inps) dei creditori pubblici». Va ricordato che in caso di procedura su base volontaria, il debitore è assistito da un apposito organismo di composizione della crisi istituito presso le Camere di commercio e ha 6 mesi di tempo per raggiungere una soluzione concordata con i creditori. Se invece la procedura è d’ufficio, il giudice convoca il debitore in via confidenziale e affida il compito di risolvere la crisi ad un esperto. Peraltro l’imprenditore in difficoltà è motivato ad attivare l’allerta: gode di misure premiali.
«Il fatto – continua Castro – è che il DDl Fallimenti è stato approvato a ottobre del 2017; con l’approvazione della legge delega il governo avrà tempo un anno per emanare la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell’insolvenza. Ma nel frattempo il governo è caduto, e attualmente il Paese ne è privo». Và detto che nella recente competizione politica nazionale la questione non sembrava rientrare nelle priorità di gran parte delle forze politiche: e questo potrebbe risultare di grande detrimento. «Invece è una legge di grandissimo rilievo, appunto perché si tratta di agire anticipando la crisi di questa o quella azienda».
C’è bisogno di istituzionalizzare i paracadute per le aziende in difficoltà, perché la trasformazione digitale approfondisce il divario tra le imprese che funzionano e quelle al palo. Secondo Castro «oggi nessuno si aspetta che il Piano Calenda, che nel complesso si è rivelata una strategia positiva, non produca anche morti e feriti. Voglio essere ottimista, e affermare che quel 20% di aziende che stanno avanzando con forza nella strada della digitalizzazione e in quella dell’internazionalizzazione, possa espandersi e diventare il 30%, o anche il 40%. Ma tutte quelle imprese che sono schiacciate sotto la linea di galleggiamento vanno dotate di bombole, di muta e di pinne, altrimenti per molte di loro saranno guai. Per un lungo periodo, bisogna attendersi una serie di lesioni occupazionali. Una nuova normativa sui fallimenti avrebbe potuto aiutare a superare i guai. C’è bisogno di un solido sistema di tutela».

Ci vogliono aziende di grandi dimensioni, in grado di dominare i mercati: come l’ Iri?
Ma per dare vita a grandi imprese, occorrono adeguati sistemi di finanziamento statale. Un ruolo che un tempo era svolto dall’Iri. È immaginabile una versione attualizzata dell’Iri? Si considerino i 500 Champion del Corriere della Sera, «la spina dorsale del Paese». Sono quelle Pmi che hanno riscosso «una crescita negli ultimi sei anni di almeno il 7% annuo, ricchi profitti, bassi tassi di rischio, alta liquidità. E investimenti: in ricerca, tecnologia, risorse umane». Per Castro «si tratta per lo più aziende incapaci di inserirsi nella vera competizione industriale, a livello globale. Sono tutte piccole, e aspirano a diventare medio-piccole. Ambiscono a passare da 100 a 200 milioni di fatturato all’anno.e non ci sono unicorni tra di loro. Eppure, ci sono settori dove saremmo ancora in tempo per creare aziende di dimensioni adeguate, come nell’abbigliamento». Come fare?«Io sogno, e non scherzo, – dice Castro – un nuovo Iri: pensate a quante grandi imprese sono nate grazie alle partecipazioni statali». Storicamente l’Iri (istituto per la ricostruzione industriale) fu istituito nel 1933, durante il fascismo. Nel dopoguerra allargò progressivamente i suoi settori di intervento e divenne il fulcro dell’intervento pubblico nell’economia italiana. Agli inizi degli anni Ottanta era un gruppo di circa mille società con più di 500mila dipendenti. Nel 1982 il governo affidò la presidenza a Romano Prodi, che cedette 29 aziende del gruppo, tra cui l’Alfa Romeo. È stata a suo tempo una delle più grandi aziende non petrolifere al di fuori degli Stati Uniti; nel 1992 chiudeva l’anno con 75.912 miliardi di lire di fatturato, ma anche con 5.182 miliardi di perdite.

Ancora nel 1993 l’Iri si trovava al settimo posto nella classifica delle maggiori società del mondo per fatturato, con 67,5 miliardi di dollari di vendite. Trasformato in società per azioni nel 1992, cessò di esistere dieci anni dopo. Vale la pena riportare il giudizio della Corte dei Conti (10 febbraio 2010) sulla stagione delle privatizzazioni: «Si evidenzia una serie di importanti criticità, le quali vanno dall’elevato livello dei costi sostenuti e dal loro incerto monitoraggio, alla scarsa trasparenza connaturata ad alcune delle procedure utilizzate in una serie di operazioni, dalla scarsa chiarezza del quadro della ripartizione delle responsabilità fra amministrazione, contractors ed organismi di consulenza, al non sempre immediato impiego dei proventi nella riduzione del debito».
Per Castro «si tratterebbe di rimettere in piedi un meccanismo che già esiste, in misura limitata: si pensi all’azione della Cassa depositi e prestiti, o alla nazionalizzazione di alcune banche. Ma si tratterebbe di farlo in modo più strutturato. Tuttavia, attualmente non esistono le condizioni politiche di stabilità per fare un ragionamento serio su questo fronte». Va detto che il racconto che è stato fatto negli ultimi 20 anni sulle partecipazioni statali è sempre stato negativo, soprattutto in ambienti politici. «Un classico esempio di narrazione falsificante: un giorno qualcuno scriverà un libro serio sul fenomeno». Secondo Gallo, invece, «la terza gamba dello Stato è un pericolo sempre dietro l’angolo. Se l’Ue ci vieta queste cose, magari ci fa un favore. Nel 2002, con la crisi della Fiat, il segretario della Uil Luigi Angeletti, cercava la sponda del ministro dell’Economia Giulio Tremonti per un intervento dello Stato. Se la Fiat fosse finita in mano allo Stato, probabilmente avrebbe anche chiuso. Invece è rimasta ai privati, e gode di buona salute».

Il fondo contro le delocalizzazioni
Il governo Gentiloni, prima di sciogliersi, aveva annunciato un fondo contro le delocalizzazioni, che avrebbe esaltato il ruolo centrale dello Stato nella difesa e nello sviluppo dell’industria. Industria Italiana si era occupata del caso qui. Castro l’aveva messa così: «Il fondo è un classico, nitido esempio di seria politica industriale nazionale. Si individuano settori di particolare rilievo e si realizzano iniziative per saldare le multinazionali al sistema-Paese. Si va da Whirlpool o da Electrolux e si stringono dei patti. Si cerca di capire di cosa abbiano bisogno e si vede il da farsi. Per esempio: lo Stato co-finanzia la ricerca di prodotto, e la multinazionale si impegna a restare da queste parti». Ma non solo.
Secondo Castro, sarebbe stato uno strumento in grado di rafforzare i “nostri” puntando su nuove dimensioni. Si poteva «per la prima volta, creare quell’integrazione industriale di cui il Paese ha un bisogno strategico, in certi settori. Si pensi alla moda: bisogna dar vita ad un soggetto italiano alla Kering. Come si fa? Si mette attorno al tavolo Armani, Renzo Rosso, Salvatore Ferragamo e altri, e si finanzia l’unione». Per Castro «fare politica industriale significa creare soggetti grossi». D’accordo: ma perché nessuno c’ha pensato prima? «Era impossibile: il centro-sinistra, nell’ansia di una legittimazione privatistica, era ottenebrato dal fanatismo liberista. Quanto alla centro-destra, aveva ben altri problemi». Però in Francia si è fatto e si fa. «La Francia ha sempre fatto una politica industriale molto seria; più in silenzio, anche la Germania». Anche qui, è difficile che qualcuno pensi a breve di riproporre l’idea. Idea che però non piace a tutti e neanche a Gallo: «Il fondo? E con quali coperture? Non si è capito».
L’esperienza personale di Gallo
Risolvere le vertenze industriali è un mestiere che necessita di pazienza e onestà intellettuale. Gallo se ne è occupato nella Prima Repubblica. «Sono stato – ricorda – responsabile dell’ufficio vertenze industriali nel gabinetto del ministero dell’industria. In precedenza, avevo maturato una modesta esperienza in proposito, in quanto dirigente generale della segreteria del Cipe, e il Cipe aveva affrontato crisi nel settore chimico, con piani di risanamento. Al tempo, si trattava di fronteggiare i segretari generali dei sindacati, e avevo capito come fosse difficile non possedere veri strumenti in mano. Mi ero fatto le ossa, come si dice. Dunque ero finito al ministero come capo delle Vertenze; e siccome il ministro del Lavoro aveva capito che con le crisi industriali c’era solo da perderci, nel conto politico riconoscenza-acredine, aveva girato queste questioni al collegio che guidavo. Io ero generoso e propenso a lavorare per l’interesse pubblico e sociale.
Tecnicamente, le vertenze erano delegate al sottosegretario Romeo Ricciuti (politico democristiano della corrente fanfaniana, fu sottosegretario al Ministero dell’industria, commercio e artigianato nel Governo guidato da Giovanni Goria, tra il 1987 e il 1988) che però era più concentrato sul suo collegio elettorale. Così ne seguiva una su cento; io le altre 99. Il mestiere qual è? Bisogna essere intellettualmente onesti, mossi da anelito sociale; e bisogna ascoltare le parti con pazienza. Io sentivo lavoratori e industrie: per metà del tempo sembrava che tifassi per i lavoratori e che colpissi al fianco gli industriali. Ricordo le vertenze Indesit, con Vittorio Merloni, e Brionvega, con Ennio Brion. Gli industriali rimanevano sconcertati. Dopo, misuravo a intuito i margini di manovra, quelli che gli industriali potevano concedere; chiedevo un po’ di più, e alla fine cedevano. Penso che in molti casi sono riuscito ad ottenere il massimo possibile. Si firmava all’alba, quando andava inserito il testo dell’accordo. Che grande differenza rispetto ad oggi: ai miei tempi io ero il responsabile, e non c’era nessun altro, tranne una volontaria abusiva; oggi c’è un ufficio, ben strutturato, di direzione generale del ministero, che ha il quadruplo o il quintuplo delle capacità lavorative dei miei tempi».
La crisi non è più epidemica e massiva, ma è endemica e selettiva
Le potenziali vittime, però, non sono poche, perché il bacino di aziende meramente galleggianti è vasto. Secondo Castro, c’è una differenza rispetto alla situazione attuale: nel 2008 crisi era massiva. «Tutti – afferma Castro – sono stati costretti a riposizionarsi nei proprio mercati di riferimento, e a dar vita a cambiamenti di processo e di prodotto. Poi, c’è chi lo ha fatto bene e chi lo ha fatto male. Chi è in crisi ora, è perché è arrivato stremato alla seconda boa, benché la congiuntura negativa propriamente detta sia terminata. Ora il fenomeno è selettivo. I numeri sono chiarissimi: il contributo dell’export (sul Pil) è di 32 punti, contro i 26 del pre-crisi. Dunque, chi si è ben posizionato nel proprio segmento ed esporta, se la passa bene. Il problema è che questa condizione riguarda il 20% delle aziende, contro il 60% di imprese che galleggiano e contro un altro 20% di società con l’acqua alla gola». Insomma, la crisi non è più epidemica, ma è endemica e più selettiva. «Ci sono delle zone malariche, e quello che risulta sempre di più è che ci saranno per un bel po’. È un panorama che non è destinato a cambiare in tempi rapidi. Aziende mal posizionate, con scarse finanze e management insufficiente saranno per anni parte del paesaggio, appunto perché la maggior parte delle imprese è appena sopra la linea di galleggiamento».
La settorialità della crisi
Confindustria cataloga 24 settori (estrazione, alimentare, tessile, abbigliamento, pelli, legno, carta, prodotti energetici, chimica, gomma e plastica, vetro, materiali da costruzione, apparecchi meccanici ed elettrici, meccanica strumentale, elettronica, elettrotecnica strumentale, strumenti di precisione, autoveicoli, altri mezzi di trasporto, altre industrie manifatturiere, energia elettrica, costruzioni); ma la crisi non ha colpito e non colpisce i settori nella stessa misura. «Quando pensiamo a Indesit o a Whirlpool – afferma Gallo – ci riferiamo al “Bianco”, e cioè a scatole di lamiera smaltate con un temporizzatore dentro; e poi c’è stata la crisi delle auto, che sono scatole di ferro, o di alluminio, con un po’ di elettronica dentro. Spostare questi prodotti significa spostare volumi vuoti, che occupano spazio. Ciò ha un costo.»
«Si tende a produrre nei Paesi dove questi prodotti sono acquistati. Ci sono mercati nuovi, in certe parti del mondo, dove la lavatrice viene acquistata per la prima volta. Ma è evidente che ci sono Paesi dove produrre Bianco non è conveniente. A meno che non si trasformi il Bianco in un prodotto sofisticato. Se non è più una scatola vuota, ma c’è del software e dell’intelligenza artificiale, allora è tutta un’altra vicenda, perché non è più vero che il costo del trasporto incide sul valore di mercato, e quindi puoi produrre in Italia e mandare gli articoli in giro per il mondo. Ma bisogna vedere se sia possibile realizzare, in Italia, l’upgrading tecnologico. Non ne sono convinto». Industria Italiana affronterà, in prossimi articoli, la tematica della crisi settore per settore.
[boxinizio]
Geografia della crisi
Tra le “aree che riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale”, il Mise elenca in particolare: l’area di Val Vibrata – Valle del Tronto – Piceno, tra Abruzzo e Marche; l’area Acerra-Marcianise-Airola, Torre Annunziata-Castellammare, Battipaglia-Solofra, in Campania; l’area industriale di Trieste (riconosciuta nel 2012, in relazione alle tematiche della produzione siderurgica, della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale); Rieti e Frosinone nel Lazio; Savona in Liguria; l’area delle province di Isernia e Campobasso (in Molise) ricomprendente i Comuni di Campochiaro, Bojano e Venafro; l’area di Taranto (Puglia), riconosciuta nel 2012; Porto Torres e Portovesme in Sardegna; Termini Imerese, con la chiusura degli stabilimenti del Gruppo Fiat e Gela (con i siti di Gela, Mazzarino, Vittoria, Caltagirone, Riesi, Caltanissetta e Piazza Armerina, con questioni relative a Eni e Syndial) in Sicilia; Piombino e Livorno in Toscana; Terni e Narni in Umbria; Porto Marghera in Veneto.
I numeri della crisi
Con l’acqua alla gola gli elettrodomestici e la siderurgia, in chiusura i call center ma in ripresa l’automotive. Sono 162 i tavoli di crisi aziendale aperti presso il ministero dello Sviluppo economico, in gioco il lavoro per 180 mila persone. Secondo la Rassegna Sindacale «nel 2012 i tavoli aperti erano 119, mentre i posti di lavoro a rischio 118 mila. La media 2012-2017 è di 146 tavoli aperti per 143 mila dipendenti interessati. Nell’ultimo biennio i lavoratori coinvolti sono 25 mila in più, dal 2012 ben 62 mila in più». Sempre secondo la stessa fonte, «nel biennio 2016-2017 il ministero conta 62 vertenze concluse positivamente, 45 casi di successo di siti totalmente o parzialmente dismessi che vedono interventi di nuovi investitori, 21 casi senza soluzione. Il tasso medio di soluzione positiva sui sei anni è del 58 per cento. Tra le principali dinamiche pesa “una crisi sistemica per gli elettrodomestici”, dal 2016 una “crescita rilevante delle crisi nella siderurgia”, dal 2015 un ingresso nei tavoli di crisi del settore dei call center mentre tendono “a scomparire” le crisi aziendali nel settore dell’automotive. In media le vertenze restano aperte 28-30 mesi (in alcuni casi anche oltre i 60 mesi, come per Alcoa, Lucchini, Termini Imerese, Om Carrelli, Gepin, Ideal Standard). E spesso anche quando si trova una soluzione non è poi efficace: la metà dei casi trattati, infatti, si ripropone al tavolo ministeriale dopo aver risolto le cause».
[boxfine]
Alcuni tra i principali tavoli di crisi aperti
Alitalia
Dal 2 maggio dello scorso anno è in amministrazione controllata, e la situazione tende a peggiorare, con continue perdite di mercato. Il suo destino è incerto: i tedeschi di Lufthansa la rileverebbero, ma solo a seguito di una generale sistemazione da parte dell’Italia; sono in gara con la cordata composta da EasyJet e Air France (che però è di recente entrata in crisi) e l’ungherese Wizz Air. Potrebbe accadere, però, che l’ex compagnia di bandiera rimanesse nella situazione attuale, e cioè in carico alla Cassa depositi e prestiti. Secondo il quotidiano Repubblica «la compagnia ha 200 giorni per salvarsi con 750 milioni di euro in mano. Una somma che sarà necessaria per non accettare l’elemosina di Lufthansa, che si è messa alla finestra evitando di fare un’offerta vera, con l’evidente intento di lasciare in mani italiane il cerino acceso del fallimento o l’onere della ristrutturazione».
Peraltro, in Europa si discute di un prestito di 900 milioni di euro: se valutato come aiuto di Stato, Alitalia sarebbe costretta a restituirlo. E sarebbe, se non la fine, un pasticcio di proporzioni colossali. D’altra parte, il peso della compagnia aerea nel trasporto aereo nei cieli italiani è in continuo calo. Se nel 2011 Alitalia trasportava il 17,5% dei passeggeri, nel 2017 ha lasciato sul campo il 5%. Negli stessi anni Ryanair è passata dal 14,9 al 20,8%, EasyJet dal 7,1 al 9,5%. In realtà la crisi di Alitalia dura da 30 anni, e i singoli passaggi sono difficilmente riassumibili, in un articolo non espressamente dedicato. La società, attualmente guidata da Luigi Gubitosi (2,8 miliardi di fatturato) è già fallita due volte.
Alcoa
A febbraio è stato siglato al Ministero dello Sviluppo Economico l’accordo per la cessione dello stabilimento di Portovesme, in Sardegna, da Invitalia al gruppo svizzero Sider Alloys. Il ministro Carlo Calenda nell’occasione affermò che «non siamo ancora fuori dalla crisi: non è una conclusione ma l’inizio di un processo. Come ho detto ai lavoratori di Alcoa, sarà superata la crisi quando uscirà il primo lingotto di alluminio dalla fabbrica di Portovesme». In realtà la questione sembra risolta, e forse non ci saranno altre riunioni al Mise sul tema. La vicenda era sorta nel marzo 2012, con l’annuncio di Alcoa voler interrompere la produzione ed avviare le attività di identificazione di un nuovo compratore. A novembre 2012 gli impianti erano spenti. Quattro anni dopo, l’accordo tra il Mise, Alcoa e Invitalia per l’interruzione del processo di smantellamento e la ricerca di un potenziale investitore.

Peraltro con l’ultimo consiglio dei ministri del governo Gentiloni sono arrivati i milioni (9 di numero) necessari a prorogare gli ammortizzatori sociali per le zone di crisi industriale. Lo ha annunciato Calenda che lega la decisione alla vertenza Alcoa. Pare che ci fossero ritardi nel processo di reindustrializzazione di Portovesme, e che circa 376 lavoratori rischiassero di rimanere senza reddito. Alcoa Inc. (Aluminum Company of America), è un’azienda statunitense terza nel mondo come produttrice di alluminio, dietro alla canadese Rio Tinto-Alcan e alla Rusal. Dalla sua sede operativa di Pittsburgh, in Pennsylvania, Alcoa gestisce operazioni in 44 paesi. Ha un fatturato di 11,6 miliardi di dollari.
AlmavivA
È un’azienda italiana che opera nella tecnologia dell’informazione e nei servizi di outsourcing (CRM Customer Experience) a livello globale. Il gruppo impiega 42mila persone, 10mila delle quali in Italia e 32mila all’estero. AlmavivA è il quinto gruppo privato italiano per numero di occupati, con un fatturato nel 2017 pari a 772 milioni di euro. La società opera attraverso 39 sedi in Italia e 22 all’estero; il 70% dei clienti è internazionale. A novembre del 2017 sono stati dichiarati illegittimi 153 dei 1.666 licenziamenti effettuati da Almaviva contact (un call center) a fine 2016 sulla sede di Roma. Con cinque ordinanze, Umberto Buonassisi, giudice della sezione lavoro del tribunale capitolino, ha annullato i provvedimenti e condannato la società a reintegrare i dipendenti. Il problema è che per i call center i margini sono in caduta. In Sicilia, la situazione di Almaviva è delicata: l’azienda ha denunciato una stretta sui prezzi da parte dei committenti e la difficoltà a fare fronte alla crisi.

L’Ilva
Nel 2012 sono state depositate presso la Procura della Repubblica di Taranto due perizie, una chimica e l’altra epidemiologica, nell’ambito dell’incidente probatorio che vede indagati Emilio Riva (della famiglia proprietaria), suo figlio Nicola, e altri. Con il nome della originaria azienda fondata nel 1905, l’Ilva è nata sulle ceneri della dismessa Italsider. Il più importante stabilimento italiano è situato a Taranto, e costituisce il maggior complesso industriale per la lavorazione dell’acciaio in Europa. Dopo l’inchiesta avviata nel 2012, originata dalla questione dell’impatto ambientale, lo Stato ha avviato la procedura di commissariamento dell’azienda e avviato una gara internazionale per una riassegnazione della stessa; la Am Investco, cordata formata da ArcelorMittal e Marcegaglia è stata scelta per avviare le trattative di acquisizione. Mittal, però, resta fermo sulla disponibilità iniziale: assumere 10mila dei 14mila totali dell’Ilva lasciando gli altri 4mila in carico all’amministrazione straordinaria. E 10mila erano quelli che Mittal avrebbe dovuto assumere secondo l’accordo con il governo, presentato dal ministro Calenda ai sindacati. Che però hanno interrotto la trattativa: «Testo non condivisibile». La palla passa al prossimo governo.