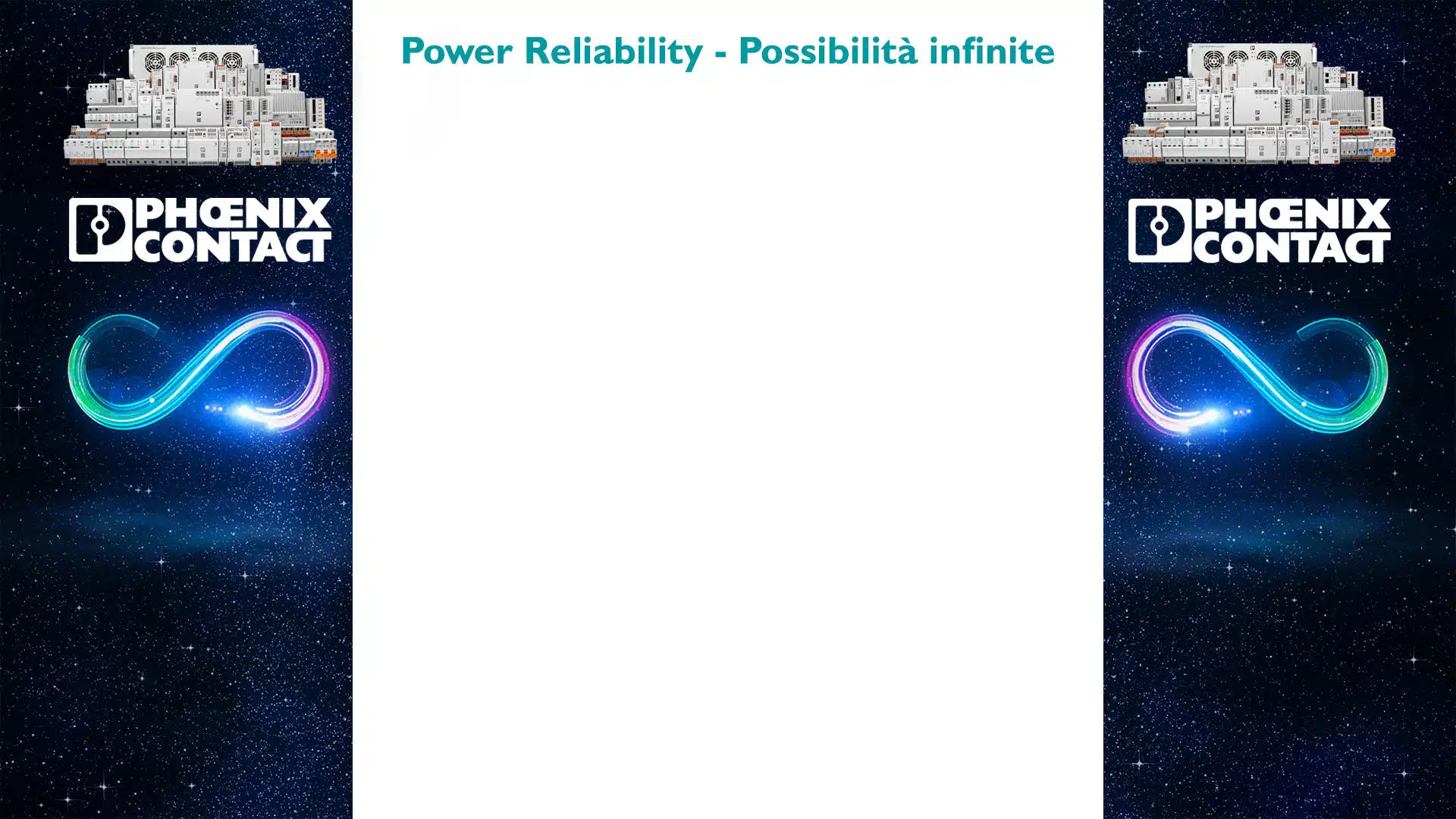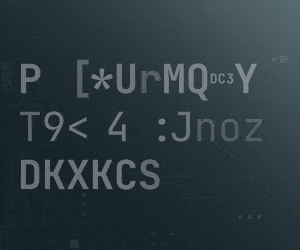di Monica Battistoni ♦ Intervista con Patrizio Bianchi, che parla di petrolio, acciaio e altri temi cruciali. E si sofferma su strategie, innovazione e politica industriale.
I prezzi delle materie prime? Secondari. La formazione? Centrale. L’industria 4.0? Una possibile soluzione a patto (sorpresa) di seguire le orme di Angela Merkel. Patrizio Bianchi, economista industriale fra i più noti in Italia, racconta a Industria Italiana perché ricerca e conoscenza rappresentano il terreno di crescita del Paese e dell’Europa nei prossimi anni. Prendendo esempio anche dalla politica industriale tedesca.
Ma prima di giungere alle conclusioni, Bianchi contestualizza il momento attraversato dall’economia. Per spiegare, per esempio, perché nei prossimi anni le imprese non saranno più così dipendenti dall’oscillazione dei prezzi delle materie prime: la nuova manifattura si baserà sempre di più sulla progettazione dei materiali definiti secondo i bisogni emergenti di una società in trasformazione. «È uno scenario completamente diverso da quello a cui siamo stati abituati. Certo, tutti sappiamo che non esistono più le condizioni che hanno generato il grande sviluppo del dopoguerra, caratterizzato da costi del lavoro, delle materie prime e del denaro stabili, o addirittura calanti, e da una domanda che non aveva bisogno di stimoli», spiega Bianchi. «Quel sistema è stato incrinato progressivamente dalle tensioni sociali, dalla crisi petrolifera del ‘75 con l’impennata del greggio, che ha scatenato l’inflazione e portato alle stelle il costo del lavoro e del denaro e di fatto ha determinato una fase di grande incertezza. Ma, paradossalmente, anche quello è stato un periodo di crescita, perché proprio l’attesa degli aumenti delle materie prime e del costo del denaro e del lavoro stimolava una domanda generata dal timore che i prezzi salissero ancora di più. In pratica, si anticipavano gli acquisti per evitare di spendere di più. E il sistema ha tenuto anche nella fase successiva, quando i Paesi sviluppati hanno iniziato a rallentare, grazie alla domanda dei Brics sostenuta dai prezzi alti delle materie prime che esportavano. Ora che sono scesi, anche in queste nazioni la capacità di spesa è diminuita».

Domanda. Ma in teoria i prezzi delle materie prime bassi, come avviene ora, non sono un vantaggio?
Risposta. Certo, ma quello che manca, ed è un enorme problema a livello mondiale, è la domanda. Anche perché, come sostiene Joseph Stigliz nel suo libro La grande frattura, in questi ultimi 15 anni la percentuale dei super ricchi e quella dei poveri sono cresciute moltissimo. Così se i primi più di tanto non possono consumare, i secondi non hanno le disponibilità acquistare dei beni. In un’ottica puramente macro quindi, il rischio è una deflazione di lungo periodo: da un lato la Bce che continua a immettere denaro a tassi negativi e dall’altro i paesi che devono acquistare i soldi con risorse ricavate dalla vendita delle materie prime. Insomma, è chiaro che siamo in una situazione di stallo, ed è particolarmente delicata perché si tratta di una condizione globale senza alcun soggetto regolatore.
D. E se il prezzo del greggio risalisse?
R. Anche se ci fosse una stabilizzazione dei prezzi, sarà sempre inferiore alle attese. Tutti gli altri Paesi fuori dal gruppo dei Brics, come Turchia, Egitto, Messico, Sud Africa sono in grandi difficoltà, perché avevano puntato la loro espansione su quotazioni di greggio molto elevate. Insomma, se non si rilanciano domanda e capacità di sviluppo, se alla politica di rigore non si affianca un programma di espansione, il rischio è la stagnazione di lungo periodo.
D. Questo è lo scenario macro, invece per quanto riguarda un quadro più focalizzato sull’Italia e l’Europa?
R. Negli ultimi anni c’è stato un enorme lavoro di innovazione nell’estrazione e nella lavorazione del petrolio, nella ricerca di alternative a questa fonte di energia e lo stesso accade con altre materie prime. Attività che hanno prefigurato la terza fase: il futuro della manifattura sarà sempre di più caratterizzato dalla ricerca scientifica, dalla capacità di costruire dei materiali su misura. Già adesso non esiste più solo la semplice trasformazione, ossia la vendita di pezzi assemblati, e non a caso, tra le imprese che godono di buona salute, sono parecchie quelle a un livello tecnologico tale da riuscire a sviluppare prototipi producendo materiali nuovi. Il comparto dei motori per esempio, una filiera che opera per il gruppo Fiat o Volkswagen, è un pezzo tessuto produttivo in espansione legato alla meccanica di precisione e alla digitalizzazione delle produzioni meccaniche. Ci sono anche segmenti come l’industria delle macchine utensili o del packaging, il cui modello di business si basa sulla capacità di fornire risposte a bisogni specifici. Insomma, a incidere nell’andamento di un’azienda non è la materia in sé, ma tutte quelle attività, a latere, di innovazione di processo, che spesso portano anche all’innovazione di prodotto.

D. Quindi anche se le industrie italiane fossero in grado di utilizzare la finanza come strumento di copertura in funzione dell’oscillazione dei prezzi delle materie prime, sarebbe poco rilevante?
R. Un esercizio del genere è ormai complicatissimo. E sebbene il rapporto tra asset finanziari e Pil reale non sia più 1 a 13 come alla fine degli anni ‘90 è ancora sbilanciato e di conseguenza la ciclicità economica non è più legata alla sola produzione, ma esasperata dalle attività speculative. In pratica, diventa molto difficile per l’industria avere dei cuscinetti se la ciclicità esterna finanziaria non li ha. Il vero problema però è un altro: un pezzo di industria gode di ottima salute, ma non è in grado di trainare la crescita del Paese.
D. Perché?
R. Perché il tessuto industriale è diviso in due: da una parte le aziende di medie dimensioni (le grandi sono ormai sparite) con tecnologie molto avanzate che si rivolgono per il 90% direttamente al mercato estero, dall’altra i fornitori di servizi nazionali come Poste ed Enel e le piccole imprese del Centro e del Sud, che operano sul mercato interno a crescita lenta. Anni di unione monetaria senza politica industriale, hanno determinato una concentrazione di industrie in territori avvantaggiati della completa apertura del mercato, penso alle imprese lombarde, venete o emiliane che si sono riposizionate come fornitrici di tecnologie e competenze e che di fatto appartengono più a un sistema industriale centro europeo. Invece, chi beneficiava dei vecchi sistemi di protezione è stato sfavorito dagli accordi di Doha del 2001 in poi. Così le aziende sono giunte a un bivio: o rischiano di saltare o semplicemente diventano un pezzo di un altro sistema industriale con il risultato di emarginare una parte importante del Paese.
D. Ma allora in che modo è possibile fare politica industriale?
R. L’unica politica industriale possibile è tornare a investire sui fattori che offrono un vantaggio competitivo: le persone e le competenze, quelle che una volta si chiamavano skill, dexterity and judgements. Che significa operare agendo sulla leva dell’economia reale piuttosto che su quella dell’economia industriale, cosa che l’Italia sta facendo ma in maniera molto selettiva.

D. Per esempio?
R. Nel Paese abbiamo quattro blocchi di industria, molto interessanti, ma ognuno con un problema. L’industria farmaceutica data per morta, quando venne dismessa Farmitalia-Carlo Erba dalla Montedison (1993), è risorta grazie a imprese molto dinamiche come la Dompé, la Chiesi, la Zambon, la Bracco. Aziende familiari di piccole dimensioni che in questi anni sono riuscite a crescere perché totalmente internazionalizzate e perché, lavorando con le università in Italia e in giro per il mondo, sono riuscite a specializzarsi e diventare un punto di riferimento in alcuni ambiti, per esempio nel trattamento del morbo di Parkinson. Per contro, la chimica di base, finita all’interno del gruppo Eni, è andata perduta poiché sarà venduta Versalis, e lo stesso è successo con la chimica dei catalizzatori ceduta a LyondellBasell: insieme rigeneravano la capacità di innovazione sui materiali polimerici, alla base dei nuovi materiali. Tutto ciò è pericolosissimo, poiché è quasi impossibile avere un’industria avanzata dei materiali se manca quella di base. Un altro rischio è quello legato ai metalli: ci sono imprese straordinarie che li impiegano, dall’alluminio all’acciaio, nel packaging e nella costruzione degli ultraleggeri. Senza l’Ilva e la ricerca di base di lungo periodo garantita dalle grandi imprese, viene meno la filiera nel suo insieme.
E, allora, come faranno le imprese di medie dimensioni, diventate leader di comparto, a perseguire l’innovazione?
R. Nel 2011 il governo tedesco ha lanciato la politica Industrie 4.0: in pratica si tratta di 36 gruppi di lavoro, coordinati in parte dal ministero dell’Industria e in parte dal Ministero dell’Educazione, avviati per ricomporre i settori industriali con il coinvolgimento delle imprese, anche le più piccole e tutta la struttura formativa, compresi gli istituti tecnici. L’obiettivo è organizzare nel minimo dettaglio i nuovi network a supporto dell’industria. Ecco, In Italia si dovrebbe perseguire una politica che favorisca e stimoli attività connesse con start up, attività di ricerca accademica di rilevanza economica, attività utili per lo sviluppo produttivo. Occorrono massicci investimenti nella formazione per realizzare un salto dimensionale nei rapporti imprese e ricerca. E, per fortuna, in alcune regioni questo percorso è già stato avviato.