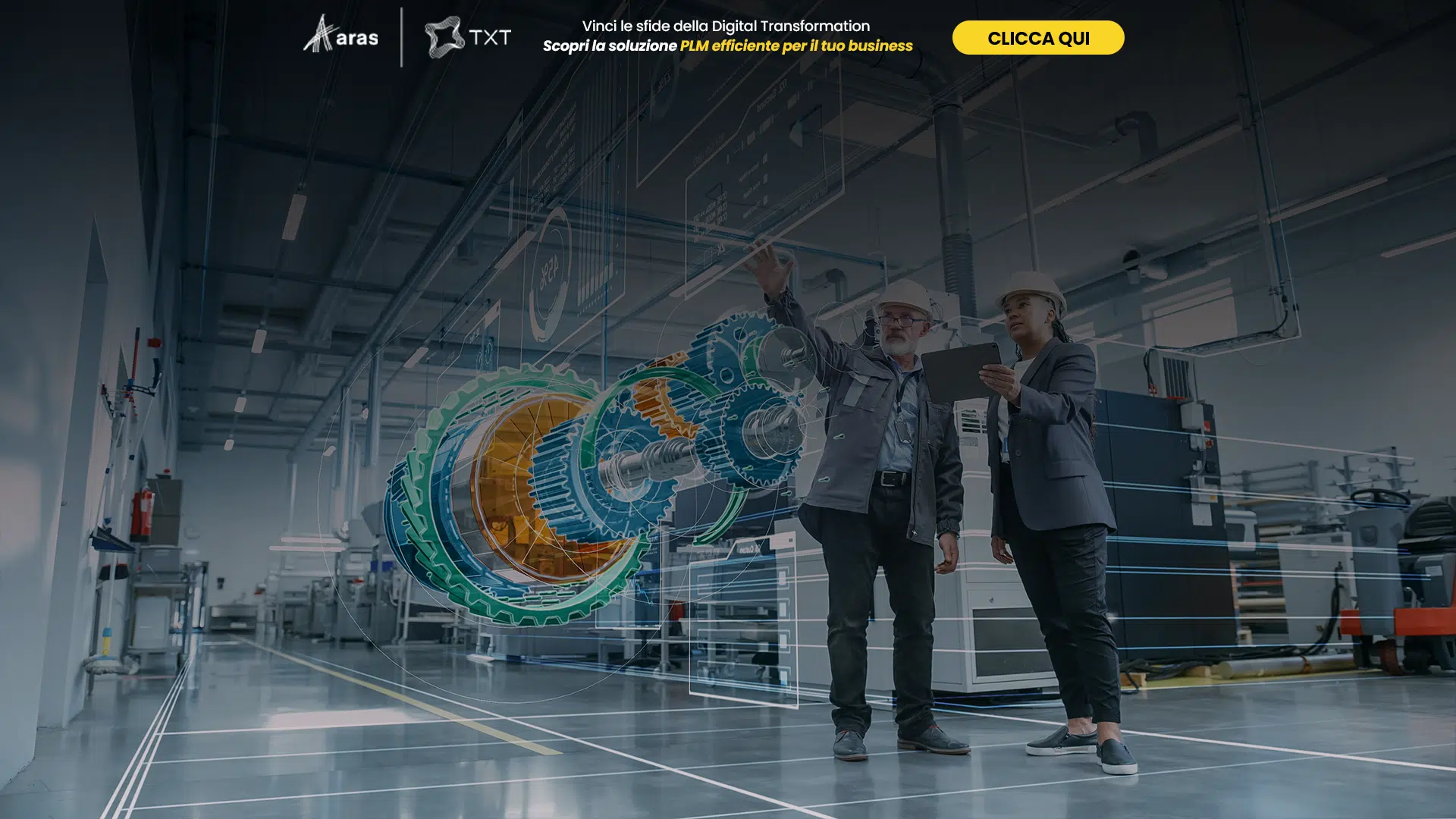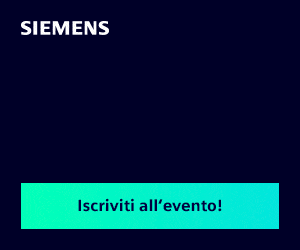di Marco de’ Francesco ♦ Per stare al passo con la digital transformation di Industry 4.0 non basta aggiornare la tecnologia del parco macchine, ma è necessario colmare il gap delle competenze, lacunose anche fra amministratori delegati e direttori generali. Le proposte della multinazionale guidata in Italia da Donato Iacovone
Riuscirà l’Italia a soddisfare la richiesta di skill tecnologici, che nel 2030 farà segnare un + 61% rispetto al giorno d’oggi? Sarà della partita, in fatto di formazione? Con ogni probabilità, no. Perché, come andava affermando due millenni fa il filosofo cinese Lao-Tzu, «la via del fare è l’essere». Ora, quanto all’Essere, il 4.0 ha reso centrali un insieme di competenze, hard e soft, come ad esempio i linguaggi di programmazione e la capacità di risolvere creativamente un problema. Senza questi skill, non si è abbastanza per le aziende, e quindi non si è chiamati a fare. Di qui, il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. L’anello mancante tra posti vacanti e disoccupazione è dunque costituito dalle competenze: la partita della trasformazione digitale si gioca su di loro, ancor più che sulle tecnologie. Le seconde sono disponibili ovunque e a costi contenuti; per sviluppare le prime, invece, occorre tempo – fattore cruciale, in questo passaggio. E la verità è che in fatto di formazione di skill l’Italia non solo è in ritardo, ma arretra.
Ai problemi storici – quelli della didattica superiore disallineata rispetto alle richieste delle aziende e della scarsa collaborazione tra istituzione, enti di ricerca e imprese – se ne aggiungono di nuovi: ogni anno il Paese perde 30mila fra giovani ingegneri, fisici e statistici; mentre importa persone a bassa scolarizzazione. Occorre reagire al più presto, mettendo assieme scuola, industria, enti di ricerca e università. ll problema della carenza di skill è sentito anche a livello Executive: il 70% dei dirigenti e imprenditori è consapevole delle proprie lacune in termini di competenze digitali.
La risposta di EY – network globalizzato di servizi professionali di consulenza direzionale, revisione contabile, fiscalità e altro – è la EY Digital Academy, piattaforma di formazione continua, in lingua italiana, per lo sviluppo di competenze ed esperienze digitali a 360 gradi. Realizzata con partner di sperimentata abilità – come Atos, Cisco, Rockwell Automation e SAS – è diretta alla formazione di manager digitali e alla creazione di una community finalizzata allo scambio di contenuti ed esperienze. Infine, va sottolineato che il ritardo sullo sviluppo degli skill va di pari passo con quello relativo alla trasformazione di prodotti e processi: l’81% delle Pmi del Nord Italia non ha adottato nessuna tra le tecnologie abilitanti 4.0. Sono solo alcune tra gli approfondimenti a margine dell’evento “La rivoluzione digitale della manifattura italiana”, organizzato da EY Manufacturing Lab giorni fa a Milano e partecipato da Donato Iacovone e Enrico Terenzoni di EY.

All’inseguimento delle conoscenze
La partita della trasformazione digitale è una sfida sulle competenze, non sulle tecnologie: quelle sono ormai disponibili dovunque e a basso prezzo. Perché una macchina entra subito in funzione; me per sviluppare abilità appropriate ad utilizzarla occorrono mesi. Perciò, scuola università e aziende devono avanzare all’unisono. Intanto, sappiamo di quali skill avremo più bisogno nel 2030: di quelle tecnologici, di data entry e capacità di calcolo. La domanda è destinata ad aumentare in modo impressionante, perché il loro utilizzo crescerà del 61% rispetto al 2016.
Secondo Iacovone, Mediterranean Managing Partner di EY, «il mercato dell’industria 4.0 è cresciuto del 30% anno su anno, e metà delle imprese ha usufruito di iper e super ammortamento, quanto ad incentivi. Ma c’è un altro aspetto da tenere in considerazione, ed è un tema importante: quello della conoscenza. Solo il 2,5% delle imprese non conosce il tema; questo dato si attestava al 40% nel 2016. Ora, il cambiamento nelle aziende passa per le competenze. Il mondo nuovo in cui siamo entrati è una realtà in cui la partita cruciale non è costituita dalle tecnologie, che sono disponibili dovunque e a costi contenuti rispetto al passato, ma si gioca sul loro utilizzo, sulla capacità di maneggiarle per rendere efficienti i processi e migliorare la qualità dei prodotti. Dunque, la partita si gioca sulle competenze».
D’altra parte, si vince solo se ci si prende in tempo, se si procede al passo serrato. «Mentre una macchina può entrare subito in funzione – ha continuato Iacovone – ci vogliono mesi per sviluppare le conoscenze utili al suo utilizzo. Di qui la necessità di una azione congiunta di scuole secondarie, università e aziende: si tratta di individuare le competenze di cui avremo bisogno fra tre, cinque o dieci anni, e di capire come svilupparle». Il fatto è che nel 2030, si assisterà ad un aumento pari al 9% delle competenze cognitive di altro livello (quelle legate al pensiero critico e al problem solving), che nel 2016 rappresentavano il 19% delle ore lavorate; del 27% di quelle sociali e relazionali (come quelle di leadership o connesse al lavoro di gruppo), che due anni fa costituivano il 15% delle ore lavorate; e del 61% di quelle tecnologiche (programmazione, analisi dati) che nel 2016 erano solo il 10%. Mentre caleranno in entrambi i casi del 15% quelle fisiche e manuali (abilità tecniche e di controllo) e cognitive di base (data entry e capacità di calcolo),che due anni fa rappresentavano, rispettivamente il 38% e il 17% delle ore lavorate.
«Sono queste le proiezioni mondiali dello skill shift tra i 2016 e il 2030 – ha affermato ancora Iacovone -: le competenze che crescono sono quelle che vanno costruite, perché oggi non sono disponibili: nel 2017 la richiesta di personale con conoscenze tecnologiche ha raggiunto la soglia di 27mila unità; e 30mila persone che disponevano di quegli skill hanno lasciato l’Italia. Quindi abbiamo un problema serio: noi stiamo esportando i migliori ingegneri, fisici, statistici; e lo facciamo anche in Germania, che è un paese concorrente nella manifattura; e non siamo in grado di reperire quelle competenze a casa. Stiamo invece importando abilità a bassissima scolarizzazione. Così non va bene: esportiamo il meglio ed importiamo ciò che non ci serve più. Quindi, o tratteniamo qui quelli che dispongono di skill adeguati, o li importiamo dall’estero. Anche noi, che aiutiamo le aziende nel processo di trasformazione, fatichiamo a reperire alcuni tipi di competenze; pertanto, stiamo cercando di formarle internamente, grazie alla EY Academy».

Le sei cause del mismatch fra domanda e offerta
L’anello mancante tra posti vacanti e disoccupazione è costituito dalle competenze. Ed è possibile individuare sei cause del mismatch fra domanda e offerta. Tra queste, l’offerta formativa teorica e antiquata e la troppo sporadica collaborazione tra istituzioni. In un recente studio di EY, “Competenze per il futuro. Come far incontrare domande e offerta?” si illustra anzitutto il mercato del lavoro in Italia: 21 miliardi, il totale delle ore lavorate nel 2017; 1.730 le ore lavorate per occupato; 58%, il tasso di occupazione destagionalizzato l’anno scorso; l’11%, il tasso di disoccupazione nel 2018; e infine il 33%, tasso di disoccupazione giovanile nell’anno in corso (dati Istat). Quanto al mismatch tra domanda e offerta, per EY «l’anello mancante tra posti vacanti e disoccupazione è costituito dalle competenze. Si assiste al deterioramento della capacità strutturale del mercato del lavoro di far incontrare domanda e offerta di lavoro, perché a parità di posti vacanti il tasso di disoccupazione è più alto rispetto a prima. Il problema è il mismatch tra competenze, disponibilità ed esigenze territoriali, settoriali e professionali».
Ma quali sono le sei cause del mismatch fra domanda e offerta? Anzitutto «l’offerta formativa e didattica superiore e universitaria è ancora teorica e disallineata rispetto ai profili professionali emergenti e richiesti dalle aziende»; in secondo luogo «la collaborazione tra istituzioni, enti di formazione e ricerca e aziende è ancora troppo sporadica e de-strutturata»; in terzo luogo «la cultura professionale italiana non valorizza adeguatamente l’autoformazione continua per l’aggiornamento e la crescita»; in quarto luogo «le persone in stato di disoccupazione non si formano rischiano di vedere le proprie competenze diventare obsolete»; in quinto luogo «la prolungata recente crisi economica ha ridotto le opportunità per i giovani di fare esperienza lavorativa e sviluppare le proprie competenze sul campo»; e in ultimo «la diffusione del fenomeno Neet, cioè di giovani non sono impegnati nello studio, né nel lavoro né nella formazione».
E tutto ciò in un contesto particolare, quello creato dagli impatti dell’industria 4.0: «L’evoluzione tecnologica in corso è dirompente e richiede alle Aziende di adeguarsi tempestivamente adottando nuovi modelli di business, tecnologie e modalità di lavoro. Perché queste siano in grado di operare hanno bisogno di Persone con adeguati skillset e mindset. Le figure professionali che dispongono di entrambe i requisiti sono sempre più rare ed è in atto una vera e propria guerra dei talenti, tra le Aziende che se li contendono». Inoltre, in termini di employability «per essere protagonisti della trasformazione in corso ed mantenersi sempre competitivi è necessario formarsi in maniera continua e costante sui temi più innovativi che impattano le nostre aree di competenza professionale in maniera: diretta, richiedendo un incremento del grado di specializzazione o l’acquisizione di maggiore trasversalità (upskilling), che può sfociare in un adattamento del ruolo attuale o addirittura nella riconversione professionale (reskilling); indiretta, modificando i sistemi tecnologici, i processi e le modalità di lavoro con cui ci si interfaccia quotidianamente».
Secondo la ricerca, tra gli hard skill più ricercati, il Coding, e cioè saper sviluppare prodotti e servizi digitali attraverso i linguaggi di programmazione (es. HTML, Java, .Net, C++, Python, R, Ruby, ecc.) e il Growth Hacking: essere in grado di promuovere un prodotto o servizio con tecniche e strumenti digitali, operando con budget ridotti. Tra i soft skill, invece, il Design Thinking, ossia la capacità di risolvere creativamente problemi complessi, e il People-centered, ovvero adottare un visione che pone la Persona al centro di ogni prodotto o servizio.
Il problema degli skill a livello Executive
Il 70% dei manager e imprenditori è consapevole delle proprie lacune in termini di competenze digitali. La risposta della multinazionale è la EY Digital Academy, piattaforma di formazione continua, in lingua italiana, per lo sviluppo di competenze ed esperienze digitali a 360 gradi. Secondo EY, «le aziende non hanno solo bisogno di professionalità esperte ITC (+56% la domanda di nuovi profili digitali), ma necessitano anche di persone che combinino la conoscenza digitale con skill di tipo relazionale e comportamentale e con competenze come la capacità di immaginare il cambiamento e di contestualizzarlo, o quella di risolvere problemi complessi attraverso gli strumenti digitali». Questo vale in primis per imprenditori e livelli dirigenziali, «i cui ruoli e competenze sono progressivamente cambiati per effetto del digitale e che spesso, diversamente dai giovani nativi digitali, si avvicinano ora alle nuove tecnologie.
I manager sono consapevoli della necessità di approfondire le proprie conoscenze: 7 manager su 10 riconoscono di essere carenti nelle competenze digitali e l’80% di essi ritiene che questa lacuna sia il principale impedimento allo sviluppo dei progetti, ad esempio di cybersecurity. Solo il 27% degli executive ritiene di possedere le skill tecnologiche necessarie per attuare la trasformazione digitale». Di qui la nascita, due mesi fa, della EY Digital Academy, piattaforma di formazione continua, in lingua italiana, per lo sviluppo di competenze ed esperienze digitali a 360 gradi. È stata realizzata con partner di sperimentata abilità: Atos, Cisco, Rockwell Automation e SAS. L’idea è appunto quella di mettere a fattor comune le esperienze e le competenze di primarie aziende tecnologiche. Nella pratica, la piattaforma è rivolta a quei dirigenti e a quei manager che intendano intraprendere strategie 4.0. Si tratta, peraltro, di combinare contenuti, esperienze e case history delle cinque società coinvolte per creare una vera e propria community che aiuti imprenditori e dirigenti nella propria formazione.
Anche sulle tecnologie bisogna recuperare terreno
Qualcosa si è mosso negli ultimi tempi, anche grazie al Piano Calenda: ma l’Italia non è indietro soltanto in fatto di competenze, ma anche quanto ad acquisizione di tecnologie. Le aziende “dinamiche”, su questo fronte, sono solo l’11,9%, anche se occupano il 31,2% degli addetti. Il fatto grave è che l’81% delle Pmi del Nord Italia non ha adottato nessuna tra le tecnologie abilitanti 4.0. Secondo Donato Iacovone «l’entusiasmo non manca, diversi imprenditori si sono avventurati nel percorso dell’innovazione e del 4.0; ma quando guardiamo i dati dell’Osservatorio Industria 4.0 del Politecnico di Milano, emerge che le aziende che stanno investendo nella trasformazione digitale utilizzando i benefici del Piano Calenda costituiscono una minoranza».
Per Iacovone, possiamo dividere le imprese in quattro cluster, in rapporto al grado di modernizzazione. Il primo è composto da realtà non innovative: riguarda il 59,4% delle imprese, per il 27,6% degli addetti; il secondo riguarda le imprese con una modernizzazione “tradizionale”, che sono il 13,6% del totale e danno lavoro al 15% degli addetti; poi ci sono le aziende in transizione, che sono il 15,1% e che occupano il 26,1% degli addetti; e infine ci sono le aziende “dinamiche”, che costituiscono l’11,9% e occupano il 31,2% degli addetti. Le aziende con meno di 25 addetti sono quelle in grande ritardo.
Va peraltro affermato «che tante aziende operano secondo nel segmento B2B, e cioè vendono prodotti ad altre aziende. Qui il prezzo è una variabile fondamentale, perché le imprese italiane che si occupano di componentistica sono in concorrenza col mondo: le aziende capofila, tedesche e francesi, sono attente ai costi. Ora, su 100 auto che girano nel mondo una è prodotta in Italia ma sei hanno componentistica italiana. E se le aziende nostrane non recuperano produttività grazie ad innovazione e investimenti, faranno fatica a rimanere al passo con i tempi e in linea con le esigenze dei costruttori del prodotto finale. E quei 450 miliardi di esportazioni italiane, che sono largamente influenzate dal B2B, rischiano di diminuire. Dunque la percentuale di aziende dinamiche è troppo bassa. C’è infine un ultimo dato di cui tenere conto: l’81% delle Pmi del Nord Italia non ha adottato nessuna tra le tecnologie abilitanti 4.0. È un dato preoccupante, che dovrebbe essere inserito nell’agenda politica e di governo: se non portiamo queste aziende ad abbracciare le nuove tecnologie e a sfruttarne i benefici, in breve tempo avremo problemi più seri di quelli che abbiamo oggi».
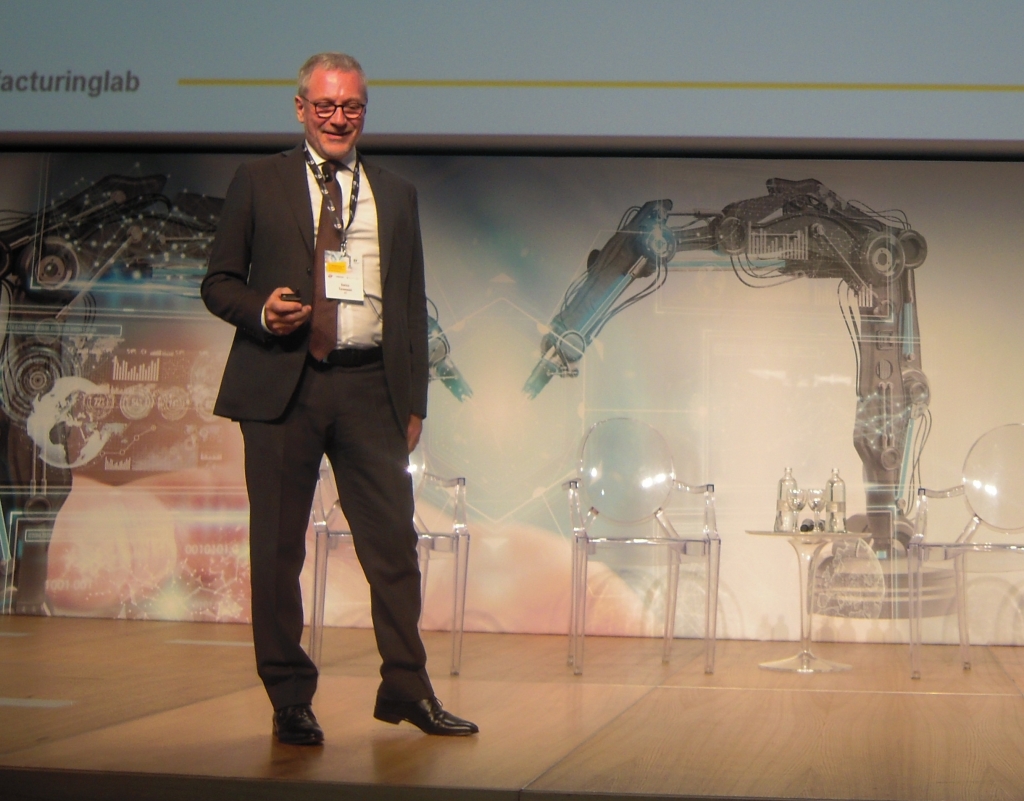
Chi non si muove è perduto
Intanto, per chi ha iniziato, si avvicina la terza fase, quella della Rivoluzione, prevista per il 2021. È dietro l’angolo. Dopo quella dei convegni e quella dei progetti pilota, si passa a quella della trasformazione del modello di business in modo integrato. Quanto alle Pmi che sono rimaste indietro, rischiano molto. Secondo Enrico Terenzoni, Mediterranean Industrial Products Services EY, «è importante rispondere a quattro domande sul 4.0. La prima è senz’altro: a che punto siamo nella fase evolutiva del 4.0? La seconda è: dove si stanno applicando le soluzioni digitali nelle aziende manifatturiere? La terza è: quali sono gli abilitatori della trasformazione digitale? La quarta, infine: quale percorso per una sostenibile digital transformation?»
Quanto alla prima domanda, secondo Terenzoni la trasformazione digitale sembra seguire tre “wave”, e cioè tre fasi storiche. «Anzitutto, il concetto di industria 4.0, dal 2013 è condiviso ormai nel mondo a seguito di tanti eventi e convegni; attualmente, nell’anno in corso, siamo in fase di applicazione di queste idee nel manifatturiero. La rivoluzione, e cioè la trasformazione del modello di business in modo integrato, avverrà quando saremo stati capaci di digitalizzare i processi. Una data precisa non si può definire, ma pensiamo che il 2021 costituisca una collocazione temporale plausibile». Ma cosa hanno rappresentato queste tre fasi storiche? «La prima è stata guidata da consulenti, da Confindustria, dall’università, e ha avuto, quanto a contenuti, libri, incontri, articoli e convegni. Ma ha anche avuto, sempre quanto a “sostanza”, i Digital Innovation Hub e il Piano Calenda. Spesso il 4.0 è stato presentato in modo immaginifico, partendo da concetti delle digital native company; in realtà non è semplice trasferire modelli innovativi in aziende tradizionali. Le imprese hanno risposto facendo dei progetti pilota, quasi tutti di scarso successo: non hanno avuto un peso nell’azienda. Insomma, la prima fase è stata caratterizzata da scarsi risultati economici, ma dalla crescita degli investimenti in automazione e connettività.
Quanto alla seconda, finalmente le aziende hanno preso in mano la materia, e attraverso l’introduzione di nuovi ruoli, come il chief digital officier, l’operational technology e l’analytics specialist, hanno lanciato programmi di digitalizzazione, pur a livello di singolo processo. Dunque, è vero che i solutions provider sono a supporto, ma la palla è passata in mano alle aziende. E ci sono i primi risultati di successo, in termini di costi, qualità e tempi, e cioè in termini di competitività. Si sta verificando un cambiamento profondo dell’organizzazione e dei processi, nel contesto della convergenza tra analogico e digitale e in vista di una roadmap digitale.
La terza fase, la vera rivoluzione, e cioè la possibilità di cambiare radicalmente i modelli di business (ridisegnando la supply chain e la relazione con il cliente), i confini dell’azienda e costruire degli ecosistemi che si auto-regolano, avverrà quando riusciremo a mettere insieme la digitalizzazione delle singole funzioni, dei singoli processi aziendali. Alcune aziende sono prossime a questa fase; ma la maggior parte è ancora in quella precedente». Quanto alla seconda domanda, il 4.0 si sta radicando, secondo Terenzoni «da una parte nei prodotti, con la sensoristica e con la connettività; e, in alcune aziende, nei processi, per la manutenzione preventiva e predittiva, per la sincronizzazione della supply chain e per altro. In realtà, dipende molto dal settore nel quale si opera. Un’impresa che realizza impianti di produzione avrà in genere un’impronta più tradizionale, in termini di processo, perché è il prodotto stesso che diventa digitale; nella siderurgia, invece, è difficile digitalizzare un coil; di conseguenza si opererà sul processo. Altri settori presentano sia prodotti che processi digitalizzabili: mi riferisco in particolare all’automotive e all’elettronica».
Quanto alle Pmi, per Terenzoni «sono ancora al palo, come abbiamo visto: o si legano ad ecosistemi che si stanno coagulando attorno ad aziende leader, o la massa critica per fare investimenti diventa improponibile». Quanto alla terza domanda, va detto che gli abilitatori, per Terenzoni «sono quelli del mondo analogico: strategia, che faccia chiarezza su quanto debba cambiare, in profondità, un’azienda; processi, che vanno allineati sia sull’analogico che sul digitale; e infine tecnologia e persone, che devono adeguarsi alla nuova realtà da un punto di vista motivazionale e qualitativo». Concludendo, quanto alla quarta domanda, per Terenzoni il percorso inizia anzitutto con «la misurazione della Maturità Digitale e delle opportunità; in secondo luogo, prosegue con la definizione di una strategia di ecosistema «Digital Driven», con obiettivi e budget; in terzo luogo, continua con l’avvio di iniziative digitali sui processi chiave; in quarto luogo, avanza con la valorizzazione delle iniziative e l’allineamento dei ‘‘4 abilitatori’’ già citati; infine, termina con l’Integrazione digitale e la definizione di nuovi modelli di business».
[boxinizio]
EY
È un network globalizzato di servizi professionali di consulenza direzionale, revisione contabile, fiscalità e altro. Conta 250.000 dipendenti in tutto il mondo. Il network è presente con più di 700 uffici in 150 Paesi. È tra le più prestigiose società di comparto. Insieme a Deloitte, PWC (Pricewaterhouse Coopers) e KPMG è parte delle cosiddette Big Four, le quattro più grandi aziende di revisione. Fino al 2002 a queste si aggiungeva la Arthur Andersen, prima del fallimento in seguito allo scandalo Enron negli Stati Uniti. Quanto al fatturato, è in continua crescita: dal 2009 al 2017 è aumentato del 46%, passando da 21,5 miliardi di dollari ai 31,4 miliardi. È stata fondata a Londra, dove ha sede, nel 1989, da Arthur Young e Alwin C. Ernst. Secondo EY, Arthur Young nacque a Glasgow, in Scozia. Si laureò in giurisprudenza, ma si è interessò al settore bancario e agli investimenti. Nel 1890, si trasferì negli Stati Uniti per perseguire la carriera in contabilità. Nel 1906, formò una società di contabilità, Arthur Young & Company, con suo fratello Stanley. Alwin C Ernst nacque a Cleveland, negli Stati Uniti. Dopo aver lasciato la scuola lavorò come contabile. Poi, nel 1903, lui e suo fratello Theodore avviarono Ernst & Ernst, una piccola società di contabilità pubblica. AC Ernst e Arthur Young non si sono mai incontrati nella loro vita, ma sono morti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro nel 1948; nel 1989 gli studi che avevano creato si sono uniti per costituire Ernst & Young. A partire dal primo luglio 2013 il nome dell’azienda Ernst & Young è stato sostituito da EY.
[boxfine]