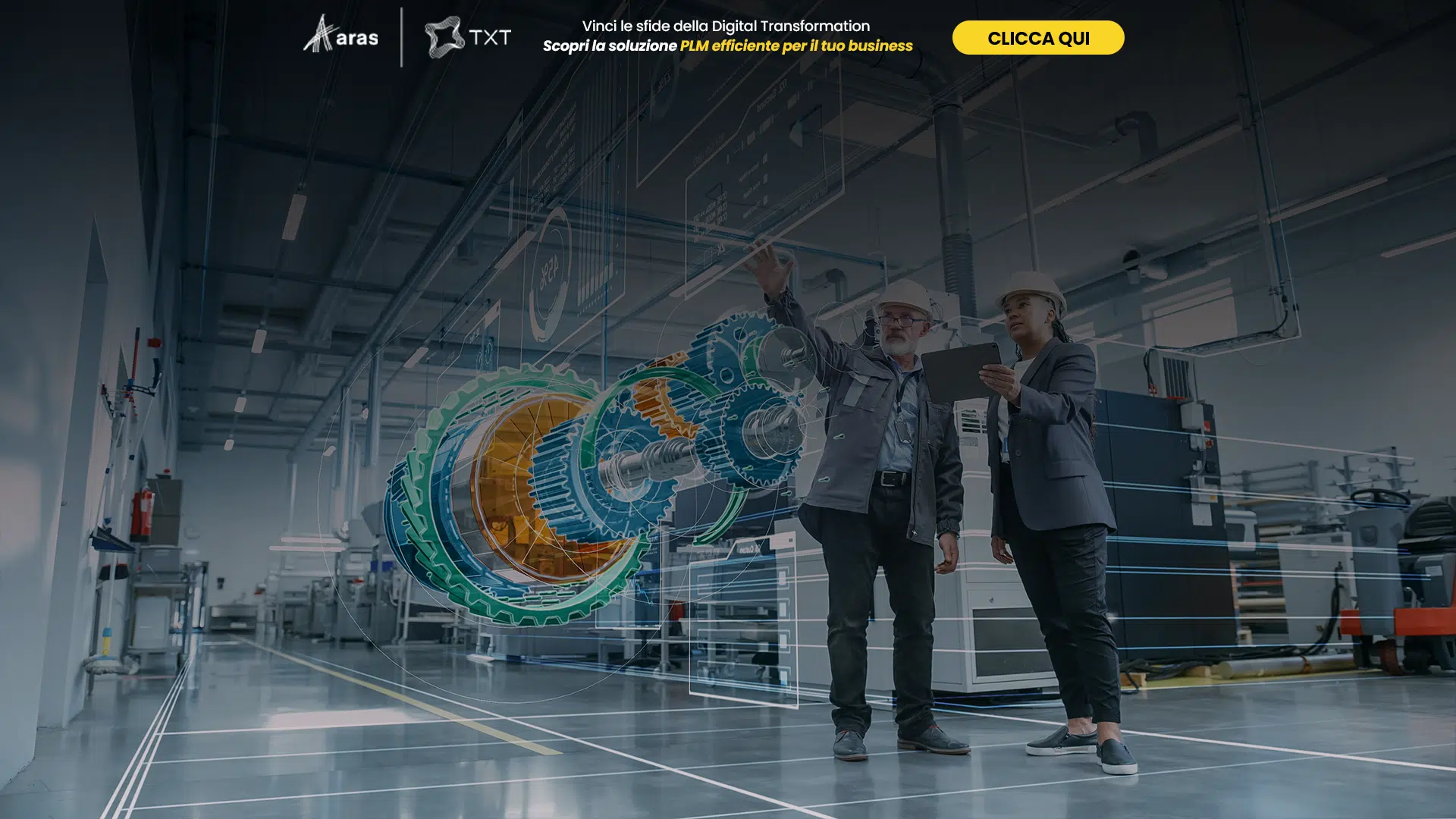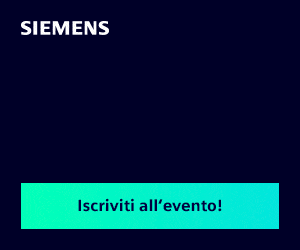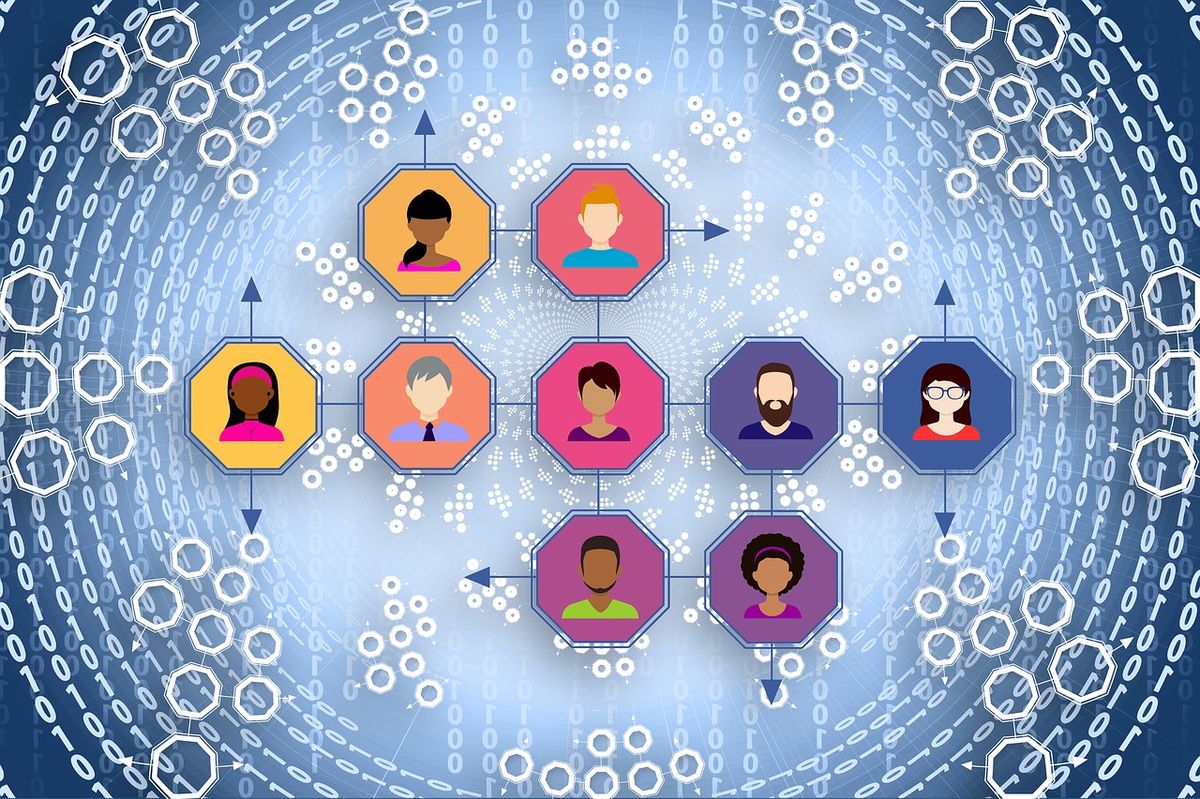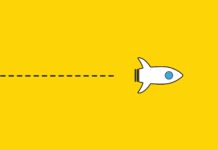di Lucio Lamberti ♦ Le tecnologie sono necessarie ma non sufficienti per attivare la digital transformation del business. Gli strumenti determinanti sono la visione e le competenze. Ecco le priorità a fronte delle carenze formative. Se ne parla al convegno “Made in Italy, Made in Digital” organizzato da Sap Italia il 24 maggio a Verona
L’ autore è Professore Associato di Marketing Multicanale, Politecnico di Milano – School of Management
Ormai è opinione comune (fortunatamente) che nella locuzione “trasformazione digitale del business” la parola “digitale” è potenzialmente ingannevole. Non si tratta, infatti, di una trasformazione tecnologica, ma di una trasformazione del modo di fare business anche grazie alle tecnologie. Insomma: il fine è cambiare il modo di lavorare (anche perché i mercati faticano a consentire l’immobilismo); le tecnologie, in ossequio all’etimo (“l’applicazione e l’uso di tutto ciò che può essere funzionale alla soluzione di problemi pratici, all’ottimizzazione delle procedure, alla scelta di strategie operative per raggiungere un determinato obiettivo”) sono uno degli strumenti attraverso il quale si può cambiare. Certamente non l’unico, e altrettanto certamente non una condizione sufficiente per una trasformazione di successo.
Per quanto l’intelligenza artificiale, il machine learning e la robotica ci abbiano messo a disposizione strumenti dalla sofisticazione, dalla capacità computazionale, dall’autonomia esecutiva, dalla facilità d’uso impensabili fino a pochi semestri fa, stiamo sempre e comunque parlando di macchine, e quindi di strumenti in grado di processare in modo teoricamente impeccabile un input, ma non di determinare la qualità dell’input stesso. In altri termini, se le tecnologie ricevono istruzioni sbagliate, faranno le cose nel modo giusto, ma non per questo faranno la cosa giusta. Allora, concentriamoci sugli altri “strumenti” in grado di rendere una trasformazione efficace e di valore. In questa sede, mi concentro su due ingredienti parzialmente interconnessi: la visione e le competenze.

La visione
Sul primo tema, un elemento che mi ha profondamente colpito, in una serie di recenti interlocuzioni con imprenditori, è un tratto ricorsivo nelle imprese che sono uscite con successo dal cambio di paradigma iniziato post-crisi del 2008/2009: il fatto che le radici della loro trasformazione sono ben affondate proprio negli anni della crisi. Si tratta di imprese che nel 2008/2009, a causa della recessione globale, hanno visto un crollo verticale dei loro fatturati, anche nell’ordine del 20-30%, e che hanno deciso di intraprendere il percorso di trasformazione e innovazione proprio in quel periodo in ragione del fatto che il calo di attività liberava tempo alle loro risorse.
Trovo questo approccio interessante (e, devo dire, anche piuttosto incoraggiante per il futuro delle nostre imprese) perché combina due fattori-chiave: il primo riguarda la comprensione della necessità del cambiamento e la propensione a innovare; il secondo è il coraggio imprenditoriale unito alla capacità di comprensione del contesto. Certamente, servono anche le spalle larghe di anni di profitti per sostenere l’investimento, e magari anche alcune misure di sostegno che consentano di affrontare un periodo duro, ma se non altro i due punti sopra elencati sono variabili endogene per l’impresa.
Le competenze: talenti cercasi
Sul fronte delle competenze, dobbiamo fare un ragionamento speculare: se la trasformazione è trasformazione del modo di lavorare, da chi può venire l’input per cambiare? Dalla capacità di interpretare in modo nuovo il proprio lavoro quotidiano da parte delle risorse interne all’organizzazione, oppure da nuove risorse innestate in azienda, che portino nuova linfa, nuova visione? A precisa domanda su questo punto, le imprese che hanno partecipato finora alle attività di ricerca del progetto Made in Italy, Made in Digital condotto dalla School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con SAP Italia e con alcune delle più prestigiose università tecniche italiane, segnalano la necessità di compresenza dei due ingredienti: da un lato, trasformare in modo efficace non può prescindere da una forte conoscenza dei processi oggetto della trasformazione, e la vera conoscenza dei processi – soprattutto produttivi – è nelle mani degli operatori, dei manager, degli ingegneri di processo. Trascurare le loro competenze (e soprattutto le loro esperienze, la loro conoscenza tacita) in sede di riprogettazione è un errore da evitare se si vuole sviluppare innovazione implementabile, in grado di entrare nell’operatività in tempi brevi ed efficacemente.
D’altro canto, vuoi per questioni generazionali (i cosiddetti millennials tendono a essere nativamente più digitali di professionisti con 15 o 20 anni di più), vuoi per una comprensibile inerzia al cambiamento, specie nel momento in cui si vanno a toccare processi che hanno caratterizzato l’attività lavorativa degli operatori per lustri, uno sguardo terzo, meno vincolato al contesto aiuta a guardare alle cose da una prospettiva nuova. E qui emerge un tema-chiave, che sarebbe auspicabile porre al centro anche delle politiche educative ed economiche del Paese: in un tessuto economico ricco di piccole e medie imprese, ma ricchissimo anche di grandi imprese B2B, di eccellenza conclamata, ma di richiamo meno spiccato rispetto a grandi nomi in settori B2C come quelli della moda, o dell’alimentare, molte delle imprese che trainano la nostra economia faticano a reclutare talenti, sia perché il profilo di competenze ricercate non sempre è coerente con le preferenze di formazione dei nostri giovani (e questo è alla base di un fenomeno parossistico, per cui, a fronte di una disoccupazione giovanile drammatica, abbiamo decine di migliaia di posti di lavoro vacanti perché non si trovano competenze adeguate a coprirli), sia perché queste realtà B2B sono considerate meno attrattive da parte dei giovani e delle loro famiglie.

Lo scarso appeal delle scuole superiori a indirizzo tecnico
Lungi dal voler sminuire l’importanza del cosiddetto made in Italy “hi-touch” italiano (moda/lusso, agroalimentare, ecc.), lo squilibrio di esposizione mediatica, alla base anche di determinate scelte formative delle nuove generazioni (basti pensare al boom delle iscrizioni alle scuole alberghiere in risposta al successo dei programmi televisivi sulla cucina), dei settori che trascinano l’export nazionale è evidente: nel 2017 l’Italia ha esportato più prodotti farmaceutici che prodotti tessili, e il settore delle macchine industriali, nel suo complesso, più della somma di agroalimentare, calzature e mobili. E così, mentre abbiamo schiere di giovani che legittimamente ambiscono a diventare brand manager di una grande griffe o che affollano aule inseguendo un titolo di studio che ahimè, numeri alla mano, ha una spendibilità professionale non sempre elevata, abbiamo troppi pochi ragazzi che si iscrivono a scuole superiori a indirizzo tecnico, che intraprendono la strada della specializzazione in arte e mestieri e studiano le materie-chiave del nuovo mondo economico (informatica, statistica, discipline tecnologiche, scienze pure, ecc.).
Attenzione alla specializzazione eccessiva
Ovviamente, non è solo un problema di orientamento scolastico, ma di rapporto tra formazione e lavoro: sono personalmente critico rispetto alle voci che invocano una maggiore attenzione da parte del sistema scolastico alla specializzazione spinta dei talenti per renderli immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Non credo, infatti, che la specializzazione spinta nei percorsi di studi sia la migliore soluzione per le prospettive delle nuove generazioni: il mondo cambia troppo velocemente per rendere opportuna la decisione a vent’anni di specializzarsi in uno specifico ambito verticale che con ogni probabilità potrebbe divenire obsoleto nell’arco di dieci anni. Questo anche perché la specializzazione eccessiva a livello scolastico rischia di avere effetti collaterali pericolosi: pensiamo al programma di studio di un perito informatico oggi e 20 anni fa.
Il numero di nuovi ambiti di conoscenza emersi in questo periodo nella disciplina si scontrano con la constatazione che la durata dell’indirizzo di studi – e quindi il volume di ore di apprendimento – è rimasta la stessa. Quindi, per aggiungere questi elementi se ne devono “tagliare” altri, ovvero alcune delle competenze-base. Una deriva di questo tipo mi preoccuperebbe perché, laddove l’area di specializzazione divenisse obsoleta, sarebbero proprio le basi ad aiutare la ricollocazione dei talenti. Per questo, diventa importante sviluppare un approccio alla formazione in cui la Scuola fornisca le giuste basi e le competenze adeguate a garantire una spendibilità, e la formazione continua in azienda (eventualmente anche in collaborazione con le stesse scuole) coltivi i talenti accompagnandoli da una specializzazione all’altra.
Questo formato, peraltro, credo possa trovare un riscontro positivo tanto presso le imprese, interessate per quanto sopra detto a talenti “trasversali” e capaci di pensiero laterale quando si tratta di pensare alla trasformazione, quanto presso le Istituzioni, se è vero che numerose realtà territoriali hanno intrapreso programmi di sostegno alla specializzazione in azienda. Vi è poi un tema di riflessione circa la produttività dei percorsi formativi (ovvero, come lavorare per trasformare l’apprendimento, consentendo a insegnanti e studenti di insegnare/imparare di più e meglio a parità di tempo destinato alla formazione), tema a mio avviso troppo trascurato nei dibattiti sull’istruzione nel nostro Paese.
La partita si gioca sull’intelligenza umana
Insomma, la strada della trasformazione dei sistemi economici passa anche attraverso la trasformazione dei sistemi per la preparazione delle persone ad abbracciare il cambiamento. In un mondo iper-tecnologico, l’intelligenza artificiale è una commodity, mentre la partita si gioca sui talenti e l’intelligenza umana. Mi auguro di assistere, nei mesi a venire, a un intenso dibattito sul “patto generazionale” di sensibilizzazione sulle professioni, di formazione continua e di interscambio tra chi è oggi in azienda e chi si gli si affiancherà nei prossimi anni, e, coerentemente con ciò, a iniziative che aiutino a formare figure professionali solide, spendibili, capaci di rendere le imprese per cui lavoreranno più competitive, e per questo in grado di costruirsi un futuro personale roseo. La partita è di importanza incalcolabile: sono in ballo sia la stabilità del futuro dei nostri giovani, sia il contrasto a fenomeni di distacco sociale – da un lato chi può abbracciare con fiducia il nuovo cambiamento, dall’altro, chi vede nel cambiamento una minaccia e lo rifugge – che mettono a rischio la tenuta stessa delle società.