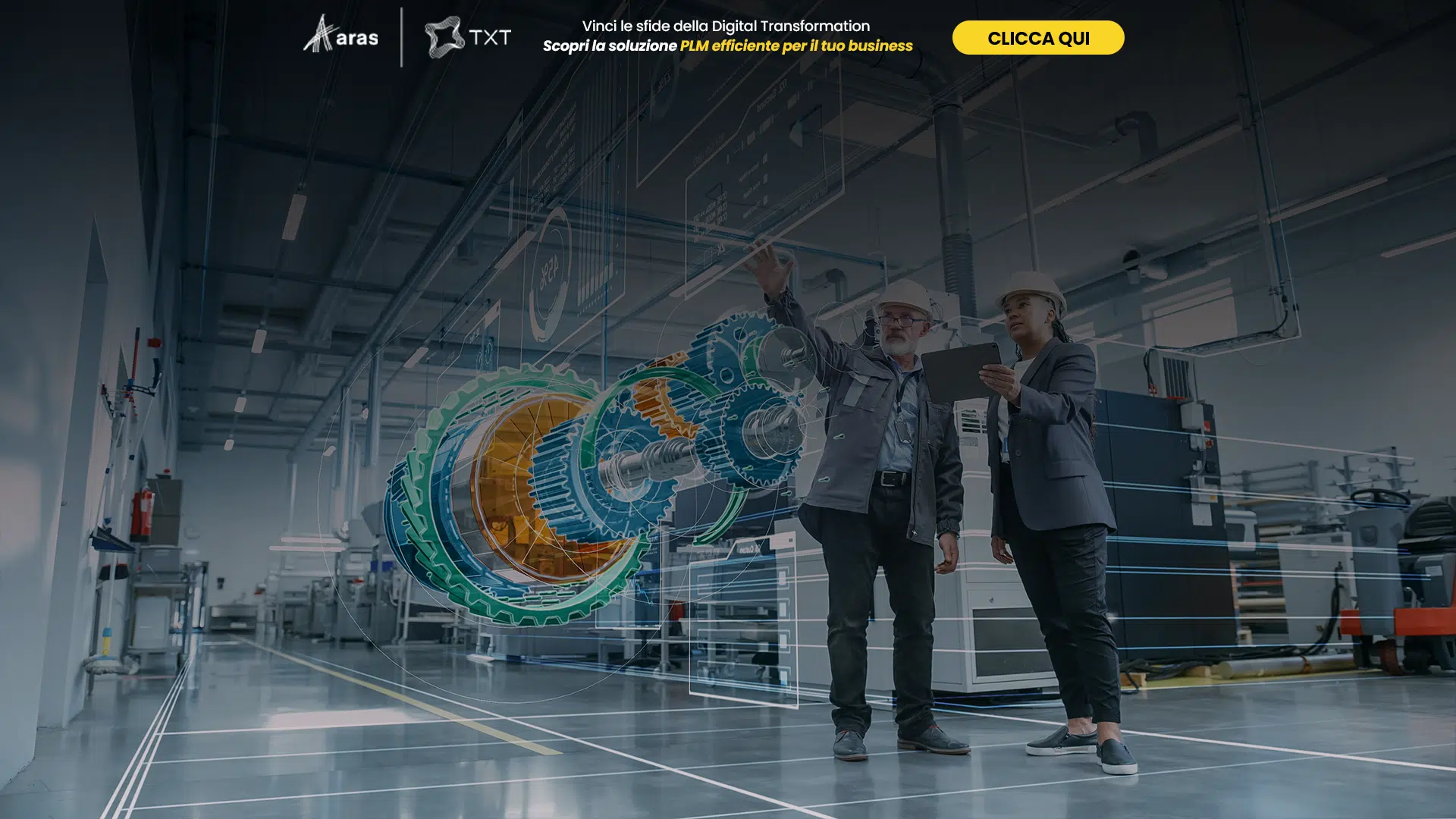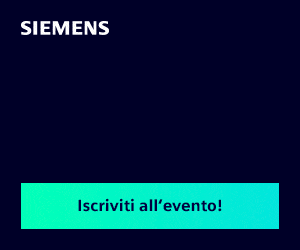di Piero Macrì ♦ Startup innovative che stentano, venture capital raro. Le imprese possono trarre nuova linfa vitale dalla condivisione di risorse? Sono possibili ecosistemi di competenze ed esperienze? Ecco i percorsi indicati da Fabio Benasso, numero uno di Accenture
Le opportunità che possono essere innescate dalla sharing economy sono molteplici: dall’implementazione di piattaforme digitali nelle realtà di distretto industriale che possono fungere anche da potente motore per la digitalizzazione delle reti di filiera, al coinvolgimento di startup a complemento di obiettivi di ottimizzazione dei processi esistenti o come leva per la determinazione di modelli di business innovativi. In tutti i settori – dalla Gdo, al finance, al manifatturiero – piccole, medie e grandi aziende stanno vivendo momenti di grande discontinuità. La progressiva presenza di newcomer digitali e l’affermazione di nuovi modelli di business necessita la creazione di una cultura d’impresa diversa dalle precedenti.
Il punto fondamentale è avere consapevolezza che l’interazione tra componenti interne ed esterne alla propria organizzazione diventa l’elemento centrale per la trasformazione digitale e lo sviluppo di una rinnovata sostenibilità. Su questi temi e su quelli legati più in generale all’innovazione digitale nel nostro Paese, Industria Italiana si è confrontata con Fabio Benasso, Amministratore Delegato di Accenture, incontrato a margine della conferenza “Open Innovation for Circularity”, promossa dall’American Chamber of Commerce.

Startup, dallo spontaneismo a processi strutturati
Da tempo si va ripetendo che mancano gli investitori e che manca una cultura adeguata. “Aumentano il numero delle startup innovative, i loro dipendenti e il valore della produzione – si afferma nell’ultima Relazione annuale del Ministro al Parlamento sullo Startup Act italiano – ma continua a persistere un problema di dimensioni e di crescita, che si intreccia con quello degli investimenti in venture capital, sempre più lontano dagli altri Paesi europei”. Tuttavia, se da noi il venture capital è un fenomeno fisiologicamente marginale – le startup innovative rappresentano ancora una frazione ridotta, pari allo 0,67% delle società di capitali attive in Italia – si continua a sperimentare, e nuove idee, non prive di un qualche interesse, iniziano a emergere.
Le grandi aziende stanno diventando interessate all’acquisizione di competenze, un fenomeno che crea una possibile leva per fare emergere nuove realtà. Si afferma la consapevolezza che l’innovazione vada ricercata anche fuori dal perimetro d’impresa. È necessario avere apertura, riconoscere che idee utili ai propri obiettivi di business possono nascere altrove. Tutto questo può creare nuova energia permettendo di confrontarsi con modi di pensare diversi, che possono contaminare positivamente l’azienda nel suo complesso.
Il venture capital in Italia
D. Qual è la situazione in merito al venture capitalism e alla capacità del sistema Italia di dare spazio alle startup?
R. Nonostante si dica da anni che questa possa essere una importante leva per il rinnovamento, l’Italia continua a essere drammaticamente indietro rispetto ad altri Paesi europei, non solo alla Germania e alla Francia, ma anche alla Spagna. Il Belpaese è ricco di idee ed esiste una vivacità nella proposizione di nuovi modelli di business. La liquidità non manca, le risorse di sistema esistono, ma facciamo fatica a creare interazioni efficienti tra tutti i soggetti che devono necessariamente essere coinvolti lungo tutto il ciclo di vita del processo.
Le difficoltà maggiori consistono nel riuscire a creare percorsi di crescita sostenibili e scalabili in progetti. Per creare le premesse per un decollo di una startup bisogna essere capaci di formulare modelli di sviluppo imprenditoriali basati su una vera logica industriale, senza che nulla sia lasciato al caso e allo spontaneismo. Il venture capital deve consentire l’apporto finanziario, ma da solo non è sufficiente se non si prevede e si formalizza un percorso evolutivo chiaro in grado di tradurre il tutto in un’offerta di mercato. L’errore più grande da parte di molte startup è invece rincorrere un chip pro bono tanto per arrivare al prossimo round di finanziamento.

Lo scenario vincente
D. Quali sono le possibili modalità di attuazione di un processo virtuoso e sostenibile?
R. Servono grandi capacità manageriali ed estrema focalizzazione sui modelli di business. Nell’ultimo periodo si è evidenziata una nuova e positiva tendenza ovvero grandi aziende che iniziano a interpretare un ruolo da protagonista nello sviluppo di nuove realtà imprenditoriali e di business. E’ uno scenario che può mettere in moto delle relazioni win-win: da una parte gli incubatori che acquisiscono know-how prezioso, dall’altra le persone portatrici di nuove idee che hanno l’opportunità di fare leva sugli asset d’azienda, creando così le premesse per una crescita sostenibile sia in termini di organizzazione che di fatturato.
Un modello ibrido, in grado di attrarre capitali strutturali e far sì che prodotti e servizi possano raggiungere una molteplicità di mercati. Nel processo di selezione dei progetti deve poi essere posta attenzione sulla tipologia di business, le risorse economiche devono privilegiare quelli che hanno una forte progettualità in termini di sostenibilità ambientale e innovazione. L’apertura delle aziende a percorsi di innovazione sta progressivamente diventando una realtà. E’ un fenomeno positivo, ma spesso il modo in cui questo metodo viene applicato è discutibile. L’apertura al mondo esterno al perimetro aziendale non deve essere un puro scouting di idee ma dovrebbe essere formalizzata e codificata come prassi organizzativa il cui fine ultimo è l’integrazione di competenze esterne al perimetro d’impresa. Infine, una volta individuata la risorsa ci si di deve impegnare per poterla far crescere e svilupparsi senza lasciare nulla al caso.

L’innovazione digitale sul campo
D. Gdo, Finance e Industria, come i differenti comparti di industry stanno vivendo la discontinuità di mercato innescata dall’innovazione digitale?
R. In questi ultimi dieci anni ciascun mercato ha vissuto una dinamica di trasformazione diversa. Il mondo della grande distribuzione è quello che ha conosciuto le disruption più importanti, anche in virtù di una minor barriera all’ingresso. In questo settore si sono imposti modelli di accesso e di consumo ormai consolidati in virtù di una relazione digitale, di cambiamenti demografici e stili di vita nonché di valore d’acquisto.
Nel finance – nonostante sia uno dei settori potenzialmente più esposto alla vulnerabilità di mercato – l’ingresso sulla scena di una nuova generazione di nativi digitali ha impattato solo marginalmente sui fatturati. Per il finance la vera disruption deve ancora arrivare. E’ vero, cresce il numero di new player con modelli di business innovativi, ma perché questi diventino realmente competitivi, in grado di sottrarre quote di mercato a coloro che presidiano il mercato, si dovranno attendere trasformazioni ancora più sistemiche.
Per quanto riguarda l’industria, il piano di incentivi messo a punto dal Governo ha generato grandi investimenti su asset aziendali, generando una profonda trasformazione della tecnologia. Tranne eccezioni, è però un fenomeno che non ha ancora evidenziato un livello di seconda trasformazione. Quest’ultimo, associato alla valorizzazione e monetizzazione dei dati, è solo parzialmente realizzato. Serve focalizzarsi su obiettivi non unicamente legati a fare innovazione di fabbrica, focalizzandosi sul possibile cambiamento dei modelli di servizio.
Fondamentale è l’affermazione della meccatronica ovvero l’integrazione tra meccanica ed elettronica, in grado di porre le basi per una progettazione intelligente che apre le porte a nuovi modelli di distribuzione e consumo. Stiamo parlando di un percorso verso un’impresa interconnessa dove sia possibile valorizzare i dati ed evolvere verso modelli di servizio. E’ un fenomeno a cui tutti guardano con interesse, ma credo che una visione sistemica della connected factory sia ancora tutta in divenire.
E le Pmi, che fare?
D. Il fatto che l’Italia sia un Paese di piccole e medie imprese è sempre stato percepito come un vantaggio competitivo. Oggi però questo comparto sembra esposto a sempre maggiori vulnerabilità?
R. Le piccole e medie aziende non hanno la capacità di governare in modo autarchico l’innovazione digitale e la sua dimensione tecnologica. La soluzione va ricercata nella creazione di ecosistemi in grado di fare economia di scala sulle tecnologie abilitanti. Innovation hub, competence center, servono spazi e luoghi dove le aziende possano entrare in contaminazione con idee e tecnologia di nuova generazione, supportando progetti di cluster d’imprese, ciascuna uguale ma diversa. Questo non vuol dire svilire l’identità e capacità competitiva delle Pmi. Tutt’altro.
Mettere a fattor comune piattaforme digitali di filiera e di industry permette di focalizzarsi al meglio sulla propria originalità e specificità, potendo però fare affidamento su un’infrastruttura di prim’ordine per governare l’innovazione tecnologica. Un esempio è quello della motor valley (il distretto industriale situato in Emilia-Romagna specializzato nel settore automobilistico, Ndr.) , dove si sono creati centri di competenza e piattaforme trasversali all’ecosistema d’impresa, valorizzando soluzioni di filiera che possono aiutare le imprese a fare un salto d’innovazione. La logica, se vogliamo, è quella ispirata dalla sharing economy.

L’importanza della formazione
D.Per far sì che le aziende possano riuscire a tenere il passo con l’innovazione diventa centrale la capacità di fare formazione. Eppure, nelle aziende italiane di formazione se ne fa molto poca?
R.Credo che da parte delle aziende e degli imprenditori sia ormai un imperativo categorico far si che la propria forza lavoro possa evolvere nel tempo acquisendo nuove competenze. In assenza di interventi a supporto della formazione esiste il rischio di ritrovarsi con una forza lavoro improduttiva che non crea alcun valore aggiunto. E’ una consapevolezza che le aziende devono metabolizzare rapidamente pena una progressiva perdita di competitività poiché i cicli d’innovazione diventano sempre più brevi. Non esiste una soluzione univoca.
Rottamare il vecchio e comprare il nuovo è un gioco che non paga poiché è vero che si fanno entrare nuove energie con capacità di interpretazione diverse, ma si corre il rischio di perdere il know-how d’impresa e di settore e la conoscenza delle logiche produttive. Si deve affrontare un percorso di long-time learning che preveda attività di skilling e re-skilling. Sotto questo aspetto, ancora una volta, sono le le Pmi ad essere più in difficoltà rispetto alle grandi aziende. La capacità di attrazione nei confronti di nuovi talenti, per esempio, è mediamente debole da parte delle Pmi. Persone con competenze pregiate trovano invece nelle grandi aziende prospettive globali e internazionali. Tuttavia, stili di vita lavorativi e profili retributivi adeguati potrebbero fare la differenza.