di Filippo Astone ♦ Con la sua intervista al Corriere della Sera a inizio anno il ministro Carlo Calenda ha rilanciato il tema dell’ azione pubblica, facendo intravedere una fase 2 dopo il pacchetto Industry 4.0. Ma di che cosa parliamo davvero? Alcuni spunti tratti dal libro Industriamo L’Italia!
La grande sfida: ridurre l’incertezza.
La politica industriale può consistere in un insieme di interventi volti a favorire il processo di trasformazione, evoluzione o adattamento del sistema produttivo, accompagnando e rafforzando le dinamiche di mercato. Non può mai consistere in un insieme di obiettivi e strumenti validi in ogni periodo storico e in ogni paese, ma va sempre disegnata a partire da precise circostanze storiche e istituzionali. E da tempo, ormai, non può consistere in incentivi economici diretti ad alcune imprese. Le regole della concorrenza, le leggi dell’Unione Europea e il buon senso lo impediscono.
Insomma, la politica industriale è sempre diversa nel tempo e nello spazio. La gestione dei cambiamenti, il loro accompagnamento, è, anzi, la sua maggior e sfida. Il concetto di “accompagnamento” è particolarmente importante. Sono finiti i tempi della “programmazione economica”, e non ha alcun senso porre rigidi obiettivi di crescita, che sarebbero impossibili da attuare. Si può solo accompagnare, fertilizzare, aiutare, ma mai dirigere.
L’assurdità degli obiettivi numerici imprecisati con rigidità e anni di anticipo, si è dimostrata tale anche in un ambito parzialmente diverso, e cioè la politica economica. In questo campo, il governo dell’Europa, anche in tempi recenti, ha fatto gravi errori. Viviamo in un clima di austerità che – come vedremo – deprime la crescita economica senza procurare vantaggi di sorta – proprio perché un quarto di secolo fa il trattato di Maastricht ha imposto rigidi limiti valevoli ancor oggi. La determinazione del limite del 60% sul rapporto fra debito pubblico e PIL, per esempio, avvenne negli anni Novanta sulla base del fatto che ci si attendeva una crescita nominale del 5% (crescita reale 3% con inflazione del 2%) e un fabbisogno del 3%. Insomma, Maastricht si fonda su un assurdo economico: fissare per decreto il tasso di crescita di un paese. Senza considerare come questo possa variare nel tempo.

Il ruolo dell’azione pubblica
L’azione pubblica può provare a condizionare, favorire, indirizzare i percorsi di trasformazione delle attività produttive e delle iniziative che vi stanno a monte, ma non è assolutamente in grado di determinarli con certezza o addirittura di pianificarli. «Lo sviluppo industriale di un paese», dice Gianfranco Viesti, professore ordinario di economia applicata all’Università di Bari, «è sempre frutto di dinamiche spontanee di mercato, imprenditoriali e tecnologiche, che rispondono in condizioni di grande incertezza a una pluralità di stimoli e incentivi.» Come ha dimostrato in vari studi Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’economia nel 2001, la domanda corretta non è se una politica industriale può ridisegnare o rilanciare un intero sistema produttivo, ma se o che cosa può fare per favorirne o accelerarne alcuni processi evolutivi.
Accompagnamento, cultura, scienza, innovazione.
La capacità di mantenere nel tempo un settore industriale è sempre legata alla sua trasformazione e al continuo sviluppo di nuovi prodotti e nuove trasformazioni. «La competitività industriale è un fenomeno dinamico», spiega Viesti. «È sempre ostacolata dall’emergere o dal rafforzarsi di concorrenti o dall’affievolirsi della domanda relativa alle specializzazioni già acquisite. È invece favorita dalla capacità di generare nuove produzioni in grado di intercettare nuova domanda e nuovi bisogni, di applicare e utilizzare nuove conoscenze e tecnologie, grazie all’emergere o al rafforzarsi di imprese particolarmente competitive.» In effetti, c’è un solo modo di ridurre l’incertezza: aumentare la conoscenza.

La politica industriale deve far leva sui territori.
Sul finire del Novecento, il concetto di politica industriale rimandava a un sistema politico nazionale che controllava o influenzava il sistema produttivo e si relazionava con il resto del mondo. Ora questo approccio così semplice e verticistico sarebbe inefficace. Viviamo, infatti, in un mondo complesso, interconnesso, nel quale la concorrenza avviene su vari livelli. Uno di questi, è il livello territoriale. La complessità va affrontata con la complessità. Pertanto la politica industriale deve coinvolgere una pluralità di attori.

«La politica industriale non si può più fare per legge. Occorre mettere in campo strumenti che possano essere usati in modo convergente su singoli territori e in risposta a precisi problemi. Si tratta di orchestrare in modo efficace diversi strumenti di lavoro e sviluppo, riuscendo anche a utilizzare i fondi europei», spiega Patrizio Bianchi, ordinario di Economia applicata alla Facoltà di Economia e Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara e Assessore a coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro della Regione Emilia Romagna : «Tutto ciò va fatto con un occhio molto attento ai fattori internazionali e tenendo presente il contesto locale e nazionale complessivo. Tutte le politiche devono essere giocate insieme: economiche, industriali, sociali e di welfare.»
L’approccio locale-territoriale è importantissimo.
Del resto, è nei territori che, come vedremo, si sono sviluppati i punti di forza manifatturieri e della conoscenza dell’Italia (e anche di altri Paesi). Ci sono sistemi territoriali che sono diventati protagonisti mondiali nel settore di riferimento, dall’automotive alla componentistica moto, dalle macchine per il confezionamento e l’imballaggio a quelle per la produzione di piastrelle, dalle calzature al biomedicale. E gli altri casi eccellenti di politica industriale (Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, ma non solo) sono tutti stati costruiti attorno ai territori, con investimenti sulla conoscenza convogliati lì. Questo non vuol dire, ovviamente, che debba mancare un livello nazionale. Il raccordo nazionale dovrebbe accompagnare, coordinare, supportare i vari ambiti locali in gioco. E lo stesso dovrebbe avvenire a un livello ulteriormente superiore, in Europa.

Quali leve usare per la politica industriale del terzo millennio.
Le leve della politica industriale contemporanea sono la tassazione, il sostegno alle varie declinazioni dell’istruzione e della ricerca (università, centri di ricerca, formazione professionale), gli acquisti della pubblica amministrazione, le azioni di coordinamento fra le imprese, le normative tecniche, l’attrazione e l’organizzazione degli investimenti privati in riferimento a specifiche priorità. «Queste leve, combinate fra loro con approcci molto complessi, possono avere successo solo se vi è continuità nell’approccio. Ci vogliono interventi contemporanei, coordinati fra loro ed estesi per un certo numero di anni. Al tempo stesso, bisogna continuamente verificare i risultati e i gradini intermedi», dice Patrizio Bianchi.
Un nostro altro interlocutore, Andrea Bianchi, Direttore Area Politiche Industriali di Confindustria, classifica le leve sui cui intervenire in modo leggermente diverso. «Gli strumenti della moderna politica industriale sono riconducibili a tre: domanda pubblica; collaborazione pubblico/privato nell’innovazione; collaborazione fra pubblico e privato nella finanza. Invece, l’obsoleta strumentazione della politica industriale è radicata su incentivi e intervento diretto. Questa cassetta degli attrezzi non è più proponibile e oggi, in un mondo interconnesso, non servirebbe a nulla. Purtroppo, molti respingono l’idea stessa di politica industriale perché ancora la vedono collegata a questi vecchi arnesi.»

Collaborazione fra pubblico e privato.
Andrea Bianchi sottolinea come le recenti politiche europee stiano molto spingendo sulla collaborazione tra pubblico e privato. E sul pubblico come moltiplicatore di valore del privato. «È una leva assai complessa da muovere, ma è molto importante», insiste Bianchi. «Già adesso, il settore pubblico può muovere selettivamente la leva della domanda pubblica. Ma può anche cercare di orientare in qualche modo l’offerta. Per esempio attraverso la collaborazione tra ricerca pubblica e ricerca privata. Ma anche nel settore finanziario, con esperimenti di successo come il Fondo italiano di investimento.»
Settori o fattori?
Fino a qualche anno fa, usava distinguere fra politica industriale orizzontale, o dei “fattori”, e verticale, o “settori”. I sostenitori della prima ambiscono a orientare l’evoluzione dell’economia nel territorio sul quale la comunità insiste rafforzando i “fattori” alla base della social capability dell’impresa (burocrazia, fisco, capitale umano, istruzione), senza prendere posizione su settori o modelli di impresa da privilegiare. Al mercato il compito di fare le scelte migliori. L’altra scuola di pensiero, invece, guarda alla “politica verticale”, orientata cioè ai “settori”, che privilegia specifici ambiti industriali e tende a porsi obiettivi precisi in termini di architettura economica del territorio, tecnologie, tassi di crescita, modelli di impresa ecc.
Il dibattito “fattori vs settori” è stato sollevato dallo scomparso economista della Bocconi Riccardo Faini in un articolo del 12 luglio 2005 su il Sole 24 Ore, suscitando finalmente un importante dibattito politico-culturale. Faini – allora vicino alla Margherita e appassionato sostenitore dell’opzione “orizzontale” in quanto convinto che il settore pubblico fosse (sia?) troppo sensibile alle pressione di lobby e interessi privati – aveva duramente criticato l’allora governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio. Il quale, nella sua relazione annuale, aveva invitato a seguire l’esempio “verticale”della Francia.
Secondo una vecchia impostazione economica, di cui Faini era portatore, fra i due approcci non ci sarebbero compatibilità. Fattori o settori. Tertium non datur. Adesso però non è più così. Il contesto internazionale, ed europeo in particolare, sembrano aver superato la dicotomia. Stati Uniti e paesi europei a maggior tasso di crescita (Germania, Francia, Gran Bretagna) da tempo applicano una “terza via” che permette di intervenire sui “fattori” e di incentivare i “settori”. Incentivare non significa erogare contributi di Stato (che, peraltro, in Europa sono vietati nella misura in cui falsano la concorrenza) ma utilizzarli con due tipi di azioni: la prima, procedere a investimenti in ricerca e sviluppo (la media dei succitati paesi è intorno al 3% del PIL); la seconda, è di esercitare un coordinamento delle imprese per costituire reti fra di esse e con le università.

Un esempio fra tutti: la Germania
La Germania è intervenuta sui “fattori”, in particolare sugli aspetti finanziari (prestiti a lungo termine per progetti industriali) ma si è anche dedicata al coordinamento delle imprese, creando 15 Cluster tecnologici (gli Spitzencluster) e alimentando con quasi due miliardi di euro la Fraunhofer-Gesellschaft, la più grande organizzazione di ricerca applicata in Europa, votata alla salute, la sicurezza, la comunicazione, l’energia e l’ambiente. Gli esiti sono evidenti solo guardando alla dimensioni della crescita dell’industria delle energie alternative. Tutte queste azioni sono svolte a livello locale, creando dei “distretti” dove imprese leader si coordinano e spesso trainano pmi e start-up, coinvolgendo università, pubbliche amministrazioni, rappresentanza sindacale e datoriale.
A parte la distinzione fra “fattori” e “settori”, che qualcuno potrebbe anche vedere come una sorta di oziosa disputa accademica, il problema è che molti (fra i quali ci sono Matteo Renzi e i suoi collaboratori) ritengono che agire solo sui “fattori” significhi già condurre una politica industriale. «Condurre una politica industriale agendo solo sui fattori è da poveri illusi. Un mercato non si è mai aggiustato da solo producendo soluzioni ottimali, viste le posizioni di oligopolio che vi prevalgono», spiega per esempio Fulvio Coltorti, già Direttore del Centro Studi di Mediobanca e oggi docente di Storia economica (e in particolare Storia delle Spa e delle grandi imprese) all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

«Soprattutto adesso, quando in Italia un quarto della capacità produttiva è inutilizzata e stiamo toccando il record di lavoratori disoccupati o sottopagati. Keynes ha ampiamente dimostrato come un sistema di mercato possa restare in equilibrio anche in condizioni di sottoccupazione. È verissimo che siamo vincolati da politiche europee che sono sbagliate (l’austerità in momenti di sottoccupazione è un grave errore) ma qualcosa si può fare comunque, con la ricerca e sviluppo, le azioni di coordinamento e sinergia, l’attrazione di capitali privati.»
Per Andrea Bianchi, la tradizionale distinzione fra politica industriale dei settori e dei fattori «è ormai superata, perché la tecnologia ha scompaginato il concetto di settore. Nano-tecnologie, biotecnologie e Ict sono abilitatori trasversali a vari settori. Peraltro, l’obiettivo di una politica industriale moderna dovrebbe essere far dialogare i settori fra di loro. Le politiche per favorire lo sviluppo di tecnologie industriali, pertanto, sono all’incrocio fra “settore” e “fattore”. Per esempio, le Nanotecnologie sono dei settori, ma sono anche un fattore di innovazione.» Non a caso, oggi politica industriale e politica dell’innovazione sono strettamente connesse.

Perché l’industria deve rimanere assolutamente centrale
Industria. Manifattura. Fabbriche. Industria. Manifattura. Fabbriche Industria. Manifattura. Fabbriche. In questo libro, come in tutta la nostra attività giornalistica recente, non ci stancheremo mai di ripetere questi concetti. Ma perché siamo convinti che il discorso sull’industria debba essere sempre il discorso politico più importante? E perché quando parliamo di politica industriale ci riferiamo sempre alla manifattura? E perché mettiamo in secondo piano i servizi, il commercio, l’agricoltura, il turismo? In questo paragrafo di “Industriamo l’ Italia! Viaggio nel’economia reale che cambia”, da cui è tratto questo articolo (e che in parte riprende alcuni testi tratti dal mio libro La Riscossa, edito nel 2014 da Magenes) cerchiamo di dare alcune risposte a queste domande cruciali.

Perché le fabbriche devono rimanere qui in Italia.
Senza le fabbriche, l’Italia può solo deperire fino a una situazione di tipo greco o portoghese. Perché l’industria è strettamente legata a ricerca e sviluppo e a quei gangli di creatività tecnologica capaci di pilotare la marcia dell’innovazione, la stessa innovazione che ci rende competitivi sui mercati globali. Perché ciò sia possibile, i laboratori di ricerca e la produzione devono essere vicini, contigui, e magari legati a centri di elaborazione intellettuale come le università.
È solo così che si produce quella “tecnoscienza” che secondo Alberto Quadrio Curzio rende possibile la tenuta dell’economia. Perché la “tecnoscienza” sia efficace, occorre che il nucleo produzione di qualità resti qui, in Italia. Anche se le tecnologie di comunicazione accorciano le distanze, va mantenuta la sequenza ricerca e sviluppo-produzione-generazione di competenze. Certo, è giusto creare stabilimenti produttivi vicini ai mercati da servire, tanto che il modello vincente del Quarto capitalismo vede in Italia headquarters (per ricerca e la parte di produzione necessaria a testare i prodotti e a servire il mercato italiano), mentre gli stabilimenti dislocati in giro per il mondo riforniscono i vari paesi, e a volte rappresentano, nel loro complesso, gran parte della produzione dell’impresa. Ma comunque il cervello, il cuore, il portafoglio e una parte del corpus devono restare qui in Italia.

La delocalizzazione ha sempre meno senso.
Un ulteriore motivo per sostenere la necessità che il manifatturiero resti il più possibile in Italia è la progressiva perdita di senso economico dei processi di delocalizzazione. Tra il 1990 e il 2010 la delocalizzazione produttiva è stata un fenomeno di massa. Intere regioni della Romania sono state praticamente colonizzate da imprenditori del nord-est ansiosi di ridurre il costo del lavoro. Adesso, quel trend è in via di esaurimento. Si continua a esportare e a internazionalizzare, ma si delocalizza sempre meno.
Perché è finita la moda, e il guadagno fatto sul basso costo del lavoro è sempre più effimero. Guadagna chi punta sull’innovazione e la qualità, non chi sfrutta i bassi salari. Che comunque sono sempre meno bassi. Perché la corsa al ribasso globale del lavoro deve trovare necessariamente un limite. E perché anche rumeni e cinesi si stanno avviando verso la sindacalizzazione e la presa di coscienza dei loro diritti. Soprattutto, l’evoluzione tecnologica sta trasformando le fabbriche in luoghi a crescente densità tecnologica e a decrescente densità di lavoro. In prospettiva, la variabile costo del lavoro avrà un peso percentuale sempre più basso. L’automazione, insomma, abbatte il costo del lavoro. Un recente studio della McKinsey ha calcolato che, entro dieci anni, fra il 15 e il 25% dei posti di lavoro operai saranno occupati da robot.
Torna il Made in Italy fatto in Italia
Ultimo, ma non meno importante fattore anti-delocalizzazione da evidenziare, la crescente sensibilità che in tutto il mondo si sta creando per prodotti “davvero” made in Italy. Secondo uno studio del Consorzio universitario Uni-Club MoRe, il 42% dei casi di back-reshoring– cioè di rilocalizzazione in Italia di fabbriche delocalizzate – si spiega con la presa di coscienza del valore economico del made in Italy. L’Italia può vantare il singolare record di rilocalizzazione,con 79 impianti tornati “a casa”, seconda soltanto agli Stati Uniti d’America con 175 casi. «Riportare una produzione in Italia può produrre un importante valore economico per l’immagine aziendale, e il brand, di chi lo fa. Significa dare grande attenzione alla qualità del prodotto. Questo, per quasi tutte le aziende, significa tutto», ci dice Roberto Giovannini, partner di Kpmg con la responsabilità di seguire il manifatturiero.
Negli Usa, però, c’è stata una forte politica industriale, tesa a favorire i rientri. In Italia no. Tutto frutto, come sempre, nel bene come nel male, della libera e indipendente iniziativa di imprenditori, tra loro senza alcun coordinamento d’intenti. Metà di questi industriali proviene dal settore tessile-calzaturiero, proprio quello – non è un caso – che negli anni passati si era distinto per la corsa oltre i confini patri. In modo sfrenato e talvolta anche insensato.
Manifattura = Sistema cognitivo distribuito.
Un’azienda manifatturiera non è fatta solo di macchine. È invece un sistema cognitivo distribuito, che aumenta ancora di più la sua complessità se ruota attorno a tecnologie avanzate. Il gigantesco patrimonio di conoscenza implicita ed esplicita che forma questo sistema cognitivo risiede nella memoria delle persone che ci lavorano in misura uguale, o spesso anche maggiore, dei file che sono depositati in vari reparti, stabilimenti, officine e uffici.
Altrettanto importanti sono le relazioni che si sono stabilite fra i vari sistemi di conoscenza ed esperienza. Sono queste relazioni e queste conoscenze a rendere fondamentale il fatto che il cuore dirigenziale dell’azienda sia vicino ad almeno una parte, quella originaria, della produzione. Per dare vita a tutto questo ci vogliono decenni, varie generazioni di padroni, manager, ricercatori, operai. E il valore di tutto questo non si misura certamente con la capitalizzazione in borsa del momento, ma con la redditività industriale di lungo periodo.
E tutto questo delicato sistema di conoscenze e relazioni è facilissimo da distruggere. Bastano pochi anni di una scellerata gestione manageriale, innamorata delle mode del momento o dei dati di borsa di breve periodo o, ancor peggio, dei tagli lineari. O basta che l’azienda sia venduta a un gruppo più grande, magari straniero, un gruppo incapace di cogliere il valore della sua conoscenza e del suo saper fare e interessato solo a stupide sinergie di breve periodo, e tutto va a rotoli.

Il manifatturiero genera gran parte degli incrementi di produttività.
Il manifatturiero rappresenta dunque la “sala macchine” della crescita economica, perché genera gran parte dei guadagni di produttività dell’intero sistema. Li genera direttamente: attraverso l’innovazione tecnologica applicata ai suoi processi e ai suoi prodotti. E genera guadagni di produttività anche indirettamente: attraverso l’utilizzo negli altri settori dei beni manufatti che incorporano queste innovazioni. Il manifatturiero, inoltre, è il massimo diffusore di innovazione nel resto dell’economia perché è al crocevia di tutti i processi economici.
Dalla sua attività, insomma, origina gran parte dei guadagni di produttività dell’intero sistema economico. Gli incrementi di produttività non avvengono solo attraverso le economie di scala e di scopo nella produzione, ma anche e soprattutto grazie a rendimenti crescenti di tipo dinamico (tecnicamente si dice learning by doing, che in parole povere vuol dire “si impara facendo”), che si generano via via grazie alla più efficiente divisione del lavoro. In questo modo, viene provocata progressivamente una crescente domanda di innovazione.
Fabbriche e innovazione: un binomio inscindibile.
Un’innovazione generata nelle fabbriche risulta tanto più rilevante per il sistema economico quanto maggiori sono le sue ricadute sui settori produttivi contigui a quello in cui essa è avvenuta. «Da questo punto di vista, la capacità di diffusione delle innovazioni è massima proprio nel manifatturiero, giacché l’attività di trasformazione richiede l’utilizzo di materie prime e input intermedi e una quantità crescente di servizi, per cui altrimenti non ci sarebbe mercato, e fornisce beni impiegati in tutti gli altri settori», ha scritto Livio Romano, ricercatore del Centro studi di Confindustria, in una nota dedicata all’argomento.
Inoltre, le esportazioni manifatturiere sono vitali per l’Italia, che è un Paese povero di materie prime, e grazie a esse può coprire le importazioni. Infatti, una riduzione permanente del 20% dell’export italiano (che per l’80%è manifatturiero) causerebbe un calo del PIL del 15% in otto anni, e degli investimenti del 17,2%. «Le esportazioni manifatturiere rivestono un ruolo strategico anche in virtù del fatto che, soprattutto per un paese povero di risorse naturali come l’Italia, consentono di allentare il vincolo esterno, ossia contribuiscono in modo decisivo al pagamento di quello che il Paese acquista all’estero, così da mantenere e innalzare il suo standard di vita. Infatti, è soprattutto dal manifatturiero che provengono i prodotti esportabili che servono a pagare le bollette energetiche e alimentari e, in generale, a finanziare gli acquisti di beni e servizi all’estero», scrive Romano.

Il manifatturiero come sala macchine della crescita.
Va aggiunto che gli effetti del manifatturiero sul PIL complessivo sono enormi. Il Centro studi di Confindustria ha fatto una stima secondo la quale un aumento durevole della quota del manifatturiero sul Pil dell’1% in cinque anni determinerebbe una successiva e ulteriore crescita del PIL totale dello 0,5% annuo.
Il meccanismo è questo: una più elevata domanda di beni manufatti stimola una sempre maggiore specializzazione della stessa manifattura e, mediante i guadagni di produttività, consente di generare un crescente reddito disponibile nell’economia. Questo maggior reddito, se si tramuta in ulteriori incrementi di domanda di prodotti manufatti, determina un processo circolare virtuoso in cui la maggiore industrializzazione causa una maggiore crescita economica e la maggiore crescita economica stimola più industrializzazione.
«Si può anche osservare come la concorrenza spinga il manifatturiero a una crescente efficienza nell’impiegare gli input e costringa, quindi, chi li produce a innovare per soddisfare la domanda di miglior combinazione prezzo-qualità. D’altra parte, qualunque settore impiega beni manufatti nei suoi processi produttivi e beneficia in termini di maggiore produttività dei miglioramenti tecnologici che tali beni inglobano», aggiunge Romano.
Una fortissima ricaduta in termini di generazione di servizi.
Inoltre la manifattura ha un impatto in termini di generazione di servizi, che nessun altro settore può dare. Nel caso dell’automotive, esistono studi che dimostrano che per ogni occupato della Fiat o di altra azienda primaria, vengono generati almeno altri due posti di lavoro fra fornitori di componenti e servizi. In altri comparti della manifattura, l’ordine di grandezza è lo stesso, o forse addirittura superiore.

Politica industriale e conoscenze.
Da tutto questo, il Centro studi di Confindustria trae argomentazioni per sostenere che occorre una politica industriale che incentivi la conoscenza. Per crescere in specializzazione competitiva la nostra manifattura deve puntare su mercati internazionali in espansione. E per farlo deve giovarsi di una politica industriale. «L’effetto del manifatturiero sul PIL dipende dallo stock delle conoscenze detenute al momento dell’integrazione nel mercato globale, perché sono tali conoscenze che determinano la collocazione competitiva di ogni paese rispetto alla concorrenza estera. E, dunque, è l’acquisizione preliminare di quelle conoscenze il presupposto della capacità di sfruttare la leva della domanda che l’apertura commerciale consente.» Una politica industriale dovrebbe allora facilitare tutto questo, con ogni strumento a disposizione.
L’industria ci lega alle dinamiche dell’economia internazionale.
Bisogna sottolineare un elemento essenziale: l’industria lega strettamente noi italiani alle dinamiche dell’economia internazionale, mentre i servizi ci ancorano a un asfittico, declinante e sempre più povero mercato interno. Anche perché l’economia italiana dei servizi è, nel suo complesso, tutto fuorché sofisticata. In Italia, molta parte dei servizi ad alto valore aggiunto (come il software) viene erogata da filiali locali di multinazionali. Come ha scritto Giuseppe Berta nel suo libro ” Produzione intelligente ” concentrarci interamente sui servizi nel migliore dei casi ci consegnerebbe «un futuro fatto di centri commerciali e di una gamma di servizi alla persona di modesta qualità, senza gli aggregatori forti e competitivi che altrove strutturano la complessione economica della società. La ritirata dall’economia della produzione apre la strada a un coacervo di attività che non generano ricchezza a sufficienza, e non a quei gangli di creatività tecnologica capaci di pilotare la marcia dell’innovazione.»
Anche Berta sottolinea che «oggi nelle nuove fabbriche e nella nuova industria si produce conoscenza insieme con i manufatti e con i servizi. La produzione continua e cumulativa di conoscenza è quanto può assicurare alle fabbriche e all’industria italiane un futuro. E questo futuro – anche se ridimensionato ed esiguo rispetto al passato – si può scorgere in nuce già oggi. La storia della manifattura che diventa sempre più tecnologica e automatizzata può essere letta come un atto continuo di condensazione e di formalizzazione delle conoscenze lavorative, oggettivate nella tecnologia. Oltre una determinata soglia di sviluppo, la fabbrica è soprattutto tecnologia e conoscenza, mentre il lavoro si compone di operazioni di supervisione, regolazione, controllo. Mansioni delicate e importanti, che incorporano ed elaborano a loro volta conoscenza e che mutano la natura stessa dell’essere operaio.»

Ricostruire il ruolo guida dello stato
«Alla fine», ha scritto David Runciman in un bel libretto intitolato “Politica” e pubblicato da Bollati Boringhieri nel 2015, «è solo la politica che ti può salvare dalla cattiva politica.» Stato. Politica. Tutto il nostro discorso su manifattura, politica industriale, crescita economica e sociale porta a sottolineare il ruolo centrale che lo Stato, nelle sue varie articolazioni, ha e deve avere. Questo, che per noi è un dato di fatto, comporta un’operazione faticosa ma necessaria: ribaltare almeno due decenni di retorica anti-statalista e pro “libero mercato” (in realtà chi usa questa locuzione si riferisce al mercato sregolato) a tutti i costi.
Bisogna anche ripensare l’approccio alla politica, che oggi – grazie a retorica “anti- casta” e populista alimentata da comportamenti inaccettabili di molti politici – è vista come qualcosa di negativo qualunque colore abbia e chiunque siano gli esponenti della classe politica. Fare politica, invece, è un mestiere nobile, e ci sono tantissime persone che vi si dedicano (o che sarebbero disponibili a farlo) con un sincero spirito di servizio.
A nostro avviso, lo Stato è l’unico che può accompagnare in maniera ordinata i processi di sviluppo a lungo termine, fare una sintesi degli interessi collettivi, investire in conoscenza ad alto valore aggiunto, di fornire quei “capitali pazienti” che, agendo a lungo termine, sono in grado poi di creare enorme valore. E quell’enorme valore va a vantaggio di tutti, certo, ma viene poi distribuito abbondantemente anche alle aziende, e a tutti gli attori dell’economia privata.
Il rischio della “cattura del decisore”: come evitarlo.
La maggiore obiezione che si fa al concetto di politica industriale (e quindi di intervento dello Stato) consiste nel rischio della “cattura del decisore”, che può venire piegato a interessi di parte. Ma questo rischio è presente sempre. L’assenza di una strategia di politica industriale può essere essa stessa il frutto delle pressioni di interessi costituiti, ai quali può interessare il mantenimento dello status quo oppure il ricevimento di vari supporti e aiuti economici dallo Stato senza che qualcuno si faccia domande circa la loro coerenza con le politiche industriali perseguite a parole. In un paese senza un’esplicita strategia di politica industriale è molto più facile che vengano prese decisioni estemporanee che vanno incontro agli interessi di singoli, magari con la scusa dell’“emergenza”.
Secondo molti osservatori, l’assenza di una politica industriale palese e consapevole negli ultimi 40 anni ha fatto molto il gioco della Fiat, che così ha potuto essere sostenuta in varie forme, anche nascoste, e senza contropartite.Inoltre, i decisori politici possono più facilmente massimizzare i ritorni di consenso di breve termine. Per essere chiari, il famoso provvedimento degli 80 euro in busta paga sarebbe stato difficilmente giustificabile nell’ambito di un piano strutturato di politica industriale.

Mariana Mazzucato e il ruolo centrale dello Stato.
La mano pubblica è da sempre il principale attore imprenditoriale e il maggior volano per la creazione di ricchezza. Mariana Mazzucato, economista inglese di origine italiana, l’ha dimostrato recentemente con efficacia nel suo saggio “The Entrepreneurial State. Debunking Public vs Private Sector Myths”(2013, Arthem Press, tradotto in Italia da Laterza con il titolo “Lo Stato innovatore“). Si tratta di uno dei libri più importanti pubblicati nel mondo, negli ultimi anni, in tema di politiche industriali.
In 350 pagine Mazzucato dimostra, fatti e dati alla mano, come, da sempre, il settore pubblico sia insostituibile nel promuovere l’innovazione perché si assume rischi in cui il settore privato farebbe fatica ad avventurarsi. Esso dispone infatti di “capitali pazienti”, che possono attendere la remunerazione del rischio non entro cinque anni, come i fondi di private equitye venture capital, ma anche in dieci vent’anni.
Siamo nel mondo reale. Un mondo raccontato da internet, su cui ha investito l’ente pubblico americano di difesa, la Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa); Il web o lo schermo tattile, entrambi nati nei laboratori del Cern grazie ai soldi di Stati europei; il sistema di scorrimento “multi-touch” frutto della ricerca nell’università del Delaware è stato sostenuto dalla National Science Foundation e dalla Central Intelligence Agency/Director of Central Agency (Cia/Dci). L’elenco è infinito. E a Mazzucato serve per evidenziare un fatto: i protagonisti dell’innovazione sono sovvenzionati da sistemi-paese, e ciò avviene anche in regimi fortemente liberisti, a cominciare dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna.

Lo Stato, si dimostra nel libro, non è dunque solo un grande regolatore che corregge fallimenti ed esagerazioni dei mercati, ma il maggior creatore di nuovi mercati. In breve, è il più grande imprenditore esistente, da sempre. Le pagine de Lo Stato innovatore prendono altresì di petto una questione decisiva: il dispiegarsi di “un marketing della verità” che restituisca agli Stati ciò che è degli Stati, con buona pace di un certo mainstream liberista.
«Se non metteremo in discussione i tanti “miti” dello sviluppo economico e non abbandoneremo le visioni convenzionali del ruolo dello Stato nello sviluppo, non potremo sperare di affrontare le sfide strutturali del 21esimo secolo e produrre quel progresso tecnico e organizzativo indispensabile per una crescita equa e sostenibile nel lungo periodo», scrive l’autrice. La quale mette in evidenzia come il governo tedesco stia investendo significativamente su nucleare, energie eoliche e solari, tecnologie “verdi”. O come quello Usa destini alla ricerca farmaceutica – attraverso i suoi programmi statali Nih – collocamenti pari a 30,9 miliardi di dollari all’anno. Denaro che ha indotto la Pfizer a trasferire i propri quartier generali dal Kent inglese a Boston.
«Quando rinuncia ad assumere un ruolo guida, lo Stato non rappresenta più un’alternativa reale al settore privato, ma un cattivo imitatore dei comportamenti di quest’ultimo», scrive Mazzucato, che individua nello Stato come «creatore dell’economia della conoscenza» l’unico modo per uscire dall’attuale situazione di crisi. Tra le soluzioni per creare una crescita sostenibile c’è la necessità di dare vita a sistemi ecologici (economici) simbiotici in cui lo Stato, anche attraverso livelli regionali e di prossimità, garantisca il funzionamento di «un’economia fortemente intrecciata, con continui anelli di retroazione tra individui e organizzazioni.»
L’innovazione e la conseguente crescita sono impossibili senza un processo globale che di fatto è esistito nel ’900 ma oggi assume sempre più dinamiche parassitarie, in cui i privati fanno incetta delle scoperte pubbliche e le riescono a rivendere attraverso operazioni di marketing e integrandole tra loro, salvo poi pretendere sgravi fiscali e contestare le “ingerenze” del pubblico. Il settore su cui ripartire viene individuato in quello della “rivoluzione verde”. «I governi devono continuare a sostenere le tecnologie pulite fintanto che il vantaggio (in termini di costi nascosti) delle tecnologie consolidate non sarà stato annullato, e in alcuni casi ci vorrà un secolo per arrivarci.»

L’economista docente all’università del Sussex cita spesso John Maynard Keynes, che approva in tutto e per tutto e del quale è, in buona sostanza, l’epigono del ventunesimo secolo. Ma ne contesta l’idea che lo Stato possa impiegare le persone anche solo per scavare buche e poi fargliele riempire. Lo scopo del pubblico non è quello di garantire piena occupazione, ma di promuovere e guidare il mercato, sviluppando la crescita attraverso la ricerca (la piena occupazione ne è una conseguenza).
[boxinizio]
Una nuova teoria del valore: intervista con Mariana Mazzuccato
Nel suo saggio di prossima pubblicazione “The Value of everything” Mariana Mazzucato definisce una nuova teoria del valore. Ce ne parla in un’intervista che riportiamo qui di seguito, e nei prossimi paragrafi.
«Per contrastare la disuguaglianza bisogna ancorare l’azione dello Stato a una nuova teoria del valore e della crescita. Solo mettendo insieme gli insegnamenti di Keynes sulla domanda e quelli di Schumpeter sul rischio e sull’innovazione, sarà infatti possibile una crescita inclusiva, cioè accompagnata dauna riduzione della disuguaglianza», spiega Mazzucato. Il libro inizierà con una risposta a Thomas Piketty, l’economista francese che, insieme alla Mazzucato, potrebbe essere l’ispiratore di una nuova sinistra. L’analisi di ” The value of everything” parte proprio dall’elemento chiave di Piketty: il rapido aumento del tasso di remunerazione del capitale, rispetto al rendimento medio in crescita.
«Il capitale ha preso il sopravvento, superando il resto dell’economia a causa del modo in cui la narrazione su chi sono i “creatori di valore” è stato catturato da un piccolo gruppo di agenti in attività finanziaria, che hanno iniziato a creare l’illusione, oggi luogo comune diffuso, che tutto il merito della grande ondata di innovazione dagli anni Settanta in poi, fosse loro.» Fu infatti il National Venture Capital Association, nel 1973 a convincere il governo degli Stati Uniti a dimezzare (dal 40% a 20%) l’imposta sul rendimento del capitale in soli 5 anni: in nome di imprenditorialità e l’innovazione.

«Eppure tutte le tecnologie che stanno alla base del miracolo Silicon Valley sono state finanziate dal governo americano in varie forme», dice la studiosa. «Si vuole negare il ruolo dello Stato, o sminuirlo, perché così diventa molto più facile evitare di condividere i guadagni. Lo Stato, investendo, socializza il rischio. Ma i privati vorrebbero invece socializzare solo le perdite, e conservare interamente per sé tutti i guadagni. Finora ci sono riusciti benissimo. Ma così hanno determinato un generale impoverimento.» Socializzare i guadagni, per Mazzucato, significa infatti pagare le imposte, «che a loro volta servono per finanziare maggiore innovazione, e quindi provocare la crescita economica, altrimenti impossibile. Il luogo comune per cui riducendo le imposte si favorisce la crescita economica è falso.»
Renzi senza un’idea forte.
A questo punto risulta evidente come il pensiero di Mazzucato entri in collisione con quello di Renzi, e soprattutto con le sue politiche. «A mio avviso», prosegue la studiosa italo-britannica «nelle sue politiche manca un’idea forte di che cosa possa essere il settore pubblico e di quale ruolo potrebbe svolgere per lo sviluppo economico. Non c’è nemmeno un’idea convincente di politica industriale. In America la Fiat investe, e lo fa a ritmi significativi, perché glielo ha chiesto il Governo come precondizione. In Italia non accade, non c’è un dare e un avere ispirato dal desiderio di creare ricchezza per la collettività. C’è solo un dare e un dare a senso unico. E non solo per una questione di convenienze. Credo che ci sia anche una sudditanza di carattere culturale e psicologico. È un peccato. Perché ci rimette l’Italia, che non inverte il declino in atto ormai da molti anni.»
Per Mazzucato, «al sistema delle imprese manca un ecosistema serio di innovazione, industria e finanza a lungo termine. Esiste un’urgenza di questo tipo di riforme. Ma invece di affrontarla, Renzi pensa solo a smantellare lo Stato. In questo modo non cambia niente di sostanziale, non c’è niente. Al saldo, durante un anno di governo Renzi, in Italia non si è mosso niente. Pertanto, è illusorio pensare che basti abbattere le tasse o ridurre la burocrazia e automaticamente arriverà lo sviluppo.»
[boxfine]
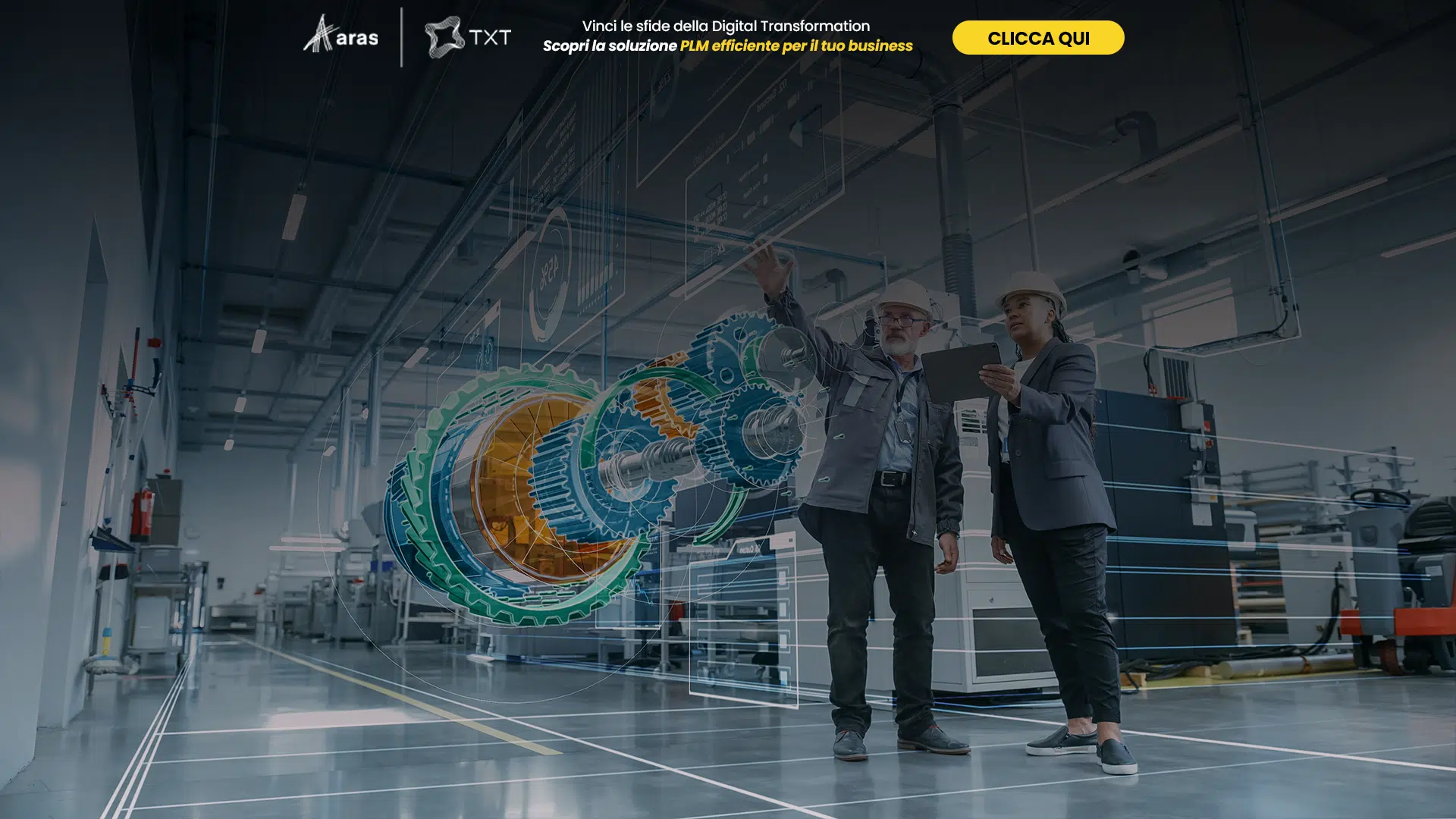




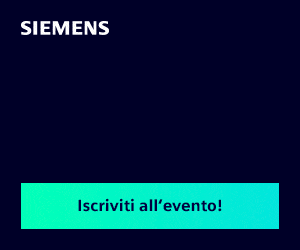













[…] tema dello Stato Innovatore e del modello di creazione del valore che pone al centro lo Stato. Del nuovo libro viene dato annuncio da autorevoli siti d’internet come Industria […]