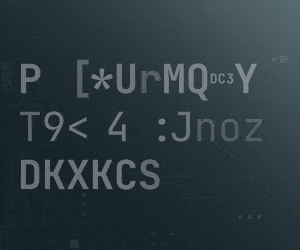di Simone Filippetti ♦ Riproduciamo il capitolo del libro “Serenissimi affari. I veneti in Borsa tra splendore e declino”, che fotografa il periodo – dal 2012 ad oggi – di declino dell’attività industriale originaria della famiglia di Ponzano Veneto. Il 2017 ha chiuso con 180 milioni di perdite, record rispetto agli 81 milioni di rosso del 2016 e ai 46 milioni del 2015. Calano anche i ricavi, chiudono i negozi e… Tutto ciò mentre i competitor Zara ed H&M vanno alla grande.
“Serenissimi affari. I veneti in Borsa tra splendore e declino” di Simone Filippetti Prefazione di Paolo Madron è edito da Marsilio
Benetton: i maglioncini si sono scoloriti
A metà degli anni ‘80, un giovane fotografo si impose agli occhi degli italiani. Era l’autore di spot che avrebbero scritto la storia della pubblicità e segnato un’epoca nell’Italia del rampantismo di Bettino Craxi e della “Milano da Bere”. Immagini scioccanti e provocatorie (per quegli anni) che fecero dell’allora sconosciuto creativo un’icona pop. E dell’azienda che reclamizzava un marchio indiscusso del Made in Italy: suore e preti che si baciavano, malati terminali di Aids, neri e bianchi che si stringevano la mano. Il fotografo era Oliviero Toscani e l’azienda Benetton, una medio piccola industria tessile di Treviso che fino a quel momento era semplicemente una delle tante Pmi dell’operoso Nordest. Grazie al fortunato sodalizio tra Toscani e Benetton, l’azienda di abbigliamento è diventata un brand mondiale. E poi c’era anche il prodotto: maglioni dai colori sgargianti che ben identificavano un’era, quegli anni ‘80 degli Yuppie e dei Paninari che divennero un simbolo in tutto il mondo. Luciano Benetton, con la sua capigliatura estrosa da pittore rinascimentale, si era inventato il marchio nel 1965, sulla scia della conterranea Stefanel che aveva aperto i battenti pochi anni prima. È stato merito suo, il più grande di quattro fratelli rimasti orfani da bambini nel Veneto dell’immediato Dopoguerra, l’aver portato la famiglia veneta a una ricchezza impensata.

Dal primo negozio, aperto a Belluno nel 1966, agli anni d’oro dei decenni ‘70 (quando Benetton arriva a esportare il 60% della produzione) e ‘80 (culminati con la quotazione in Borsa, da 210 miliardi delle allora Lire, addirittura in tre diverse piazze: Milano, Francoforte, New York). Il simbolo dell’ascesa è la fantasmagorica Villa Minelli a Ponzano Veneto, alle porte di Treviso: un’immensa casa di campagna padronale costruita nel XVI secolo, circondata da un parco, comprata nel 1969, ma inaugurata a metà anni ‘80 dopo 15 anni di restauri che l’hanno trasformata in una sorta di quartier generale museo da dove i Benetton tirano le fila dei loro affari. Luciano è l’uomo dietro al successo dei maglioncini, che arrivano a superare, negli anni d’oro, i 2 miliardi di giro d’affari e a impiegare oltre 10mila dipendenti.
L’azienda Benetton ha fatto accumulare alla famiglia quel tesoretto che ha posto le basi per la nascita dell’Impero che è oggi Edizione Holding, la cassaforte dei quattro fratelli. Se Luciano è dunque il creativo, il fratello Gilberto è invece il cervello finanziario: rimasto in ombra mentre Luciano guadagnava celebrità e le copertine di riviste e giornali, Gilberto intuisce che l’azienda deve diversificarsi e sul finire degli anni ‘90, sfruttando il patrimonio nato coi maglioncini e la stagione delle privatizzazioni dell’Iri, trasforma il gruppo in una super–holding. Che oggi spazia dagli aeroporti, alle autostrade, ai duty free.
Quelli erano, però, per la United Colors of Benetton i favolosi anni ‘80, appunto. Anni che culminarono con lo sbarco in Borsa del gruppo: era il 1986 e Piazza Affari accolse, al prezzo di 10mila lire, il Signore incontrastato della moda giovane. In quegli anni Benetton legò il suo nome ai motori: la casa di moda entra nel gran circo mediatico-sportivo della Formula 1, allora dominata dallo strapotere Ferrari-McLaren. Rileva una vecchia scuderia in disarmo, la Tolemon, e la trasforma nella Benetton Renault. Al comando c’è uno sconosciuto manager piemontese, ex geometra di Verzuolo, cittadina in provincia di Cuneo: tale Flavio Briatore. La Benetton macina successi nei Gran Premi e dalla sua scuderia esce un giovane pilota di belle speranze: Michael Schumacher destinato a diventare il campione più celebre della Formula 1. La fama sportiva è una molla pubblicitaria mostruosa per il marchio Benetton, a cui nel frattempo si è aggiunto anche Sisley, una linea più sportiva e casual che negli anni ‘80 è gettonatissima tra i giovani (tanto che la Fiat ne farà anche un fortunato modello di Panda 4×4, la Panda Sisley).

Ma nel frattempo sono passati tre decenni. Il matrimonio inossidabile Toscani–Benetton è finito e il marchio Benetton si è appannato. L’azienda ha detto addio anche al mondo dei motori, dopo aver venduto tutto, nel Duemila, al socio Renault ( pochi anni la famiglia investirà invece in una mega operazione di terreni: un latifondo da 900mila ettari in Patagonia, Argentina, per allevare pecore da lana merinos). Su un mercato che prima era una prateria dove scorazzare indisturbati, sono arrivati concorrenti agguerriti: Zara, H&M, Mango, Custo (tre spagnoli e uno svedese). L’offerta di moda giovane, con un brand a prezzi accessibili,dove Benetton era stato un pioniere, si è moltiplicata e, mentre gli altri correvano, Benetton è rimasta ferma: il vantaggio del pioniere è svanito. I veneti hanno cominciato a perdere quote a scapito degli avversari.
Nell’anno dello sbarco in Borsa, Benetton macinava fatturato e utili: aveva brindato al traguardo di quota 1000 miliardi (quasi 500 milioni di euro) di giro d’affari, generato da 3.500 negozi sparsi per il mondo, e oltre 100 miliardi (60 milioni) di profitti. Insidiata da tempo dagli altri marchi emergenti, ecco la mossa inaspettata: due anni fa, i Benetton annunciano, fulmine a ciel sereno, il ritiro della storica azienda di famiglia dalla Borsa di Milano. Un delisting, nel gergo della finanza. Benetton abbigliamento scompare dai radar del mercato per tornare negli hangar. Motivo? Una difficile, e senza garanzia di successo, ristrutturazione. Al momento dell’addio da Piazza Affari, il gruppo veneto fattura due miliardi di euro; Zara, il marchio della spagnola Inditex, cinque volte tanto e senza 30 anni di storia alle spalle. Oggi Benetton fattura quello che la concorrente iberica fa di utili. Un gigante contro un nano. Solo che dieci anni fa la situazione era invertita, con Benetton a guardare dall’alto. I giganti erano gli italiani, gli spagnoli i nani.
I Benetton hanno offerto 4,6 euro per riprendersi l’azienda. L’avevano portata in Borsa, quasi 30 anni prima a 10.000 lire (circa 5,1 euro), quando la quotarono. La famiglia ci guadagna (in senso relativo) perché si ricompra a prezzo più basso quello che avevano quotato a prezzo più alto. Una volta tanto non restano col cerino in mano i piccoli azionisti storici: per chi era entrato nel lontano 1986, l’avventura si chiude con un piccolo guadagno (il prezzo di Opa è poco sotto quello di quotazione, ma nel frattempo gli azionisti hanno incassato dividendi nel corso dei decenni). E gli utili accumulati negli anni d’oro non sono evaporati, come spesso succede in tante aziende, ma sono andati a finanziare l’espansione dell’impero, creando le altre gambe. Cos’è successo?
È successo che Benetton ha perso appeal: comprare un capo Zara oggi fa più figo di un Benetton, costa poco e puoi cambiare il tuo guardaroba ogni stagione senza dover spendere una fortuna. Il marchio italiano, invece, non riesce più ad avere la stessa presa di un tempo sui consumatori. Il solo ritornello del Made in Italy, della sartorialità e del gusto inimitabile di un capo italiano, è un karma che non basta più: la moda, specie nel segmento dove opera Benetton, che è la fascia medio–bassa, è un mercato sempre più competitivo, dove i margini si assottigliano perché le basse barriere all’ingresso e l’aggredibilità dei marchi porta i prezzi al ribasso. Una maison del lusso può permettersi di sparare prezzi folli, ma sul retail e sul mass–market, soprattutto in uno scenario di polarizzazione dei consumi, se non insegui la politica dei prezzi concorrenziali sei fuori gioco. Ma questo comporta guadagni sempre più risicati. In più con la recessione che ormai dura da anni in Italia, i consumi languono e questo non aiuta a recuperare quote di mercato. Volendo, c’è anche una lettura più “politica” della saga: i Benetton hanno costruito una fortuna sull’abbigliamento, fortuna con la quale poi hanno iniziato a far altro.

Oggi sono i padroni degli aeroporti e delle autostrade italiane (con il colosso Adr–Atlantia). Siedono nei salotti strategici dell’alta finanza: nel tempio laico Mediobanca, nelle Assicurazioni Generali, nella Pirelli di Marco Tronchetti Provera e nel Corriere della Sera, il quotidiano dove ogni imprenditore in Italia sogna di entrare. Il fatto è che questo “altro” (ossia le diversificazioni degli interessi) si è rivelato o molto più redditizio, o strategicamente più rilevante, dello storico business dell’abbigliamento. E oggi, da un punto di vista reddituale (basta vedere le performance di Borsa), il marchio Benetton è l’anello debole di tutta la galassia.
Così all’improvviso– dicevamo– nel 2012 hanno annunciato l’addio alla Borsa, dopo 26 anni di onorata presenza. Perché andarsene da Piazza affari? Per vendere? Difficile che i Benetton vendano, perché l’azienda di famiglia ha un valore affettivo enorme per la dinastia di Ponzano Veneto. Però si vede che la famiglia è anche distratta da altro. La girandola dei manager in Benetton, sei negli ultimi undici anni, è il segnale che qualcosa non va per il verso giusto e il bilancio ne è la riprova: nel 2011, ultimo bilancio pubblico, gli utili erano caduti del 30% a 70 milioni. Nel 2008 i profitti erano 155 milioni: in tre anni si sono dimezzati e ora addirittura il gruppo è in passivo. Stiamo pur sempre parlando di un marchio presente in 120 Paesi. Ma il maglione è impolverato. E se dovesse continuare questa tendenza pericolosa di continuo peggioramento, avere le spalle larghe potrebbe non bastare più. Ecco la decisione: via l’azienda dalla Borsa dove pure era sbarcata con successo. Ed era considerata una storica “Blue chip”.
Allora ha fatto bene la famiglia a decidere di togliere l’azienda dal mercato. La Borsa si nutre di aspettative e premia le aziende che mostrano di saper crescere. Ma soprattutto i mercati hanno sempre fretta: vogliono vedere risultati su basi trimestrali, una frenesia che non va d’accordo con le ristrutturazioni. Non c’erano più le condizioni a che il mercato apprezzasse l’azienda. Al momento dell’addio a Piazza Affari, il titolo era fortemente deprezzato e sottovalutato. Con meno di 700 milioni di capitalizzazione, il gruppo valeva meno dei soli immobili che possiede. Paradossi del mercato: come se il marchio valesse zero.
Fuori dalla Borsa, la famiglia ha più spazi di manovra per rilanciare l’azienda. La sfida è dura: c’è da ripensare un business e ritrovare quella spinta creativa e glamour degli anni ‘80. Oppure un partner: magari la stessa Zara o H&M? Sono passati due anni da quando la nave è rientrata in porto. Ma finora si è visto poco. E i numeri, seppur ora arrivino col contagocce al mercato, raccontano un’azienda che ha perso ancor più terreno e si sta avvitando. Nel 2012 il fatturato era sceso sotto la soglia dei 2 miliardi, a 1,8, con una caduta del 10%. La marginalità si era ulteriormente contratta: si cala ancora, a 770 milioni. Gli utili, pericolosamente vicini allo zero (24 milioni). E l’anno scorso, terribile per il Paese sprofondato ancor più in recessione, le cose non potevano certo migliorare.
Ed ecco l’inevitabile epilogo di anni di declino: Benetton è stata affossata da una perdita monstre di poco meno di 200 milioni (ma il dato non è ufficiale). I ricavi sono scesi a 1,6 miliardi, un altro–10%, per il secondo anno di fila. È il bilancio più disastroso della storia del gruppo veneto. Era successo solo una volta in quasi 40 anni di storia di finire in rosso, e allora era stato solo per un motivo straordinario. Unica notizia positiva, il debito: è stato dimezzato da 600 a 300 milioni. Al momento dell’addio dalla Borsa, il gruppo mostrava segnali di difficoltà, ma era ancora profittevole. Ora perde fatturato e soldi. Un brutto segnale.

È stata anche tentata qualche contromossa: tipo il taglio dei costi e la riduzione del personale (l’anno scorso erano stati annunciati inizialmente 450 licenziamenti, poi convertiti in contratti di solidarietà con esuberi dimezzati). Ma di fronte al crollo dei consumi di tutto il mercato, non è bastato. Ci vuole qualcosa di più drastico. Benetton sta dimezzando la sua presenza: è in uscita da 60 mercati su 120 in cui era. Ma il problema di fondo rimane l’eccessiva esposizione in Italia, il paese peggiore, oggi, per un’azienda di largo consumo. Il Belpaese pesa ancora per il 39% del giro d’affari e Benetton è di fatto un’azienda Euro–centrica: i mercati Ue, area dove l’economia arranca, rappresentano il 75% delle vendite del gruppo. A inizio 2014, ecco che circola una notizia inaspettata: sul ponte di comando approderà un nuovo manager (la famiglia aveva fatto un passo indietro già nel 2003). Si dice sia il tedesco Bruno Salzer: fama di duro, primo dirigente straniero in casa Benetton.
Potrebbe essere la persona giusta: Salzer viene da Escada e da Hugo Boss. Ha una grossa esperienza nel settore retail e abbigliamento, esperienze che i precedenti di Benetton non avevano in curriculum. Ma il nome si rivelerà una bufala. In Benetton arriva sì un nuovo amministratore delegato, ma non è Salzer. Bensì un uomo di casa Benetton, Marco Airoldi. Il 54enne manager viene dalla multinazionale della consulenza Bcg (Boston Consulting Group), ma da 20 anni segue gli interessi della famiglia (ed è stato anche in passato direttore generale di Autogrill, altra azienda della galassia Benetton). È, in ogni caso, l’ennesimo cambio di panchina, a sostituire l’AD Biagio Chiaro Lanza.
La nomina di Airoldi– e i rumors su Kaiser Bruno, forse fatti girare ad arte per bruciarlo o per sondare le reazioni del mercato– scuotono, però, anche i delicati equilibri familiari, dove tra i vari fratelli non sono mancate frizioni in passato, soprattutto tra Luciano e Gilberto. E proprio sul ruolo nel gruppo di Alessandro, il figlio di Luciano che da tempo studia da erede designato dello scettro, ma che si scontra con le diffidenze di Gilberto, da sempre favorevole al suo uomo di fiducia Gianni Mion. Dopo il delisting, le redini di Benetton erano passate nelle mani di Alessandro, figlio di Luciano, nel ruolo di dominus che assommava presidenza e alcune deleghe manageriali. Con l’arrivo di Airoldi, ma soprattutto la sua defenestrazione da presidente, sostituito proprio da quel Mion braccio destro dello zio Gilberto, il suo ruolo subisce inevitabilmente una deminutio. E vi si legge tra le righe una sorta di implicita bocciatura per Alessandro, relegato al solo ruolo di consigliere di amministrazione, ma con la compensazione di un assegno da 1,7 milioni di euro come buonuscita per l’ex incarico da presidente.
Che farà a questo punto l’eterno rampollo? Rimarrà ancora in azienda o preferirà fare un passo indietro per dedicarsi al suo primo amore, il fondo di private equity da 21 Investimenti (proprietario, tra l’altro, anche dei cinema The Space, la ex catena Warner Village). Una soluzione drastica e di rottura, per la famiglia, ci sarebbe, ma è ritenuta un’eresia in casa Benetton: vendere l’abbigliamento. Logica consiglierebbe, di fronte alla difficoltà di rilanciare l’azienda, di passare la mano (fintantochè il marchio è appetibile) e di concentrarsi sugli altri business, più profittevoli. Ma la Benetton ha un forte valore affettivo per la famiglia: soprattutto Luciano non accetterebbe mai di lasciare la sua creatura, quella su cui è stata costruita la fortuna del gruppo. Di fronte alla crisi, prevarrà la ragione o il sentimento?

Dai Panettoni di Stato a multinazionale: il caso Autogrill
Non so se vi sia mai capitata tra le mani una di quelle cartoline degli anni ‘50 o ‘60. Ritraggono l’autostrada del Sole, i ristoranti Pavesi, quelli a ponte. Fanno sorridere, perché oggi a nessuno verrebbe mai in mente di spedire una cartolina (ma nemmeno di postare un selfie sui social network) con una stazione di servizio. Eppure quei ristoranti a ponte e quelle autostrade nuove e scintillanti, erano allora il simbolo del Paese che rinasceva, l’emblema del boom economico del Dopoguerra. Le autostrade sono state il sistema venoso del corpo Italia, le arterie che facevano circolare il sangue dell’economia. Per 50 anni il Paese si è mosso, non solo fisicamente, sulle strade asfaltate. Il Pil è andato di pari passo con la motorizzazione di massa. E su quelle autostrade, quando ci si fermava con la famiglia nei primi esodi estivi dell’Italia degli anni d’oro, si mangiava divinamente.
I ristoranti Pavesi–Motta–Alemagna erano il sogno di ogni bambino degli Anni ‘50. “Panettoni di Stato”, lo sprezzante nomignolo affibbiato da economisti e giornali. Il primo bar a insegna Motta, nella galleria Vittorio Emanuele, a Milano, aveva aperto i battenti nel 1928. Poi a metà Anni ‘70 assieme ad Alemagna e Pavesi (il cui primo chiosco-bar sulla Milano-Novara era stato inaugurato nel 1947, con l’Italia ancora tra le macerie fumanti della guerra), le tre insegne confluirono nella Sme, una società finanziaria che faceva capo all’onnipotente e onnipresente IRI, il motore immobile dell’economia italiana, le famose “partecipazioni statali”.
In quegli anni l’Italia è il più sovietico dei Paesi occidentali in politica economica: la presenza dello Stato è soffocante. Il pubblico produce di tutto, dalla benzina all’elettricità, dalle automobili agli aeroplani. Arriva anche sulla tavola: lo Stato “mammone” cucina per gli Italiani anche i dolci da mangiare a Natale. Ecco i famosi, o famigerati, “Panettoni di Stato”, paradigma del più deletereo statalismo. Roba da piani quinquennali della Russia sovietica di Stalin. Oggi il nome Pavesi non esiste più. Ma continuano a esistere quei ristoranti ed esiste il “Favoloso Mondo di Autogrill”. Quello di Autogrill è il più spettacolare caso di privatizzazione riuscita e di nascita, da zero, di una multinazionale su scala mondiale. Assieme a Luxottica (altro veneto, sarà un caso?), sono probabilmente le uniche due aziende globali che l’Italia vanti (non c’è Fiat o Finmeccanica che tenga).
Oggi, è un gruppo da 4 miliardi di giro d’affari e 55mila dipendenti che spazia dall’Alaska all’Australia: non c’è un aeroporto internazionale (da Londra Heathrow a Dubai, dal JFK di New York a Kuala Lumpur) dove Autogrill non serva qualcosa da mangiare. Anche a vostra insaputa: perché magari c’è l’insegna Burger King o Costa Cafè, ma sono gli Italiani che lo gestiscono. Gli riesce così bene che dal mangiare sono passati poi anche ai duty free. Autogrill è diventata talmente grande che di una società ne hanno fatte due (Autogrill e WDF): una per i ristoranti, e una per i duty free.
Sotto il cappello del mastodontico moloch chiamato IRI, Autogrill sarebbe rimasta una bella società italiana o poco più. Oggi invece è una delle più grandi, e misconosciute, storie europee di perfetta sintesi tra pubblico e privato. La svolta epocale arriva con gli anni ‘90: l’IRI viene sciolta e le sue aziende messe in vendita (il governo Prodi deve fare cassa per risanare i conti ed entrare nell’Euro). Nel 1995 Autogrill (il copyright è della Pavesi che inventò il nome e mai scelta di un marchio fu più felice) diventa privata. E chi si fa avanti? Una famiglia veneta che fino ad allora aveva riscosso successo con dei maglioncini colorati, i Benetton. La mossa era inusuale: loro sono dei parvenu del Nordest, non fanno parte dei salotti buoni. Gilberto Benetton, la mente dietro la diversificazione degli affari di famiglia’, ha però una capacità previsionale fuori dal comune e capisce che quella è una grande occasione (oltre ai panini, dall’IRI, si comprò anche le ben più corpose Autostrade, che però non diventeranno globali come Autogrill).

L’azienda è una singolare e irripetibile miscela di creatività italiana e rigore anglosassone (molto poco italiano, invece, è l’understatement, la ritrosia a esibire i propri successi). Incroci del destino: mentre i maglioncini Benetton cominciavano a infeltrire, saliva in orbita l’astro Autogrill. Appena entrati, i Benetton fanno tre cose: quotano in Borsa, puntano a esportare il modello all’estero e managerializzare l’azienda. L’eccellenza nel cibo e una certa art de vivre sono i jolly del Paese. Eppure gli Italiani, con il loro spirito imprenditoriale molto individualista, mancano spesso di efficienza e di quella disciplina che fanno la differenza tra i capitalismo familiare e l’impresa globale. Le imprese familiari pagano lo scotto di litigi interni e dell’insofferenza verso il mercato e la gestione manageriale.
Autogrill invece è una simbiosi perfetta tra le due anime, familiare e mercatistica. I Benetton subito si aprono all’esterno, con manager estranei alla famiglia a gestire, e conla quotazione della società. Il piano industriale? Il cibo in movimento: sfamare i viaggiatori in senso lato (perché solo in autostrada? Ovunque). L’idea va di pari passo con un’altra buona mossa: lo sbarco negli Stati Uniti. Nel 1999, la Autogrill dei neopadroni Benetton compra la Hms Host, Host Marriot Services, una sorta di Autogrill americano. È lo stesso anno in cui un altro veneto, Luxottica, mette a segno un colpo, sempre in America: rileva la casa che produce i Ray Ban. Entrambi i blitz all’estero sono destinati a cambiare la storia delle due aziende.
Hms Host è un marchio storico: l’azienda è nata nel 1897, più di un secolo prima (un record e una rarità in una nazione senza storia e dove il capitalismo distrugge di continuo aziende per crearne di nuove). Si porta in dote la scintilla di un nuovo business model per i nuovi padroni italiani: il franchising di alcuni marchi famosi, come Starbucks e Pizza Hut. È l’uovo di colombo: invece di colonizzare il mondo con bar Autogrill, meglio gestire marchi famosi di cui i viaggiatori sono già clienti abituali. Ecco che Autogrill, oltre ai suo ristoranti col famosa insegna della A rossa, inizia a diventare un concessionario. Prende in affitto grandi spazi, nelle stazioni ferroviarie, nei musei, negli aeroporti, e li riempie di insegne che piacciono al pubblico.
L’uomo cui i Benetton hanno affidato le chiavi di Autogrill è Gian Mario Tondato Da Ruos, (ex rugbista, anche se dal fisico, asciutto e slanciato, non si direbbe). Schivo al limite dell’indisponente, di poche parole e molti fatti, il manager porta gli ex ristoranti Pavesi a diventare un colosso mondiale delle concessioni. Già l’anno dopo la conquista dell’America, Autogrill è un gruppo da 3 miliardi di euro di fatturato e 4300 ristoranti in 16 paesi del mondo. Ma è solo l’inizio. Arriverà a sfondare i 6 miliardi nel 2008, raddoppiando dimensioni in soli 8 anni (e nel 2011, ultimo anno del gruppo unificato prima della scissione, arriverà a 6,5 miliardi di ricavi, un record, così come per gli utili,di 139 milioni).
Autogrill è per la famiglia di Ponzano quello che United Colors of Benetton era negli anni ‘80: la gallina dalle uova d’oro. Dopo l’America, seguiranno altri due grandi acquisizioni (frutto della sua strategia): la spagnola Aldeasa, regina dei duty free in America Latina e l’inglese World Duty Free . Sulla scrivania di Tondato, racconta chi ha avuto modo di vederla, c’è una lettera scritta da Joe Biden, il vice–presidente degli Stati Uniti. Il braccio destro di Barack Obama, si complimenta per come Autogrill ha rinnovato un’area di servizio lungo l’autostrada che il secondo uomo più potente al mondo fa in auto ogni mattina per andare alla Casa Bianca. È la consacrazione di un’azienda italiana a multinazionale su scala globale.
Ma quella stessa Italia che l’ha tenuta a battesimo è oggi il problema principale per Autogrill. Una crisi senza precedenti e che non finirà a breve. Di più, un mercato autostradale, già in difficoltà, dove le gare sono anti–economiche, le stazioni di servizio ormai troppe (una ogni 25 km contro una media europea di 50 km) e si continua a far proliferare l’offerta. Un cocktail micidiale: se non si rivede l’intero sistema delle concessioni, Autogrill non avrà altra scelta che lasciare l’Italia. Lo dicono i numeri, impietosi. In nove anni il peso del mercato interno sul totale del gruppo è calato di 30 punti: nel 2003 il solo business autostradale faceva quasi la metà del margine di tutta Autogrill (40% sull’Ebitda di gruppo). L’anno scorso il peso dell’Italia è caduto al 14%: se il calo continua a questi ritmi, è matematica, tra 3 anni la redditività dell’Italia sarà un microscopico 3%. Già oggi i costi generali di tutta l’azienda (6 miliardi di fatturato nel 2012 prima della separazione) equivalgono a quanto fattura l’Italia: solo questo basterebbe per traslocare da un’altra parte.
La recessione sta lasciando a piedi gli Italiani. Il traffico sulla rete viaria a pagamento è caduto dell’11% negli ultimi due anni. Siamo tornati indietro di 12 anni. L’agognata ripresa, se mai ci sarà, toccherà in ogni caso solo marginalmente le autostrade perché ormai si va verso un mondo sempre meno autocentrico. La rivoluzione dei treni ad alta velocità sta cambiando le abitudini di trasporto e di spesa della gente. Si preferisce un treno col wi-fi dove si può chattare con gli amici in Facebook. Guidare è un piacere da Anni ‘70, quando si viaggiava a gruppi. L’auto è destinata a diventare un dinosauro per gli spostamenti a lunga percorrenza. Per ora, Autogrill ha dimezzato le aree di ristoro (21 concessioni rinnovate sulle 42 precedenti), per adeguarsi a un mondo post–crisi.
Da Villa Minelli, in quel di Ponzano, i Benetton sono corsi ai ripari, ancora una volta con una visione di lungo periodo. Dopo quasi dieci anni, Autogrill è tornata alle origini. Ossia a quella ristorazione che è nel DNA e ha scritto la storia del gruppo. Ma nel ritorno al passato, si sono gettati i semi del futuro, anche con un’Italia in declino apparentemente inarrestabile. Sono state separate le due anime del gruppo (la ristorazione e i duty free): la vecchia Autogrill è tornata a fare solo ristorazione; la “nuova” Wdf (World Duty Free) gestisce i negozi negli aeroporti ed è stata anch’essa quotata a Milano nell’autunno del 2013.
È il terzo snodo cruciale nella vita di Autogrill, da quando è stata privatizzata. Prima lo sbarco negli Stati Uniti, nel 1999 con Hms Host. Poi nel 2005, quando la società era in una posizione “scomoda”: big mondiale della ristorazione con oltre 3 miliardi di ricavi, ma con prospettive di mercato non incoraggianti. Il food&beverage aveva margini prospettici in calo, cosa che poi si è rivelata tale (peraltro amplificata dalla crisi). Da lì la diversificazione dei duty free. Le due anime, simili solo in apparenza, perché operano negli stessi spazi (aeroporti, stazioni), hanno business model diversi e soprattutto prospettive molto diverse: il duty free è il mercato che cresce a ritmi sostenuti e ha grossi margini; la ristorazione, invece, è un settore che oggi necessita di una ristrutturazione.
In Italia paga la caduta del traffico autostradale, che rappresenta ancora il grosso del mercato per Autogrill: di qui la scelta di separare i destini. Anche perché così gli stessi Benetton possono trovare un grosso partner per assicurare un altro capitolo di espansione nella storia di Autogrill. Il futuro delle due nuove società è stato tratteggiato dallo stesso Gilberto, sempre più l’eminenza grigia della famiglia: trovare un marito per entrambe le società. Già da almeno due anni i Benetton avevano in testa questo passo, ma il centauro Autogrill (metà ristoranti, metà negozi) impediva aggregazioni. Ora con due società separate e due business focalizzati si potrà trovare molto più facilmente quel partner industriale che il mercato aspetta da anni e che farebbe di Autogrill e Wdf i numeri uno al mondo nei loro rispettivi settori.
Gli occhi sono puntati a Est, ma bisogna anche rimanere nella vecchia Europa. L’Asia e i mercati emergenti sono il futuro delle concessioni e degli aeroporti, ma sono i vecchi mercati, ancora oggi quelli coi numeri più grandi. Se vuoi essere un leader oggi devi essere per forza in Europa e negli Stati Uniti, ma se vorrai essere un leader tra 10 anni, devi entrare oggi nei paesi asiatici. Per farlo i Benetton sono disposti anche a rinunciare alla proprietà. Scendere sotto il 50% di Autogrill: meglio essere piccoli azionisti di un colosso mondiale che l’azionista di maggioranza di un gruppo piccolo (che poi tanto piccolo non è). Ancora una volta, a Villa Minelli precorrono i tempi. È il futuro del capitalismo familiare.