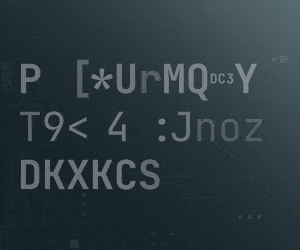di Marco de’ Francesco ♦︎ Dopo lo scontro frontale con la Cina che ha portato al bando di Huawei – anche se rientrato prudentemente – il presidente americano potrebbe preparare un’offensiva contro le quattro ruote del Vecchio Continente. Le promesse elettorali disattese e i sondaggi in calo potrebbero indurlo a questa mossa. Rilanciando la manifattura a stelle e strisce e impedendo licenziamenti. Affossare il Ttpi ridarebbe nuova linfa a un sistema economico che cresce solo nominalmente, come ci conferma l’economista Giuseppe Berta. Con le partite ancora aperte del reshoring della produzione di GM e Ford
«Metteremo una tassa del 25% su ogni auto che arriva dall’Ue», ha affermato qualche mese fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Minacce insensate, per alcuni osservatori; ma anche parole che rimbombano tra le coste dell’Atlantico proprio ora che è in corso l’offensiva americana contro il gigante cinese dei cellulari e dei tablet Huawei, che a seguito di una ordinanza presidenziale non potrà, al termine di un rinvio di tre mesi, utilizzare vitali chip Made in Usa. In realtà Trump, a suo modo, tra attacchi e ritirate, sa fare sul serio. È questo è preoccupante, perché il presidente potrebbe avere più interesse a fissare i dazi alle auto del Vecchio Continente che a non farlo. Potrebbe, in un certo senso, essere costretto dalle circostanze. Perché, alla fine, le sue promesse elettorali non sono state mantenute, e le nuove presidenziali si tengono l’anno prossimo. L’economia americana, infatti, pompata da lavori infrastrutturali straordinari, ora sta arretrando. Il grande reshoring delle multinazionali del manifatturiero, quello che avrebbe dovuto ripopolare di tute blu gli stati centrali degli Usa, non c’è stato; e anzi, nell’automotive – settore di valore simbolico nella cultura americana – sono in corso chiusure e licenziamenti in patria. Dunque Trump potrebbe, con una sola mossa, indebolire la concorrenza dell’auto tedesca, da sempre protagonista delle sue invettive; affossare definitivamente il Ttpi (l’accordo commerciale di libero scambio tra Usa e Ue) in versione tascabile, di cui si inizierà a discutere tra qualche giorno; e sfoderare un’arma politica in grado di distogliere l’opinione pubblica dagli insuccessi. Secondo la Cnbc, pare che poco dopo il minaccioso discorso pubblico in West Virginia, in un successivo incontro a Washington, Trump abbia detto al presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker che tutta la questione dei rapporti commerciali transatlantici si gioca sull’automotive. Non sorprenderebbe. In ogni caso, la partita si terrà nei prossimi mesi. Non si dovrà attendere molto per capire come andrà a finire. I dazi sulle auto sarebbero una catastrofe per l’industria e per la componentistica italiana.

L’America sta veramente crescendo?
Trump, per ora, è stato molto fortunato. Nel primo trimestre del 2019, il Pil è volato al 3,2% superando largamente le previsioni degli analisti, che ponevano l’asticella a quota 2,5%. Nel terzo trimestre dell’anno scorso si era verificata una contingenza paragonabile: una crescita del 3,5%, ampiamente migliore delle attese. Tecnicamente, l’economia americana è in forte espansione. Molto dipende dal rialzo della spesa al consumo, che incide per il 70% sull’economia: è aumentata del 4% negli ultimi tre mesi del 2018 e dell’1,2% nei primi tre mesi dell’anno in corso. In quest’ultimo periodo sono cresciuti pure gli investimenti pubblici, del 2,4%; e le esportazioni nette hanno fatto riscontrare un incremento di un punto percentuale. Accelerano anche gli acquisti aziendali, per la ricostituzione degli stock. In queste condizioni, è normale che Trump sia andato all’incasso. Secondo il presidente, è tutto merito suo: la diminuzione della tassazione corporate e le semplificazioni burocratiche introdotte dalla sua amministrazione avrebbero prodotto un’onda lunga positiva. Non è certo che sia vero. «Probabilmente, la crescita prolungata è un fenomeno indipendente da Trump», afferma Berta. E forse l’America sta frenando e non lo sa. Paul Ashworth, il capo economista di Capital Economics (società di ricerca con sede a Londra, già vincitrice del Wolfson Economics Prize), pensa che la crescita sia stata spinta dalla spesa del governo su autostrade e strade comuni. Alla Bbc ha pertanto affermato che «eliminando gli eccessi sovradimensionati del commercio netto, delle scorte e degli investimenti nelle autostrade, che saranno tutti invertiti nei prossimi trimestri, la crescita è stata solo dell’1%. In tali circostanze, continuiamo a prevedere che quest’ultima rallenterà quest’anno, costringendo la Fed a iniziare a tagliare i tassi di interesse prima della fine del 2019». Il rallentamento dell’economia potrebbe spingere Trump a prendere in considerazione misure estreme e ostili contro altri Paesi. Vediamo perché.

Le presidenziali americane mentre l’economia frena
Il 3 novembre 2020 si terranno le elezioni presidenziali americane. Se Ashworth avesse ragione, la competizione per lo scranno più importante del mondo si svolgerebbe in un contesto difficile, per Trump. Per Berta, «alla fine, manca un anno e qualche mese. Il ciclo positivo va avanti da molto tempo; ma razionalmente, quanto può durare?». Tutti sanno che l’economia di un Paese può calare ad intervalli di tempo più o meno costanti. E poi ci sono altri segnali di cui tenere conto. Secondo l’Ocse, il commercio mondiale sta rallentando, e anche il Pil mondiale è a rischio. Paradossalmente, sono le stesse politiche di Trump a favorire il declino. Secondo l’economista capo dell’Ocse Laurence Boone «la fragile economia globale viene destabilizzata dalle tensioni commerciali. La crescita si sta stabilizzando ma l’economia è debole e ci sono rischi molto seri all’orizzonte: i governi devono collaborare per garantire un ritorno più forte». Per l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, tuttavia, il calo degli Usa dovrebbe attestarsi a quota 2,3%. Sempre in campo positivo, dunque; e il calo, forse, non sarebbe tanto grave da spingere il presidente Usa a fare sul serio. Ma c’è dell’altro.
Perché la partita riguarda l’automotive
La partita, in realtà, si gioca sull’automotive. Tutta la politica di Trump ruota attorno al concetto di “America First”: strategicamente, un ritorno all’unilateralismo. L’America decide da sola ciò che è bene e ciò che non conviene portare avanti. La nazione si riscopre sovrana, e si pone in prima linea come attore politico. Secondo i sostenitori di questa teoria, è la crescita del Pil che guida il commercio, e non il contrario. Si è sempre ad un passo dal protezionismo. L’economista e politologo francese Jacques Sapir inquadra questo fenomeno nel concetto di de-mondializzazione. Non stupisce che Trump, anche prima della sua elezione, abbia lavorato per affossare il Ttip, l’accordo commerciale di libero scambio tra Unione Europea e Usa – patto che forse sarà riesumato in versione minimalista dopo le elezioni europee. Da un punto di vista industriale, invece, America First significa la fine della delocalizzazione. Per Trump, la produzione delle grandi multinazionali americane deve rientrare entro i confini nazionali, portando lavoro a quegli stati interni degli Usa che nell’ultimo decennio hanno conosciuto tempi difficili. Non c’è solo la California, in America. Solo che le cose non stanno andando per questo verso. La società americana di consulenza strategica At Kearney pubblica uno studio annuale in materia, e il Reshoring Index di luglio scorso indica che l’anno prima «le importazioni di manufatti negli Stati Uniti dai 14 maggiori partner commerciali a basso costo in Asia sono aumentate di ben 55 miliardi di dollari, e cioè dell’8% – il più grande incremento in un anno dopo la ripresa economica del 2011». Tre motivi su tanti: il risparmio delle multinazionali è un fatto certo; le aziende non intendono abbandonare in anticipo poderosi investimenti all’estero; infine, la manodopera qualificata è carente. Alla fine, conti alla mano, sono 16 le multinazionali americane che hanno annunciato il reshoring della produzione in patria, ma solo per numeri limitati, inconsistenti rispetto alle cifre nazionali. Tra queste, due carmaker: Ford e General Motors. La prima ha affermato di voler cancellare l’espansione di uno stabilimento messicano per rafforzare quello di Flat Rock, nel Michigan. Un insieme di movimenti interni al colosso mondiale porterebbe anche in Indiana, Illinois, Ohio e New York complessivi 4.200 posti di lavoro. Per la seconda, c’è un piano per aumentare la forza lavoro di Michigan, New York, Tennesse e Texas 12.988 lavoratori, e 2.700 posti sarebbero recuperati in Kentucky spostando la produzione dalla Cina e dal Messico. Solo che qualcosa non ha funzionato. Il reshoring dei lavoratori dell’automotive, bandiera della campagna elettorale di Trump, non si verificherà. Nel senso che a prescindere da spostamenti interni, i lavoratori americani di comparto sono destinati a diminuire. Il colosso di Detroit ha annunciato pochi giorni fa il taglio del 20% dei manager e del 10% dei lavoratori, circa 7mila persone, tra licenziamenti e uscite concordate. Gli esuberi colpiranno soprattutto gli Stati Uniti. General Motors licenzierà 4mila dipendenti in Nord America, per finanziare auto elettriche e veicoli autonomi. Ciò è parte di un piano di razionalizzazione che prevede la chiusura di 5 stabilimenti e il licenziamento di 14.700 lavoratori. Quando Trump lo ha saputo è andato su tutte le furie. «Sono molto deluso da General Motors e dal loro Ceo, Mary Barra, per aver chiuso gli stabilimenti in Ohio, Michigan e Maryland – ha scritto sui social – Niente sta per essere chiuso in Messico e in Cina. Gli Stati Uniti hanno salvato General Motors, e questo è il grazie che otteniamo!». La società ha un po’ frenato quanto a chiusure; tuttavia, già lo stabilimento di assemblaggio dell’Ohio ha chiuso i battenti, e quello del Maryland sta seguendo la stessa sorte. Per la politica di Trump è uno smacco notevole.

Trump ha già colpito
Non sempre Trump ha minacciato e basta. La vicenda Huawei ha prodotto per ora solo grande ma momentanea instabilità dei mercati; ma le sanzioni economiche e l’embargo petrolifero in Iran hanno bloccato le aziende europee in quel Paese. E poi, i dazi sull’alluminio (10%) e sull’acciaio (25%), prima previsti per Cina, Giappone e poi estesi a Europa, Canada e Messico. In realtà, il provvedimento, del valore di 30 miliardi, ha colpito soprattutto gli ultimi due Paesi, dai quali provengono oltre la metà delle importazioni di questi metalli. «Per l’Italia – afferma Berta – i dazi hanno arrecato danni molto limitati. È vero che produciamo acciai speciali, con il Gruppo Arvedi; e che a Taranto è operativa la nuova Ilva di ArcelorMittal; ma complessivamente le nostre esportazioni verso gli Usa valgono poco, circa 650 milioni di dollari». Poca roba. Più colpita la Germania, che esporta acciaio in Usa per 1,4 miliardi. Ma anche qui, niente rispetto al valore dei beni tedeschi che attraversano l’oceano: circa lo 0,1%.
I dazi alle auto europee sarebbero una catastrofe per l’industria italiana
Più seria sarebbe la questione delle auto. Anzitutto, in via diretta. «Nello stabilimento di Melfi (Potenza) – afferma Berta – Fca produce Jeep Renegade dirette per lo più al mercato americano, e in gran numero: tra le 120mila e le 130mila unità all’anno. Costituiscono una quota davvero importante della nostra produzione nazionale che si attesta attorno al mezzo milione di automobili». Più di un quinto della auto realizzate nel Belpaese finirebbe sotto scacco, con evidenti contraccolpi commerciali e occupazionali. A Melfi lavorano 8mila dipendenti, di cui 4mila dedicati al montaggio degli autoveicoli. Peraltro, circa 1.800 di loro sono giovani entrati di recente. Bisogna poi considerare i 3.300 lavoratori delle aziende fornitrici, e gli 800 delle imprese di servizi. In totale, il sistema Fca a Melfi dà lavoro a 12.100 persone. Va inoltre considerato che Fca realizza gli utili quasi esclusivamente negli Stati Uniti: il mercato europeo è stagnante, e la presenza di Fca in Asia è limitata. Ma al di là della produzione diretta, il guaio si estenderebbe alla componentistica che, con multinazionali del calibro di Magneti Marelli, Sogefi, Brembo, Trw e Skf in testa, vale 46,5 miliardi, e cioè il 3% del Pil. Nel 2018 i componentisti hanno subito una flessione del 9,2%, in Italia, legata al calo tendenziale del 12,3% della produzione di auto. È un periodo di transizione, piuttosto difficile, per le quattro ruote. Ci sono di mezzo il declino del diesel, l’incertezza sull’elettrico e tante altre ragioni (sul punto, si consiglia la lettura di questo articolo); e anche la componentistica soffre. Quest’ultimo è un comparto vitale, la spina dorsale della manifattura italiana. «Se mai le nuove tariffe colpissero le auto tedesche – termina Berta – per noi sarebbe un guaio grosso, perché queste contengono una quantità considerevole di pezzi italiani. La barriera a Daimler, Volkswagen, Bmw e Porsche sarebbe quasi immediatamente uno stop alla nostra componentistica».