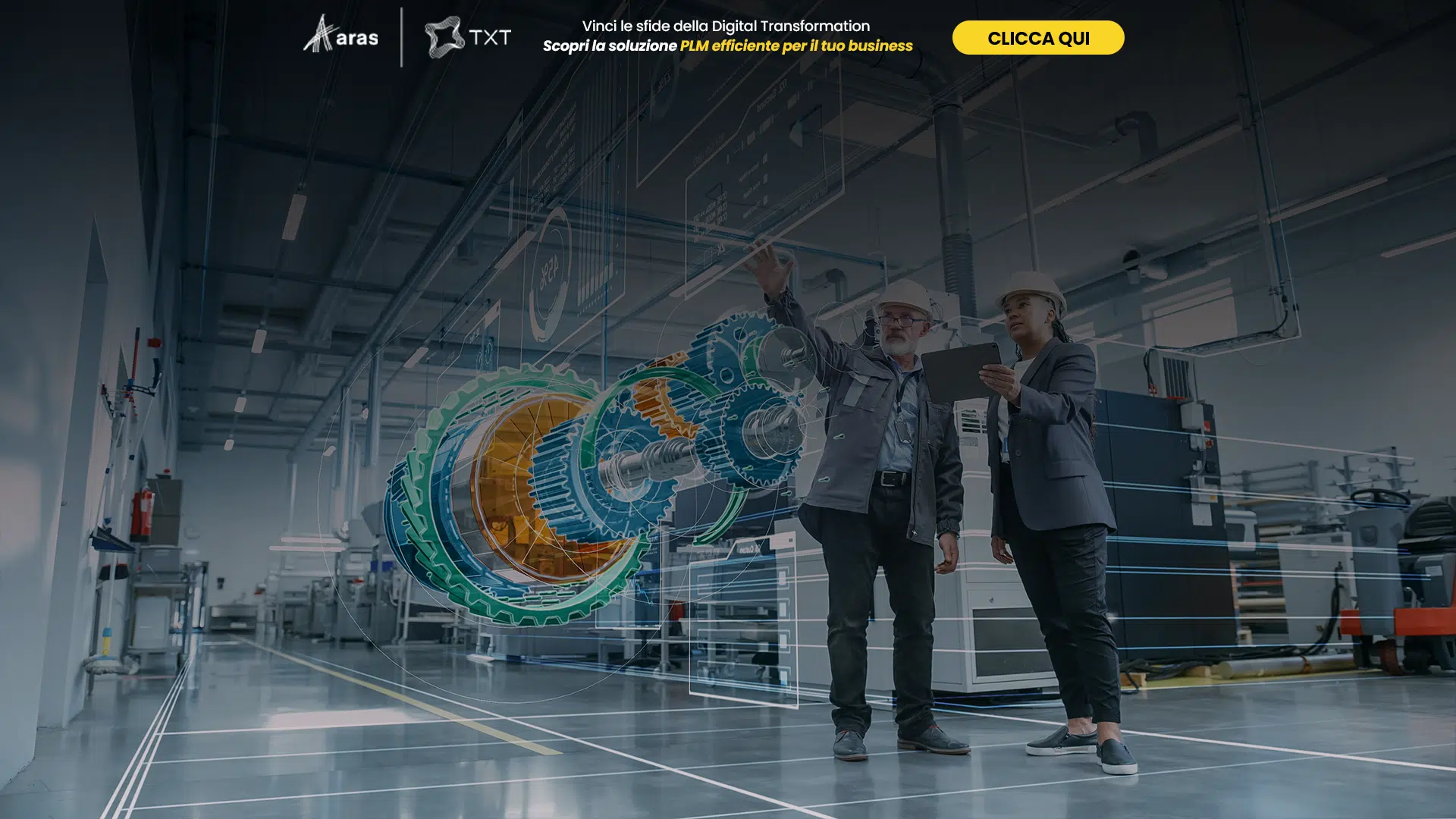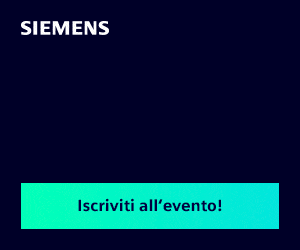di Marco de’ Francesco ♦ La cessione dello storico marchio ai cinesi di Haier fa riflettere sulle responsabilità della classe dirigente economica e sul nostro destino. Parlano Maurizio Castro, Marco Fortis, Luca Beltrametti e Fulvio Coltorti
Con la cessione di Candy al colosso cinese Haier, il Bianco italiano ammaina per sempre il tricolore. L’epopea di uno dei comparti vitali per il Boom economico – si pensi a Zanussi, Rex, Ignis, Indesit – termina una volta per tutte e, al di là della singola vicenda, ci induce a riflettere sul carattere del capitalismo italiano nel suo complesso. Sì, perché ci sono almeno tre (pesanti) rilievi che si possono legittimamente muovere a una parte della classe imprenditoriale nostrana. Anzitutto, quello di non essere stata in grado di pensare in grande, e quindi di non aver provveduto alla creazione di gruppi con dimensioni tali da scoraggiare la campagna di acquisti straniera. Si è preferito rifugiarsi nella nicchia, per evitare la concorrenza. In secondo luogo, l’errore strategico di non puntare sulla qualità, e quindi sul design e sulla tecnologia: gli industriali si sono giocati la carta della riduzione dei costi di produzione. E ciò in un contesto in cui c’è sempre un Paese più povero, lì dove produrre costa meno. Infine, di aver ceduto alla tentazione di lasciare la gestione dell’azienda a figli e nipoti: la grande visione non si trasmette per via genetica, e la famiglia del fondatore o tiene tutto o vende tutto, senza soluzioni intermedie. Ora, il Paese paga il conto, con gli interessi, di queste scelte sbagliate. Ne abbiamo parlato con un esperto di comparto, Maurizio Castro, e con tre docenti in materie economiche, Marco Fortis, Luca Beltrametti e Fulvio Coltorti.

Si chiude l’epopea del Bianco italiano
Lo strano caso di un’azienda che aveva fatto le mosse giuste, quanto a internazionalizzazione, e che si preparava al salto tecnologico. Invece la famiglia proprietaria ha venduto, segnando l’ultimo atto dell’epopea del Bianco in Italia. Il tricolore è stato ammainato in via definitiva.
Secondo l’ex senior executive vice-president del settore componenti a livello mondo di Electrolux nonché ex direttore scientifico del Master della Business school Cuoa Maurizio Castro «era un po’ di tempo che i cinesi di Haier cercavano un’opportunità in Europa, e l’hanno trovata nel Paese più qualificato, lì dove c’è una grande esperienza di settore. Il marchio, “Candy”, è un po’ appannato, ma può senz’altro essere rivitalizzato. Tutto sommato, un’operazione interessante per i cinesi. Quanto a noi, l’evento non è banale: si chiude il cerchio, l’epopea del Bianco “italiano”. Non che la questione Candy pesi più di tanto, ma è l’ultimo atto, che ha sempre un significato. I giochi si sono fatti prima, con Zanussi, Rex, Ignis, Indesit e altri giganti; ora però il tricolore è stato ammainato in via definitiva».

La cessione ai cinesi
L’operazione è questa: la famiglia Fumagalli ha ceduto il 100% dell’azienda, 4mila dipendenti, valutata 629 milioni di euro e con ricavi pari a 1,14 miliardi e buoni risultati negli anni recenti, al colosso cinese Haier, una multinazionale con base a Quingdao e quotato ad Hong Kong, che ha altre dimensioni: è il maggior gruppo al mondo per la produzione di elettrodomestici, con un fatturato che ha raggiunto la soglia dei 37 miliardi di dollari e una quota di mercato pari al 14,3%. Sottratto il debito, gli azionisti incasseranno 475 milioni di euro. In realtà la sorpresa è per gli operatori di settore e per i giornalisti: l’operazione era stata definita l’estate scorsa. È stata portata a termine qualche giorno fa, e segue di pochi giorni un’ipotesi di accordo di Candy con i sindacati, che prevede lo stop al licenziamento di 200 esuberi in cambio di cassa integrazione e riduzione dello stipendio.
L’intesa contempla peraltro un aumento della produzione a Brugherio (MonzaBrianza): il numero annuo di lavatrici realizzate passerà da 350mila a mezzo milione. Ma negli anni, all’aumento della produzione è corrisposta la costante riduzione del personale; e anche la contrazione dei marchi. Da una parte Candy ha intrapreso la strada della globalizzazione, dall’altra ha ceduto brand preziosi come Bessel, Donora, Zerowatt. In un’intervista al quotidiano “Il Giorno”, il delegato sindacale della Fiom, Michele Gallina, 34 anni passati in fabbrica, l’ha messa così: «Sembra una legge: i padri costruiscono, i figli espandono, i nipoti lasciano».
Un po’ di storia
Candy era stata fondata a Monza nel 1945 da Niso Fumagalli e dai suoi figli Enzo, Eden e Peppino con il nome di “Officine Meccaniche Eden Fumagalli”; la prima lavatrice fu presentata alla fiera di Milano del 1946, quando l’azienda cambiò il nome in Candy. Già dal 1955 l’azienda aveva compreso quanto fosse importante l’espansione all’estero: aprì, nella seconda metà degli anni Cinquanta, filiali in Francia e in Germania. Nel 1958 realizzò la prima lavabiancheria completamente automatizzata. Negli anni Sessanta inizia la produzione di lavastoviglie. Il design dei prodotti è curato da star a livello globale come Giorgetto Giugiaro, Mario Bellini, Marco Zanuso. Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande espansione, con l’acquisto di marchi importanti come Hoover European Appliance Group; cambiando il nome in Candy Hoover, l’azienda arriva, nel 2002, ad esportare in 111 Paesi. Nel 2006 l’azienda di Brugherio compra la cinese Jinling, terzo produttore del Paese di lavatrici ad asse verticale; l’anno dopo, la turca Doruk con il marchio Süsler; nello stesso anno, acquista i diritti esclusivi sui marchi finlandesi Helkama e Grepa; nel 2013, il gruppo fa propria la britannica Baumatic. Attualmente l’azienda opera – con 47 filiali diffuse in tanti Paesi – con i marchi globali Candy e Hoover e con i marchi nazionali Vyatka, Otsein, Iberna, Jinling, Rosières, Süsler, Gasfire e Baumatic.
Se la vendita ai cinesi di Haier ha sorpreso, è perché le mosse degli ultimi anni sembravano dirette ad un percorso autonomo dell’azienda italiana, che sembrava capace di muoversi a livello globale e che mostrava attenzione verso la tecnologia. Infatti l’anno scorso Candy aveva siglato una partnership con i cinesi di Meiling: in pratica, la Jinling di Candy produrrà lavatrici esclusivamente per la newco Meiling Candy Group, che è al 60% cinese e al 40% italiana. Un affare da 4 milioni di lavatrici in tre anni. C’è anche da ricordare che per finanziare l’innovazione tecnologica – il forno watch and touch con webcam interna, gli elettrodomestici connessi con wi-fi – l’azienda aveva effettuato un aumento di capitale di 70 milioni. Tutte cose di cui si occuperanno i cinesi di Haier.
Va detto che ci sono ragionevoli speranze che, da ora in poi, le cose non si mettano poi così male per i dipendenti italiani. Finora i grandi gruppi cinesi quando sono sbarcati in Italia e in Europa hanno sempre condotto politiche espansive, e incrementato le assunzioni. Come ha scritto Dario Di Vico sul “Corriere della Sera“ , è fortemente probabile che «faranno di Brugherio l’avamposto per rafforzarsi in Europa». Inoltre, hanno tutto l’interesse a proseguire la strategia condotta dall’azienda finora, quella finalizzata a rafforzare la leadership nel seguento più profittevole e a maggior tasso di sviluppo: gli elettrodomestici interconnessi.
L’incapacità di sostenere la propria grandezza
Il Bianco nazionale è stato sconfitto perché non è stato in grado di mantenere e sviluppare adeguati livelli dimensionali: le aziende italiane sono diventate prede ideali per i grandi gruppi globalizzati.
C’è da chiedersi, dunque, perché il Bianco in Italia sia stato sconfitto? «Si è verificato una specie di contrappasso – afferma Castro -: quello di chi non è in grado di mantenere la propria grandezza. Negli anni Sessanta e Settanta l’industria italiana di comparto aveva assunto un così importante rilievo perché era stata in grado di dar vita alla “grande industria”. Non è un gioco di parole: la classe imprenditoriale italiana ha iniziato a considerare la grandezza come un fardello, e così è stata sconfitta soprattutto dal punto di vista valoriale. Non è stata capace di generare gruppi e poli di dimensioni adeguate, tramite le fusioni e altro. Così, ora paghiamo il conto con gli interessi». Però la filiera resta in Italia. «Certo, ma bisogna smetterla di pensare alle multinazionali come ad un concentrato di razionalità: finché le cose vanno bene, le operazioni di acquisto risultano sempre win-win; ma quando vanno male la musica cambia e ci possono essere delle conseguenze per il territorio». Haier è però un gruppo strutturato. «Senz’altro, e immagino che i primi anni di Candy cinese saranno buoni e vissuti con entusiasmo. Poi, chi lo sa».
Un’occasione persa già negli anni ottanta
L’opportunità di creare un colosso nazionale del Bianco, in grado di difendere il tricolore, è sfumata già trent’anni fa, per questioni di politica industriale tipicamente italiane.
Ma non si poteva far niente per aiutare il Bianco? «L’italianità – afferma Castro – andava salvata nella prima metà degli anni Ottanta, quando si è consentito ad un piccolo gruppo svedese, Electrolux, di acquistare il controllo della Zanussi: bisogna ricordare che l’azienda di Pordenone era il maggior produttore europeo di elettrodomestici, avendo assorbito Zoppas, Castor, Triplex, Becchi. Se è finita in mani scandinave è perché Gianni Agnelli, il patron della Fiat che si era impegnato a ricapitalizzare la Zanussi per un 15%, oppose il veto all’offerta di Carlo De Benedetti; poi si fece avanti Merloni, ma senza troppa convinzione. Così, per Agnelli fu facile sostenere l’ingresso della famiglia Wallemberg. Poi, con la crisi di Electrolux, la famiglia di Vittorio Merloni (la Indesit è ancora il secondo produttore europeo di elettrodomestici per quota di mercato, ma nel 2014 è stata venduta agli americani di Whirlpool) ebbe una seconda possibilità, ma non se ne fece niente; e venne meno l’opportunità di creare un polo italiano dell’elettrodomestico, che avrebbe svolto una funzione di diga rispetto a interferenze straniere».

Le colpe della classe imprenditoriale italiana, storie di conigli e mammut. Castro
Non ha saputo pensare in grande, e le ultime generazioni hanno, a differenza dei padri fondatori, cercato di evitare la competizione dei mercati rifugiandosi nella nicchia, lì dove la concorrenza non è ancora arrivata. La politica, poi, non ha sostenuto il ruolo centrale del Bianco per la nostra economia.
In fondo, pensa Castro, è colpa degli industriali italiani. «Si è creduto poco ad un settore ciclico – afferma – che va sempre nella direzione del mercato, senza essere mai in controtendenza. Le grandi aziende italiane, che un tempo c’erano, avrebbero dovuto porsi in grado di competere a livello globale, con strategie di posizionamento non banali. Come si è detto, in questo settore devi possedere dimensioni adeguate, perché la marginalità è strettamente legata alla capacità di razionalizzazione dei costi e di realizzazione degli investimenti, su grandi numeri. È un po’ come con l’automotive: ci sono barriere molto imponenti in ingresso, tanto che di newcomer non se ne vedono. E l’Italia, come si è detto, non ha più saputo esprimere l’energia necessaria per operazioni di questo genere.»
«Era poi necessario il supporto della politica nazionale, che c’è in ogni Paese tranne il nostro: non è che i sudcoreani di Hyundai siano soli. Si doveva sostenere il ruolo centrale del Bianco per l’industria nostrana. Un’idea che venne a Pierluigi Bersani, ma era troppo tardi». E ora? «Siamo sempre più piccoli. Presidiamo nicchie, ma di sole nicchie non si vive. Queste sono come le brioche di Maria Antonietta: per campare, serve il pane, che per noi era la chimica, la moda, la siderurgia, la grande distribuzione e il Bianco. Ora è tutto straniero». E perché ciò è accaduto?
«Perché la competizione vera, lo scontro campale, è nei mercati. La battaglia si verifica quando i grandi si trovano in concorrenza. Invece, la nostra classe imprenditoriale ha scelto la nicchia perché, come dicono gli Americani, è il rabbit, il coniglio che è in anticipo rispetto al mercato, e di conseguenza evita la competizione. Nella nicchia, in un certo senso, si vive grazie a rendite di posizione, quelle derivante dallo stare lontani dalla mischia. Lo scontro, dicono gli Americani, è tra mammut. Ecco, noi abbiamo scelto di essere rabbit – perché siamo diventati un po’ imbelli». E anche perché, si potrebbe aggiungere, molti dei grandi e medi capitalisti (ma per fortuna non tutti) hanno preferito tesaurizzare e diversificare invece che investire.

Le colpe della classe imprenditoriale italiana: bassi costi di produzione vs maggiore qualità. Coltorti
Invece di puntare sulla qualità, e quindi sul design e sulla tecnologia, gli industriali si sono giocati la carta della riduzione dei costi di produzione. In un contesto in cui c’è sempre un Paese più povero, lì dove produrre costa meno.
Secondo Fulvio Coltorti, docente di Storia Economica all’ Università Cattolica di Milano «alcuni studi hanno verificato che quando una grande azienda straniera acquista una più piccola italiana, in genere questo comporta dei vantaggi, perché la seconda inizia ad operare in vista di orizzonti internazionali che prima non riusciva a scorgere. Ciò non accade necessariamente; e ciò che succede di solito. E non significa che l’apertura a mondi globali non si sarebbe verificata se l’impresa italiana non fosse stata comprata. Vuol dire che quando l’azienda straniera compra, lo fa per dare a quella nostrana delle chance. L’aspetto negativo è che i centri decisionali non sono più nel Belpaese, e quindi, ad esempio, no sono gli italiani a decidere dove investire. E poi, anche se la filiera resta qui, il valore aggiunto è in capo a chi la guida».
A questa considerazione andrebbe aggiunto che gli utili non vanno più in Italia, ma nel Paese dove ha sede il compratore. Con il Bianco come funziona? «Il problema del Bianco è sempre stato un problema di qualità», risponde Coltorti. «Considerata la concorrenza dei Paesi dove il costo del lavoro è minore, bisognava fare come la Germania, e investire sul contenuto del prodotto e cioè, ad esempio, sul design o sulla tecnologia. In Germania il costo del lavoro è più alto che in Italia, ma i loro prodotti, per esempio nell’automotive, sono al top, e quindi la maggior spesa è scaricata su beni che costano di più. Se i costi di produzione aumentano, i beni devono costare di più. Nel Bianco, invece, si è sempre puntato su una qualità standard, mentre la clientela chiedeva beni con prestazioni maggiori». In definitiva è “colpa” «degli industriali italiani, che non hanno puntato all’aumento di valore dei prodotti, ma ad abbassare i costi della produzione. Per questo erano tutti contenti, con il Jobs-Act. Eppure non mancano esempi positivi: si pensi alla Smeg, che offre prodotti con design e prestazioni superiori. Ma, in genere, siamo rimasti al palo, quanto a qualità».
Le colpe della classe imprenditoriale italiana: ovvero… un problema di famiglia. Beltrametti
Uno dei grandi handicap alla crescita del Paese è la gestione delle imprese familiari, affidata a membri della famiglia fondatrice. E quest’ultima o tiene tutto o vende tutto, senza soluzioni intermedie.
Secondo Luca Beltrametti, docente di politica economica all’Università di Genova, «l’aver perso l’intero comparto del Bianco è di per sé un fatto negativo. Da una parte, è sempre possibile il trasferimento di produzione all’estero, dall’altra il valore aggiunto non è più in Italia. Perché è accaduto? Parlando in via generale, e quindi senza riferimenti al caso Candy, uno dei grandi problemi del nostro Paese è che le tante imprese medie di origine familiare sono guidate da componenti della famiglia, e non da manager, come accade invece in Germania. Ciò rende il passaggio generazionale particolarmente drammatico. Non ci sono opzioni intermedie: la famiglia, in Italia, o tiene tutto o vende tutto. Non conosce altri metodi per incrementare il capitale, anche cedendo una parte delle quote. Questo meccanismo si è rivelato uno dei più grande handicap alla crescita del Paese».
C’è un altro motivo: «Negli anni Settanta e Ottanta – afferma Beltrametti – i grandi guru dell’economia sostenevano che quello dell’automotive fosse un settore maturo, la cui sopravvivenza non poteva che essere collegata al trasferimento all’estero della produzione. È stato un errore catastrofico. Lo si è pensato anche per il Bianco, e anche questo è un errore. Bisognerebbe invece immaginare un grande apporto tecnologico nel prodotto, che faccia la differenza sul mercato. Ora, con la digitalizzazione, ci sono i presupposti perché ciò accada». Secondo Castro, «è probabile che Samsung, che è un gigante della tecnologia ma che produce Bianco, sarà la prima grande impresa a innestare grandi contenuti di innovazione nel prodotto, che attualmente non si distingue da quello anni Cinquanta. Ciò cambierà completamente la battaglia sul mercato, e il mercato stesso».

Game over. La partita del Bianco è chiusa in Italia. La perdita di sistema è avvenuta anni fa. Fortis
Secondo Marco Fortis, docente di economia industriale all’ Università Cattolica di Milano, «in effetti il Bianco è un settore maturo, a basso valore aggiunto, dove i player asiatici operano in una logica di riduzione dei costi e di bassa marginalità; era abbastanza normale che il baricentro della produzione si spostasse in altri Paesi. Non è vero, però, che siamo solo comprati; per esempio, il gruppo Nocivelli (poi Epta; ndr) non solo ha sviluppato marchi interni, ma ha anche fatto acquisti all’estero. In tutti i casi, quanto al Bianco, il problema non è il finale, quanto il “durante”, ciò che è accaduto in questi anni e che ha portato a questa situazione. Sono cambiate le aree produttive e il costo del lavoro è diventato uno spartiacque. Si è giunti al capolinea, in Italia. È andata così. Ogni tanto emergono idee curiose, tipo quelle che riguardano l’intervento della Cassa depositi e prestiti per riprenderci qualcosa: il problema è che non c’è più il Made in Italy, e che la perdita di sistema non si è verificata giorni fa, ma anni fa. Non è come nella meccanica, dove le nostre imprese fanno shopping all’estero. Questa del Bianco sembra a tutti gli effetti una partita chiusa».