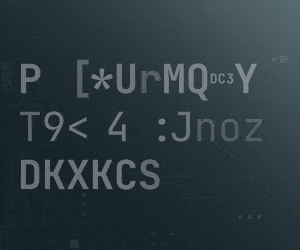di Piero Macrì ♦︎ Intelligenza artificiale e machine learning non rivoluzioneranno la produzione. E cobot e macchine autonome non sostituiranno l’uomo in fabbrica. I luoghi comuni sul futuro digitale rivisti dall’occhio critico di Severino Meregalli
Guardare al digitale con un pensiero laterale per non farsi trascinare dall’hype tecnologico e riuscire ad avere una visione d’insieme del mercato senza essere alla mercé del diktat mediatico. In questo articolo presentiamo 10 riflessioni su alcuni degli argomenti più discussi in tema di tecnologia ed economia digitale con l’intento di demistificare alcune verità assolute su industria 4.0, automazione, robotica, produttività, competenze, intelligenza artificiale, mercato del lavoro e innovazione d’impresa. L’articolo è il frutto di una lunga conversazione con Severino Meregalli, (professore associato della School of Management di Sda Bocconi e direttore scientifico del Devo Lab), che ringraziamo per i contenuti, intellettualmente brillanti e molto utili a chi fa impresa.

1. Conta il digitale, ma anche il ferro. L’esempio di Tesla
Il prodotto del nuovo millennio ha bisogno del digitale ma a patto che vi sia una reale integrazione industriale. Un esempio è Tesla. La società di consulenza Munro & Associates specializzata nel settore automotive, dopo aver ispezionato pezzo per pezzo la Model 3, ha svelato punti deboli e di forza della vettura elettrica. Ebbene, partendo dalla strategia costruttiva, la società è rimasta particolarmente colpita dalla qualità costruttiva generale, alquanto pessima. Il messaggio implicito è che Tesla avrebbe potuto approfittare di qualche dritta della “vecchia scuola”. Dove la Model 3 invece eccelle è in tutto ciò che riguarda le componenti elettroniche, di gestione della batteria per esempio: è come se arrivassero da un altro pianeta. Tutto ciò che attiene la meccanica sembra invece che arrivi da una specie di asilo infantile dell’ingegneria. Tesla, quindi, come esempio di genio e sregolatezza: innovativa sulla parte digitale; indietro anni luce sulla meccanica. L’esempio di Tesla dimostra che per integrare con successo tecnologie digitali in un prodotto non deve esistere soltanto un pensiero digitale, ma industriale. Insomma, non è sufficiente iniettare dosi da cavallo di farmaci high-tech digitali per far sì che le organizzazioni, di qualunque ordine e grado – grandi, medie e piccole – possano affrontare indenni le sfide del nuovo mercato. Sappiamo, dall’esperienza acquisita in passato, che l’introduzione di tecnologia non determina di per sé un salto quantico e un aumento altrettanto proporzionale delle performance se questa non viene associata a una visione di lungo termine. Tenete sempre a mente che l’informatica è preziosa, dà velocità, ma se non si dispone di un modello di business solido, può essere pericolosa perché può accelerare il fallimento.
2. L’intelligenza artificiale è sopravvalutata
Nel Rapporto pubblicato dal National Bureau of Economic Research – “Artificial Intelligence and the Modern Productivity Paradox: A Clash of Expectations and Statistics” – si offre un interessante contributo alla comprensione delle potenzialità dell’intelligenza artificiale. Gli autori – professori del Mit di Boston e dell’Università di Chicago – si dichiarano convinti che l’Ai possa offrire una innovazione sostanziale e un possibile incremento di produttività, a patto che si creino e si affermino veri e propri ecosistemi in grado di imprimere un’accelerazione e diffusione sistemica delle nuove tecnologie. Perché si possa pienamente affermare un nuovo corso industriale – la cui spinta propulsiva derivi dall’intelligenza artificiale in ogni sua possibile declinazione, a livello di prodotti, processi e servizi – serve e servirà tempo. I progressi sono incoraggianti, ma da qui a pensare che nel giro di pochi anni l’economia del pianeta possa re-ingegnerizzare il propria Dna attorno ai microsomi del Machine Learning andando a stabilire nuovi indici di produttività e nuova occupazione, ce ne passa. Tra le varie declinazioni dell’intelligenza artificiale spicca il Machine Learning, ovvero la capacità di un sistema – attraverso algoritmi ereditati da logiche neurali – di apprendere e sviluppare autonomamente in modo incrementale una propria super intelligenza. Tuttavia, le espressioni reali di questi potenziali sviluppi sono ancora confinate all’interno di progetti e soluzioni elitarie. Siamo ben lontani dall’aver traguardato una diffusione tale da permettere un salto significativo in termini di produttività. È sbagliato pensare che l’intelligenza artificiale sia la panacea per l’efficienza assoluta. Non è la polverina magica che crea la nuova impresa digitale. A questo riguardo sono interessanti le opinioni del professore del Mit, Daron Acemoğlu, autore del libro “Why the Nations Fail”. Acemoğlu sostiene che l’intelligenza artificiale sia largamente fraintesa e, soprattutto, che la sua importanza sia enormemente esagerata. Il rischio che, sia nel presente che nel breve e medio periodo, tolga posti di lavoro è di gran lunga inferiore a quanto si va dicendo. Certo, alcuni processi e alcuni lavori saranno sostituiti dall’implicito potenziale tecnologico che la tecnologia porta con sé, ma è un aspetto ancora del tutto marginale e relativo solo a una piccola porzione del mondo del lavoro. Oggi ci stiamo confrontando con “Narrow Ai” tecnologia limitata a specifici utilizzi e non è in grado di competere e sostituire capacità umane. La famosa “Broad Ai”, ovvero la declinazione di un’intelligence di larga portata che andrebbe a diffondersi estensivamente sul mercato del lavoro, al momento non è altro che pura immaginazione. L’Ai – sottolinea Acemoğlu – è una delle tante tecnologie di automazione. Con questo il professore non nega ripercussioni sul mercato del lavoro: l’introduzione di automazione, oggi Ai, potrà tradursi – così come sempre è stato – in una riduzione dei salari per alcune categorie di lavoratori e rendere non più indispensabili alcune mansioni.

3. Il computing sarà sempre più autonomo e capace di decidere
Il denominatore comune del possibile scenario che va emergendo è di una sempre più forte autonomia funzionale di tutte le componenti abilitanti nuovi processi. La crescente diffusione di sensori e microchip applicati a cose e, verosimilmente e in forma progressiva, a persone, implica infatti un automatismo dei processi decisionali, a tutti i livelli. In estrema sintesi significa dare velocità al business, offrendo non solo insight su processi e attività una volta inimmaginabili, ma introducendo capacità attuative all’interno dell’infrastruttura Ict. E se è vero che i robot prenderanno sempre più spazio nella fabbrica è altrettanto vero che l’intelligenza delle infrastrutture Ict in divenire produrrà un non meno significativo livello di produttività. Complessivamente, la nuova automazione generata dall’affermazione dell’IoT sarà responsabile di una straordinaria accelerazione nella perdita di posti di lavoro in settori labour intensive, in primis quello manifatturiero. Un fenomeno che, verosimilmente, non sarà dello stesso ordine di grandezza di quello determinato dal passaggio dall’agricoltura all’industria della prima metà del novecento, ma che darà luogo a una profonda trasformazione del mercato del lavoro. La relativa perdita occupazionale sarà però accompagnata da un altrettanto significativo aumento di posti di lavoro in altri ambiti, in primis quello legato alla sanità e salute della persona. Di fronte a questi possibili scenari l’industria è obbligata a un riallineamento in termini di organizzazione, tecnologie, processi e competenze. Servirà trovare un nuovo equilibrio, che a sua volta sarà messo in discussione dalla prossima disruption.
4. Nell’industria manifatturiera italiana l’Ict non è mai stata un fattore strategico. Ma non sarà più così
Siamo testimoni di un paradosso: lo straordinario progresso tecnologico degli ultimi dieci anni non è correlato a un’altrettanta straordinaria crescita della produttività. Come affermato in passato da Robert Solow, premio Nobel per l’economia nel 1987: “You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics”. Per il momento vale la pena riflettere su un altro dato, per quanto paradossale, ma sostanzialmente in linea con le affermazioni di Solow. Guardando alla storia dell’industria manifatturiera italiana ci si accorge infatti di una costante: ovvero che l’information technology non è stato un fattore strategico, se non per eccezioni. Molte aziende con sistemi informativi datati hanno avuto successo e hanno espresso nel tempo un’ottima competitività, anche su mercati globali. Ma non potrà più essere così. In una prospettiva digitale e d’impresa interconnessa le cose cambiano. Non si possono più avere macchine di ultima generazione nello shop floor e computer polverosi nel back office poiché il denominatore comune diventa l’Industrial IoT ovvero capacità di avere flussi di dati che, opportunamente trattati, generano informazioni pertinenti “across the enterprise”, a supporto della produzione, della supply chain e delle applicazioni critiche d’impresa». In questo percorso obbligato partiamo svantaggiati rispetto ad altri Paesi? No. La manifattura italiana non soffre di un gap digitale poiché i macchinari acquisiti portano a bordo, embedded, intelligenza IoT. Ergo, e semplificando, un qualunque investimento diventa di per sé un investimento 4.0. La quota digitale presente nelle fabbriche italiane è elevata. Può non apparire ma esiste. Quello che latita è la capacità di trasformare le potenzialità in risultati. Si tratta, come dire, di dar fuoco alle polveri. E poi, attenzione: considerato il ciclo di vita delle macchine industriali – anche superiore ai vent’anni – esiste la possibilità del retrofitting, che consente di dare intelligenza a quelle macchine che ne sono ancora prive. In buona sostanza, un processo di trasformazione digitale è largamente attuabile, anche in presenza di un parco macchine non di ultimissima generazione. Non sarà il metodo più elegante, ma dopo tutto conta il fine non il mezzo.
5. Incentivi? Non sono indispensabili. Ma servono investimenti strategici
Si dice che le aziende più performanti siano quelle che hanno innovato di più. È un’affermazione un po’ retorica. Non potrebbe essere diversamente. È sbagliato pensare che in assenza di incentivi fiscali le aziende non investano. Si parla tanto del Piano Industria 4.0, ma a ben vedere la capacità di resistenza e di innovazione espressa dalle imprese, in particolare nel settore manifatturiero, non sono tanto correlate agli incentivi fiscali: i risultati e le performance nascono essenzialmente dalla capacità imprenditoriale e da una visione strategica coerente con l’evoluzione dei mercati così come dalla consapevolezza che una qualsiasi attività deve necessariamente essere sostenuta da una continua ricerca e sviluppo nella tecnologia. Gli imprenditori sono contenti che ci siano gli incentivi, ma gran parte degli investimenti li avrebbero comunque fatti poiché da loro dipende il futuro dell’impresa. Piuttosto, si vorrebbe che in un paese come l’Italia, dove le risorse sono scarse, gli stessi soldi fossero spesi per migliorare e rendere più efficiente l’intero ecosistema. L’infrastruttura di trasporto innanzitutto così come tutto ciò che facilita la vita di un’impresa. Ridurre il tasso di burocrazia, per esempio, poiché l’Italia si distingue per la complessità di leggi e normative che regolano la vita delle aziende. Esistono, come afferma più di un economista, troppe regole e per cambiarle si tende ad aggiungerne di nuove e quindi ad aumentare il carico burocratico. Per vincere, per essere competitivi, per creare nuove opportunità di lavoro, la tecnologia non è di per sé sufficiente. Il successo dipende dal cambiamento organizzativo e da maggiore efficienza sistemica, che deve esistere sia a livello d’impresa sia a livello nazionale.
6. Fare di più con meno? Se continuiamo con questo slogan siamo spacciati. Il futuro è l’outcome economy
Da un punto di vista teorico l’assunzione del cocktail della nuova frontiera tecnologica può significare più produttività ovvero fare di più con meno. Non solo, maggiore produttività significa capacità di creare e servizi a costi più bassi e, di conseguenza, la possibilità di generare un potenziale aumento della domanda. Tuttavia, la determinazione di una dinamica positiva dei mercati è in larga misura dipendente da fattori economici: l’introduzione di automazione e l’incremento di produttività non sono di per sé sufficienti a innescare un circolo virtuoso dei mercati: in assenza di una domanda la capacità delle aziende di acquisire un aumento di produttività equivale a un esercizio a somma zero. È però fuorviante continuare a ragionare esclusivamente in termini di produttività. Fare di più con meno è un pensiero legato a una concezione della produzione del secolo scorso. Se andiamo avanti con questo slogan siamo spacciati. Il problema è creare valore. Pensiamo al Made in Italy. Applicare tecnologie digitali in una filiera è teoricamente positivo ma può tradursi in un disvalore se non si riesce a preservarne le unicità. La prospettiva è ragionare secondo quanto viene oggi sottinteso dall’outcome economy ovvero l’ennesima possibile discontinuità di mercato che implica il passaggio dalla vendita di prodotti e servizi tradizionali a quella basata sulla reale misurabilità dei vantaggi conseguenti la fruizione e utilizzo degli stessi da parte di utenti (scenario b2b) e consumatori (scenario b2c). Al centro il prodotto connesso e digitalizzato. La futuribile tendenza è direttamente proporzionale all’affermazione di tecnologie digitali e dell’IoT ovvero dalla progressiva sensorizzazione dei prodotti, dalla capacità di soddisfare analisi real time del dato e dalla disponibilità di infrastrutture edge e cloud.

7. La ciclicità dei mercati è imprevedibile. Servono imprese resilienti
Disruption significa essere preparati ad affrontare le inevitabili discontinuità. La globalizzazione ha permesso l’affermazione di un mercato in grado di esprimere una domanda espansiva. La libera circolazione delle merci ha significato poter sfruttare opportunità di domanda interna e internazionale. Ora, con la stretta sugli accordi commerciali, si sta profilando una sempre più ampia incertezza. Le imprese devono avere una buona dose di resilienza poiché la crescita non sarà mai lineare. È come voler controllare il tempo: impossibile. La dinamica dei mercati può essere ben rappresentata da una frequenza sinusoidale, un costante alternarsi di picchi e flessioni. Chi riuscirà a navigare indenne tra alte e basse maree sarà in grado di assicurare la propria sostenibilità; chi al contrario si dimostrerà incapace di governare la propria flotta in mare aperto è destinato al naufragio. Appare sempre più evidente che è la propensione al cambiamento e la flessibilità a rendere sostenibile la propria competitività. Un qualcosa, il cambiamento, che non si può improvvisare, che non può essere una via di fuga o un semplice escamotage, ma che deve essere inteso come parte integrante della cultura aziendale ovvero diventare un “present continuos tense”. Questo significa comprendere obiettivi e finalità ed agire di conseguenza poiché le tecnologie devono contribuire a gestire al meglio l’alternanza dei picchi e delle flessioni dei mercati.
8. Non solo data scientist servono high skill worker su tutta la piramide del lavoro
In un mondo ipertecnologico le società devono essere capaci di formare “high skill worker” con competenze modulate, verso il basso e verso l’alto. C’è spazio per tutti. Mai però avere la presunzione di essere arrivati. Si deve sempre tenere presente che il cambiamento è l’unica certezza. Una delle sostanziali differenze rispetto al passato è data infatti da una maggiore volatilità delle competenze, che nascono, si sviluppano e muoiono con cicli molto più brevi rispetto al passato. «Abbiamo bisogno di una forza lavoro che sia maggiormente addestrata alle esigenze di industria 4.0. Non ci si deve limitare al solo riallineamento di competenze degli operatori, che devono oggi essere in grado di interagire con interfacce uomo-macchina evolute. Se mai serve preparare queste persone a interagire e dare a queste machine istruzioni complesse e non soltanto schiacciare dei bottoni. Si confonde l’essere capaci di utilizzare un’interfaccia, che non è più analogica e che inibisce l’attività fisica, con la vera formazione. Occorre capire cosa sta succedendo e perché.

9. Percorso digitale fai da te? No grazie
Tutte le competenze hanno un costo per essere sviluppate soprattutto perché si deve ormai ragionare secondo un approccio “world class”. Il problema è che le conoscenze distintive più ricercate sono difficilmente reperibili all’interno delle aziende. Servono impulsi di competenza sia nelle pmi sia nelle grandi aziende ma si deve essere consapevoli che gran parte di questi impulsi, i più preziosi, non possono che venire dal mondo dell’offerta e dal mondo professionale. Il disegno di una nuova linea di produzione non può essere fatto in casa. Serve una contaminazione dall’esterno. Una volta bastava la sola intelligenza aziendale a integrare le tecnologie abilitanti la competitività aziendale. Ora non più. È bene confrontarsi con esperienze e valori che risiedono all’esterno del perimetro d’impresa. Il paradosso è che questo è più facile che avvenga in una pmi piuttosto che in una grande azienda . In quest’ultima si ha spesso la presunzione di avere la massa critica per sviluppare queste capacità. L’esperienza insegna, purtroppo, che i centri competenza interni possono diventare centri di incompetenza. E qui si apre il grande tema della fiducia, del trust. Con chi condividere un percorso di trasformazione? Chi si pone questa domanda è già sulla giusta strada.
10. Non saranno i nativi digitali a salvare le imprese
Una visione sensazionalistica e poco matura delle tecnologie digitali comporta molti rischi come quello di sopravvalutare gli effetti di queste innovazioni e di affidarsi a luoghi comuni poco utili per trasformare in valore l’enorme potenziale tecnologico a disposizione delle imprese. È del tutto sbagliato pensare che l’avvento dei cosiddetti nativi digitali in ruoli direzionali porti automaticamente ad un aumento della capacità delle imprese nell’adozione e nello sfruttamento delle tecnologie digitali. Sarebbe come dire che chi padroneggia con naturalezza la guida di un veicolo ha le caratteristiche necessarie per essere un manager di successo nel settore dell’automotive. Eppure, questa convinzione si è diffusa rapidamente con la conseguente banalizzazione dell’importanza delle conoscenze tecnologiche e manageriali necessarie per comprendere e sfruttare la cosiddetta rivoluzione digitale. Se invece per “nativi digitali” intendiamo indicare giovani manager con una profonda conoscenza delle tecnologie digitali e dei loro effetti sul business allora stiamo descrivendo un profilo professionale di cui si sente sicuramente la mancanza. La nuova impresa in grado di confrontarsi con le sfide del digitale non emergerà grazie a un salvifico afflusso di nativi digitali nelle organizzazioni d’impresa né tanto meno dal contributo spot di qualche talento di passaggio.